 Bruno Bolla vanta un ampio bagaglio culturale che attinge da un nugolo di generi musicali agli antipodi del mainstream. La sua prima passione è quella per il cosiddetto “afro”, un intricato filone-contenitore di materiale trasversale determinante per gli orientamenti stilistici futuri. Negli anni Novanta infatti si lascia conquistare dall’acid jazz che, analogamente a quanto avvenuto con l’afro, è simile ad un groviglio multisfaccettato di generi che collega il mondo degli strumenti acustici con quello degli elettronici. Tra i suoi interessi c’è anche la house, che interseca ecletticamente con disco, funk e soul. Attivo pure in ambito discografico ma prediligendo più intenti compilativi che produttivi, Bolla è oggi uno dei veterani italiani della consolle, con una passione quarantennale alle spalle che continua ad animarlo senza sosta.
Bruno Bolla vanta un ampio bagaglio culturale che attinge da un nugolo di generi musicali agli antipodi del mainstream. La sua prima passione è quella per il cosiddetto “afro”, un intricato filone-contenitore di materiale trasversale determinante per gli orientamenti stilistici futuri. Negli anni Novanta infatti si lascia conquistare dall’acid jazz che, analogamente a quanto avvenuto con l’afro, è simile ad un groviglio multisfaccettato di generi che collega il mondo degli strumenti acustici con quello degli elettronici. Tra i suoi interessi c’è anche la house, che interseca ecletticamente con disco, funk e soul. Attivo pure in ambito discografico ma prediligendo più intenti compilativi che produttivi, Bolla è oggi uno dei veterani italiani della consolle, con una passione quarantennale alle spalle che continua ad animarlo senza sosta.
Nell’intervista rilasciata qualche tempo fa ad Emanuele Treppiedi per Zero, racconti di aver frequentato i primi negozi di dischi d’importazione in Italia, come Goody Music di Jacques Fred Petrus o Il Bazaar di Pippo di Pippo Landro, ai quali abbiamo dedicato ampio spazio in Decadance Extra. Cosa significava, quarant’anni fa, comprare musica che conoscevano in pochi?
Alla fine degli anni Settanta i negozi in cui acquistare musica specializzata erano una marea. Ce n’erano moltissimi non legati alla dance music, dove trovavo jazz, funk, fusion, afro, brazil, new wave ed elettronica in genere. In realtà molti di questi erano librerie in cui vi era un reparto appositamente dedicato ai dischi. Se ripenso a cosa ho comprato in quei posti, peraltro a prezzi bassissimi, mi vengono i brividi! Adesso molti di quei dischi sono introvabili o disponibili, su internet, a prezzi incredibilmente alti. Nei primi anni Ottanta però, seppur i negozi fossero tantissimi, a suonare quelle cose a Milano eravamo davvero quattro gatti. Io compravo ovunque, da Pacha a Supporti Fonografici, da Mariposa a Tape Art, da Buscemi a Bonaparte Dischi passando per Stradivarius, Messaggerie Musicali, Iperdue in zona Brera e i magazzini sparsi in zona Mecenate dove era quasi impossibile accedere per un privato, senza dimenticare i minuscoli negozietti sparsi per la città con un ben di Dio incredibile.
Chi, come te, voleva intraprendere la carriera da DJ, era messo di fronte al bivio di scegliere se passare le musiche da hit parade o dedicarsi a cose più ricercate e quindi difficilmente proponibili al grande pubblico? Tale scelta implicava anche delle conseguenze a livello lavorativo?
In quegli anni, pur facendo il DJ ancora a livello hobbistico, desideravo prendere le distanze dai generi musicali mainstream che andavano per la maggiore a Milano. La musica commerciale più in voga era la disco, quella in stile Claudio Cecchetto che comunque era un “signor DJ”, tra i pochi che stimavo veramente in quel periodo in città. Io però stavo crescendo con altri gusti puntando ad un genere che non era popolarissimo nei club milanesi ma che palpitava nei cuori di molti “alternativi” e vantava migliaia di seguaci disposti a spostarsi persino in altre regioni, come il Veneto o l’Emilia Romagna, pur di seguirlo. Mi riferisco al filone “afro” nato in club come la Baia Degli Angeli, meno facile ed immediato rispetto alla disco proposta dai DJ importanti di Milano come Tony Carrasco, il menzionato Cecchetto o Moreno della discoteca Astrolabio (quest’ultimo, a mio avviso, una spanna sopra tutti), che erano la risposta italiana a David Mancuso, Nicky Siano o Larry Levan, e posso garantire che fossero tecnicamente persino migliori rispetto ai colleghi d’oltreoceano. Per il genere che piaceva a me però i modelli erano Moz-Art, Beppe Loda, Daniele Baldelli, TBC ed altri contraddistinti da scelte musicali coraggiose, cura nella selezione ed una certa apertura verso tutto quello che era meno scontato e scarsamente appetibile per il mondo radiofonico. Non certamente a caso questi DJ sono tuttora in attività e molti di loro stanno vivendo una seconda giovinezza, con un giusto tributo anche all’estero perché in quel periodo erano ben pochi i DJ in Europa a proporre musica simile. Nel Regno Unito, ad esempio, i DJ passavano bella musica ma il mixaggio non apparteneva alla loro cultura, davano priorità alla selezione più che alla tecnica. Io seguivo quindi gli input dei miei riferimenti ma avevo già una personalità e cercavo di metterci del mio. A causa della poca popolarità del genere però non fu facile approdare a consolle importanti e a livello lavorativo si faceva una grande fatica. C’era qualche party privato o serate tematiche nei circoli, che non erano molti e spesso legati troppo a livello politico. In linea di massima non si dedicava tempo ed attenzione al divertimento e al disimpegno. La discoteca poi non era ben vista, almeno tra le mie conoscenze. Io ero fortunato, mi capitava di finire dentro il locale trendy per qualche festa a tema organizzata da qualcuno che prediligeva i suoni strani ed affascinanti, e a tal proposito ricordo un bellissimo party dedicato ai fumetti che sonorizzai con musica afro/elettronica nel 1984. Il club si chiamava Primadonna e si trovava nei pressi di Via Monte Napoleone. Fu una festa fantastica, la gente ballava tutto ciò che mettevo e a Milano mi sembrò davvero un miracolo.

Bruno Bolla in una foto risalente al 1987
Tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta l’arrivo di strumenti elettronici dal costo contenuto, in primis quelli della Roland, decretano la nascita di nuovi generi come new wave e synth pop che offuscano la popolarità del funk, del soul e specialmente della disco. Da appassionato proprio di questi generi, come vivesti quella fase?
Vissi quel periodo con poca sofferenza perché curiosità ed eclettismo mi avevano già portato a mischiare quei filoni. Alcune cose synth pop, ad esempio, si sovrapponevano bene ai suoni disco funk. Comunque iniziai a comprare molta meno disco, ma seppur si stessero manifestando i primi segni di stanchezza, artisti provenienti da Stati Uniti e Gran Bretagna continuarono a partorire grandi cose, lasciando emergere le prime contaminazioni.
Nel corso degli anni non hai mai fatto mistero della tua stima e devozione per il cosiddetto movimento “afro”, nato e sviluppato in locali come Baia degli Angeli, Cosmic, Ciak, Typhoon o Melody Mecca. Secondo te quelle sovrapposizioni stilistiche effettuate con maestria da DJ preparati tanto in tecnica quanto in cultura e background, sono state storicamente impattanti come house e techno? L’impressione è che sulla mappa mondiale della dance music culture, l’afro, inteso sia come stile che come attitudine, non sia finito forse proprio per la scarsa considerazione degli italiani.
Come hai giustamente detto, il cosiddetto “afro” era più un’attitudine che un genere, un po’ come avvenne per l’acid jazz negli anni Novanta. Effettivamente quello che si vedeva nei club italiani di allora non esisteva in molti locali europei. Eravamo avanti ma non siamo stati capaci di capitalizzare le nostre stesse intuizioni e questo, per noi italiani, purtroppo è un classico. La risposta a quanto mi chiedi l’abbiamo davanti agli occhi: i giovani adesso comprano ristampe e sono alla costante ricerca degli originali. Importanti label indipendenti di tutto il mondo dedicano gran parte dei loro budget per ristampare autentiche pietre miliari di questa “dance music” non proprio convenzionale, facendo scoprire cose di quel periodo rimaste nell’ombra per decenni. Le ristampe afro, disco, funk e boogie oggi vanno a ruba, ma l’impatto rispetto ad house e techno è stato minore, e credo non potesse essere diversamente. House e techno rientrano infatti nella categoria dei generi musicali ed hanno già una vita molto lunga, pluritrentennale. La loro collocazione è radicalmente legata alle evoluzioni tecnologiche al contrario dell’afro, un’attitudine ed un mix tra post punk, electro, industrial, new age, ethno, new wave, dark, funk, disco, prog rock…

Un flyer del Matmos (1991-1992)
Nei primi anni Novanta sei tra i DJ che animano una delle one night più note di Milano, Matmos, ideata dal compianto Marco Tini. Potresti descriverla?
Matmos fu, molto semplicemente, la prima one night milanese completamente dedicata all’house music. L’esordio fu al Beau Geste, tra 1990 e 1991, con tre DJ resident, Luca Colombo, Giorgio Matè e Ralf. Tra 1991 e 1992 la location si spostò al Linea, in Piazza San Babila. Ralf si alternava come guest a Ricky Montanari e Flavio Vecchi portando il suono della Riviera, e a Colombo e Matè si aggiunsero Jackmaster Pez ed Andrea Gemolotto. Io entrai come guest fisso, una volta al mese, esibendomi dopo aver suonato al Lizard dove ero resident. Insomma, ogni trenta giorni avevo una “doppia” in città, una vera rarità perché erano entrambe serate e non after hour, ma la cosa non dava fastidio a nessuno. Ricordo che si facevano serate sporadiche pure il giovedì, negli ultimi anni al Tainos in zona Piazza della Repubblica, dove si testavano anche giovani talenti in una specie di laboratorio, affiancati alternativamente da uno di noi resident. A Marco Tini piaceva cambiare quindi prenotò il Carisma di Piazzale Cordusio per la stagione 1992-1993 e lo inaugurò con un progetto fighissimo basato su due sale. In una c’erano i resident Luca Colombo, Jackmaster Pez e Giorgio Matè che suonavano house, nell’altra invece io e Steve Dub, ai tempi resident del Plastic con Nicola Guiducci, che invece proponevamo sonorità black, acid jazz, r&b ed hip hop. Visto il mio eclettismo, apprezzato senza riserve da Tini, mi chiesero di curare anche il set di chiusura in decompressione della sala house, col mio downbeat cosmico strumentale. Insomma, un progetto in cui risiedeva tutta la visione di Marco Tini relativa ad un locale perfetto e definitivo. Purtroppo Marco ci lasciò ancor prima di iniziare in seguito ad un tragico incidente stradale, e portare avanti il Matmos senza di lui non funzionò. Con Isa e Lucia, le sue assistenti che presero in mano le redini del progetto, approdammo al Lizard dove, come annunciato prima, ero resident col mio gruppo Les Fous De L’Île. Si trattava di un club fashion dove suonavo cose underground pur avendo a che fare con un pubblico modaiolo ed internazionale. Il sogno di Marco Tini, far convivere l’anima raver ed underground del Matmos col pubblico del jet set, più “fighetto” ma ricettivo, si realizzò ma purtroppo senza di lui. Mi emoziono ancora quando ci penso. Tempo fa un nostro vecchio cliente ed ormai grande amico mi disse: «Bruno, hai fatto una bellissima carriera ma con Marco accanto avresti raggiunto molti più obiettivi, ti adorava e credeva in te come pochi altri». Credo avesse ragione.
C’era una ragione dietro il nome Matmos, adottato in seguito dal duo americano di San Francisco formato da Drew Daniel e Martin Schmidt?
Il Matmos nostrano non ha davvero nulla da spartire con la band da te menzionata. Marco prese quel nome dal film “Barbarella” del 1968, con Jane Fonda come protagonista. Nella pellicola lei è una viaggiatrice dello spazio che ha tante avventure, fantastiche ed erotiche, e il Matmos è una sostanza energetica di cui vivevano gli abitanti di Sogo, la città dove approda. Sul perché Tini abbia optato per questo nome esistono varie versioni, ormai diventate quasi delle leggende. Per quanto ricordo io, c’erano connessioni con l’uso di sostanze stupefacenti e con la perversione, ma essendo un fanatico di quel film ed amandolo visceralmente, è probabile che la ragione si debba ricercare altrove. La serata incarnava in toto la sua visione cinematica e sotto questo aspetto Marco Tini fu un assoluto precursore di ciò che si fa oggi in molte one night.

Le rubriche musicali curate da Bruno Bolla sui magazine di settore
Nel 1996 inizi a scrivere per DiscoiD, freepress di informazione discografica particolarmente noto tra gli addetti ai lavori. La tua rubrica rimasta in vita per ben dieci anni, Eclectic Jazz, sembra raccogliere l’eredità sia dell’Hot From The Box curato qualche tempo prima sulle stesse pagine da Philippe Renault Jr., sia di Jazzy Vibes di cui ti occupavi personalmente nel 1994 su Trend Discotec e Tutto Discoteca. Eclectic Jazz bazzicava nei territori acid jazz, rare grooves, r&b, easy listening e jazz house/soul, con qualche incursione nel drum n bass e nel breakbeat. Come nacque la collaborazione con quella testata ideata da Vincenzo Viceversa (intervistato qui) e guidata da Gianni Zuffa del Discopiù di Rimini?
Effettivamente una rubrica simile esisteva già ed era curata da Philippe, con cui ho condiviso tantissime consolle ed è tuttora tra i miei amici più cari. Lui era molto impegnato sia come DJ che come imprenditore e quindi non riusciva più a seguire tutto come avrebbe voluto. Credo fu proprio lui a suggerire il mio nome a Gianni Zuffa, che tra l’altro conoscevo già perché ero cliente del suo negozio. È stato straordinario collaborare con DiscoiD e con tutti coloro che, come me, curavano le rubriche fisse. Senza presunzione, posso ammettere che fosse una guida sincera, appassionata ed imparziale, come poche altre in Italia. Un fantastico contributo di non professionisti, perché a quanto ricordo non c’erano giornalisti o aspiranti tali ad interessarsi a quelle musiche, che diede vita ad un magazine altamente professionale, costruito con pochi mezzi ma tanto entusiasmo. Ricevo tuttora attestati di stima per il mio lavoro e di questi tempi fa veramente piacere.
Come ti tenevi aggiornato negli anni Novanta? Oltre a frequentare i negozi di dischi, leggevi riviste specializzate?
Avevo dei giornali di riferimento ma quasi tutti stranieri, da Straight No Chaser a Blues & Soul e Wire. In Italia invece mi piaceva Blow Up e non disdegnavo Il Mucchio.
Ritieni che la stampa italiana relativa alla dance elettronica abbia educato il pubblico o gran parte delle riviste, come alcuni sostengono, erano riempite con recensioni accomodanti ed interviste simili a panegirici?
Entriamo in un argomento piuttosto delicato. Anche io, qualche volta, sono stato criticato per il lavoro su DiscoiD, accusato di parlare maggiormente di una certa etichetta o di un certo artista. A differenza di altri però non mi occupavo di un solo genere e in poche righe dovevo selezionare materiale eterogeneo, house, funk, jazz, broken beat, afro, trip hop, breakbeat, e non era facile. Da parte mia c’era molta ricerca ma nel contempo tentavo di avere un occhio di riguardo per i prodotti di “casa nostra” che le label mi mandavano in formato promozionale. La stampa italiana che si occupava di dance elettronica e in generale di musica mi è sempre sembrata discretamente imparziale, a parte qualche giornale in voga negli anni Novanta che puntava più al gossip e metteva l’aspetto musicale in secondo piano. In quel caso figuravano interviste “a comando” con l’intervistato che dettava le domande, sullo sfondo di celebrazioni gratuite a nastro che si sprecavano. Operazioni sostanzialmente commerciali basate sul triste scambio del dare-avere, che non hanno fatto bene al movimento abbassando terribilmente il livello. Ora credo ci sia più equilibro anche se purtroppo mi capita ancora di imbattermi in qualche intervista di quel tipo. Su internet però scrive pure gente molto più attenta ed appassionata, e questo dovrebbe onorare chi opera oggi.
Programmi radiofonici (vari su Italia Network, il tuo Dancefloor Jazz su Rai Radio 2 seguito da Cool Dance su Radio Montecarlo), programmi televisivi (Match Music, Crazy Dance, TSD, Videomusic ed altri minori diffusi in syndication), riviste: in passato era possibile percorrere tante strade con obiettivi di divulgazione, oggi invece pare che quei canali siano propensi a tutto fuorché dare voce a movimenti subculturali. Internet, che in teoria potrebbe condurre a riscontri ancora più forti, non sembra generare fidelizzazione o comunque un interesse pari a quello che avevano i giovani di qualche decennio fa. Possibile che a quasi vent’anni dal Duemila, data ideale di accesso al futuro, i vecchi mass media abbiano deciso di non puntare più su contenuti didattici preferendo l’intrattenimento leggero e molto spesso privo di alcuno spessore culturale? Perché avviene ciò?
Perché la musica non è più un motivo dominante. Le cose sono profondamente cambiate, i media se ne fregano della cultura musicale e cercano soluzioni facili ed immediate. Un vero peccato. Ormai se si cercano contenuti culturali relativi ad argomenti di nicchia, è necessario fiondarsi su internet o al massimo sui canali tematici televisivi, anche se lì ho visto più cose brutte del resto. I vecchi media sono oppressi dalla necessità di fare audience, non che prima non lo fossero ma ora chi rischia a parlare di argomenti che interessano a pochi? Vuoi sentire musica di un certo spessore? Vai sul web e lascia perdere le stazioni radiofoniche che non hanno più voglia, coraggio e competenze per investire sulla qualità. Il loro lavoro è mettere in rotazione venti brani, spesso pessimi. A questo punto, per me, possono diventare tutte radio di informazione, sul modello Radio 24. Fa eccezione, con buoni risultati, la Rai, forte del canone, dove c’è ancora voglia di far sentire musica seria, di raccontare una storia con calma e senza fretta. Spero possa durare. Sentire programmi liberi, senza significativi paletti editoriali come i miei Dancefloor Jazz e Cool Dance da te citati prima, ma anche come B Side di Alessio Bertallot o i mixati di Italia Network, è diventata pura utopia. Mi viene sempre in mente l’affermazione di uno che le radio private le aveva iniziate e alla grande, il compianto Leonardo Re Cecconi alias Leopardo, un genio assoluto. Nei primi anni Duemila, quando si iniziò a sentire aria di smobilitazione per i programmi radiofonici specializzati, mi disse: «Le radio private italiane, e quindi anche i network, sono sempre state fatte da tanti mediocri e pochi bravi». Mai come oggi quel concetto risulta veritiero. Leopardo stava anticipando ciò che sarebbe successo. Io, che in fondo nelle radio ho lavorato poco, solo cinque anni circa, ed essendo più un DJ da club, rimasi particolarmente colpito da quelle parole. Per quanto concerne la televisione e gli altri canali, l’analisi è molto più semplice: nei primi anni Novanta c’era un fermento incredibile intorno alla house music, risultò quasi logico creare televisioni e programmi dedicati, ma si trattò solo di un fenomeno passeggero. Io non ho mai creduto sino in fondo a quella vampata d’interesse, infatti declinai qualche proposta che sembrava interessante. Non mi rappresentava, non serviva e soprattutto non mi sentivo adatto. È un po’ come quello che è avvenuto ai club. Chi investe ancora in questo settore? Oggi non esiste più neanche un terzo delle discoteche che c’erano in Italia nel 1995. A fine anni Novanta è iniziato il declino ed è cambiato il sistema. Rimane internet ma, come dici tu, a dispetto del suo enorme potenziale non possiede la stessa forza di allora perché le nuove generazioni non hanno lo stesso interesse e rivolgono la loro attenzione altrove. Inoltre non c’è un fenomeno musicale dirompente come lo è stata l’house music. La trap? Non credo affatto. Assistiamo ad un calo vistoso dell’attenzione da parte dei giovani per la musica e le sue storie, ma anche per il clubbing. Questo argomento mi ha convinto a creare, con una crew di amici DJ, sia veterani che non, Brotherhood, un concept che non ha la pretesa di creare nulla di nuovo e fantastico ma solo di riportare al centro il valore della musica, come le one night degli anni Novanta tipo Matmos di cui parlavamo qualche riga fa. Insomma, prima la musica e poi il resto. È dura portare avanti un progetto del genere oggi ma qualche piccola soddisfazione ce la stiamo prendendo, ed abbiamo solo un anno di vita.

Le copertine di alcune produzioni discografiche di Bruno Bolla
Il decennio 1990-1999 è stato l’ultimo a poter contare su un mercato regolato dall’economia pre-internet in cui le case discografiche incassavano denaro dalla vendita dei loro prodotti fisici (dischi, CD e cassette). Dal 2000 in poi le cose non sarebbero più state le stesse, e in tanti ci hanno rimesso le penne. Stranamente tu, a differenza di gran parte dei tuoi colleghi, non hai mai puntato a sviluppare il ruolo di produttore, seppur i tempi fossero ancora propizi, limitandoti perlopiù alla selezione di varie compilation tematiche (“Influencia Do Jazz”, “Break N’ Bossa”) a cui se ne aggiunsero altre nel nuovo millennio come i due volumi di “BlackTronic” su Cool D:vision. Perché hai preferito focalizzare la tua attività solo sul DJing?
Ho sempre avuto un rapporto particolare con la produzione di musica e soprattutto con la definizione di “produttore”. Quando sento qualcuno che si considera tale rimango sempre perplesso. Associo il fare musica all’essere musicista, ed io non lo sono. Ma cosa vuol dire realmente essere “produttori musicali”? Attribuirsi la paternità di un disco? Una buona parte dei nomi internazionali del DJing si avvale di ghost producer, musicisti con grande abilità nell’uso delle macchine, pagati per realizzare brani che escono a nomi di altri (a tal proposito si rimanda a questo reportage, nda). A metterci la firma è il DJ che grazie a questi dischi diventa famoso facendo più gig. In realtà più che essere un DJ, quello credo sia un imprenditore, label manager o qualcosa di simile. Qualora mettesse l’idea portante è giusto che gli vengano riconosciuti i meriti, ma se non lo fa? Questo succede abbastanza spesso, soprattutto oggi dove il marketing ha preso il sopravvento sul resto. Io sono molto rispettoso della mia attività da DJ ed anche di quella dei musicisti. Nel 1997 ho “prodotto” il mio primo disco, “Indefinita Atmosfera” di Neos, con Gerardo Frisina e musicisti straordinariamente importanti nel panorama jazz italiano come il sassofonista Gianni Bedori, scomparso nel 2005, e il pianista Luigi Bonafede. Il compito mio e di Gerardo, che poi ha intrapreso una strepitosa carriera solista, era dare degli input nu jazz con un’attitudine da club a dei musicisti tradizionali che della dance non sapevano nulla o quasi. Ecco perché sul disco c’è scritto “produzione artistica” accanto ai nostri nomi. Mi sembra una definizione corretta. Comunque il mio è un discorso generale, ovviamente esistono DJ che nel contempo possono essere anche musicisti e bravi producer, ma sono una minoranza contrariamente a quanto si possa credere. Si tratta di rispetto dei ruoli insomma. Io ad esempio realizzo e suono re-edit nelle mie serate, ma non le ho mai pubblicate, lungi da me appropriarmi di un brano su cui sono intervenuto facendo qualche cut, allungando delle parti ed aggiungendo beat e groove piu freschi. Nutro comunque rispetto per chi pubblica cose del genere, e devo dire che ci sono personaggi abili in questo, inclusi tanti amici DJ-producer, ma io non riesco proprio, almeno per il momento. Mi rifaccio a quella che è la mission del DJ sin dai tempi dei grandi maestri, Mancuso, Levan, Grasso, Hardy… ovvero selezionare, assemblare e mixare musica di altri dando ad essa l’energia necessaria per essere utilizzata in un club. Questo è il DJ, le altre funzioni sono accessorie, meno importanti. Per tale ragione non sono mai stato un “producer” prolifico, ho sempre lavorato sulla selezione e sul DJing piuttosto che sulla creazione. Quando sento un bel disco non penso quasi mai al groove da carpire per ricavarne un nuovo prodotto, bensì a quale possa essere il brano da accostare in un set. Ho questa attitudine, non c’è nulla da fare. Tuttavia in passato è capitato di collaborare in un team in cui il mio compito era rappresentare l’archivio storico e quindi tirare fuori l’idea da un disco che non conosceva nessuno. Un produttore artistico quindi, e non escludo che ciò possa accadere ancora in futuro. Gran parte dei miei sforzi, comunque, sono stati assorbiti dalle compilation: i tre volumi di “Influencia Do Jazz” raggiunsero, a metà anni Novanta, soglie di vendita impensabili per un progetto così specializzato, per di più made in Italy. Si parlava di ottomila/novemila copie a volume, forse anche di più, non ricordo bene. Stesso dicasi per i due volumi di “BlackTronic” usciti tra 2003 e 2005, tuttora un mio format da club.
Nel 2006 metti su, insieme a vari amici/colleghi, il team Love Supreme che debutta sulla Tirk di Sav Remzi, erede della Nuphonic citata spesso nei tuoi articoli e recensioni. L’ultima uscita però credo risalga al 2012, vi siete fermati?
Cause di forza maggiore ci hanno divisi. Io mi sono trasferito in Piemonte nel 2008, Roberto Di Movi ha mollato l’Italia per andarsene ad Ibiza più o meno nello stesso periodo. Nic Sarno invece ha iniziato con progetti solisti interessanti ma diversi. Luca Saponaro infine, musicista e perno del tutto, ha stretto varie collaborazioni con altri artisti della scena milanese, oltre ad aver fondato una propria etichetta, la Mad On The Moon, con risultati egregi anche se i dischi in quel periodo (2006-2010) si vendevano davvero poco e la riesplosione del vinile era piuttosto lontana. Era rimasto solo e noi, a differenza di tanti altri, non riuscivamo a scambiarci idee a distanza con Skype, avevamo bisogno del contatto fisico, di respirare la stessa aria, marijuana compresa (loro, io no) – ride. Molte incisioni dei Love Supreme erano jam improvvisate con una strumentazione quasi interamente analogica, nel pieno stile dei nostri eroi ed ispiratori come Can, Tangerine Dream, Klaus Schulze, Popol Vuh ed altre eminenze del krautrock tedesco. La spontaneità era la qualità primaria del nostro lavoro e riascoltando oggi quei brani mi accorgo che a guidarci era una grande creatività. Chissà, magari un giorno torneremo insieme.
Il mercato della musica è radicalmente cambiato ma si può dire altrettanto del DJing, spettacolarizzato come non mai e portato a livelli di popolarità esagerata, agli antipodi rispetto a quello che era il DJing degli albori. Tu, che hai avuto la possibilità di vivere almeno tre decenni in questo settore, come giudichi tale evoluzione o, come sostengono in tanti, involuzione?
La spettacolarizzazione e l’eccessiva popolarità di alcuni, cosiddetti, DJ, hanno ben poco da spartire con la mission per cui la figura del DJ stesso è nata. Negli anni d’oro il DJ era considerato importante quanto il barman del locale o poco più. Doveva solo caratterizzare il club con la sua musica. L’importanza attribuita ai DJ oggi è davvero eccessiva e lo dico anche se sono parte in causa. Non so se sia da considerare un’involuzione ma sono del parere che il DJ superstar odierno sia una figura ben diversa rispetto a quello che deve essere un DJ. Io lo chiamerei persino diversamente anche se non saprei come. Un DJ americano un giorno mi disse: «Un disc jockey non può valere più di cinquemila dollari, chiunque esso sia, è una questione di ruolo. Il DJ deve rimanere underground, anche sotto il profilo economico, è un concetto etico». Poi, come nel mondo del calcio, c’è la relazione tra domanda ed offerta ed è proprio lì che tutto diventa distorto. D’altra parte è un fenomeno strettamente connesso alla realtà contemporanea dove regnano eccessi incontrollati.
Oggi in discoteca pare si preferisca fare video con lo smartphone anziché ballare, e in relazione a ciò piovono costantemente critiche sulle nuove generazioni, accusate di non sapersi divertire e di frequentare locali (ma specialmente i grandi festival) per il solo gusto di far sapere agli altri di esserci stati. Come era il pubblico di venti o trent’anni fa invece? È vero che gli avventori dei club erano più appassionati rispetto a quelli odierni o è solo un luogo comune?
Esiste un pubblico appassionato anche ora, non tutto è negativo ed io non sono affatto un nostalgico. Sono però cambiati i numeri. Nei club ci andava più gente, questo è un aspetto non trascurabile, ora ci sono altre distrazioni proprio come lo smartphone. A questo proposito vorrei raccontare un aneddoto divertente e significativo. Nel 2008 sonorizzai l’apertura di un negozio di un brand italiano importante a Tokyo. Sentendo per caso un amico giapponese, un addetto ai lavori noto a Milano, mi venne in mente di allungare la permanenza in Giappone con un paio di gig in piccoli club dove normalmente si tenevano serate rare grooves. A rendere fattibile l’idea furono le mie raccolte “Influencia Do Jazz”, pare che grazie ad esse il mio nome fosse discretamente popolare da quelle parti. Portai solo CD per la performance nel negozio ed una quarantina di dischi rare grooves di tipo funk, brazil e jazz. Nel primo club, a Tokyo, la serata andò egregiamente, ricevetti tanti complimenti ed un ottimo riscontro. Il giorno dopo andai in un’altra località, fuori dal centro cittadino, praticamente in periferia, e lì ebbi quasi uno shock. C’erano tanti addetti ai lavori ma dopo un’ora mi resi conto che non ci fosse grande entusiasmo, ballavano in pochi e molti erano distratti, guardavano il telefonino ed io non capivo la ragione. Chiamai quindi il mio amico chiedendogli se fosse possibile farmi parlare con l’organizzatore che era a pochi metri da me. Gli domandai cosa non andasse, se stessi sbagliando qualcosa in quello che facevo e lui, dopo un paio di classici inchini, mi disse: «No amico, tutt’altro. Stai mettendo cose bellissime che non conoscono e quindi stanno cercando di capire cosa siano con l’aiuto di un’app installata sul cellulare». Caddi dalle nuvole, non sapevo neanche cosa fosse ma è risaputo, i giapponesi sono sempre stati avanti nella tecnologia. Rimasi talmente basito che il mio interlocutore capì l’imbarazzo e qualche minuto dopo, credo in seguito ad un robusto passaparola, tutti iniziarono magicamente a ballare e terminai il mio set in gloria. In quel caso ho dovuto ricorrere a tutta la mia sfacciataggine ed esperienza per non perdere la calma. Oggi quando vedo smartphone e video, invito la gente a godersi il momento ma purtroppo non ho l’antidoto a questo atteggiamento, credo sia una questione di cultura. Per quanto riguarda i festival invece, penso che abbiano accelerato il declino del clubbing. Come dicevo prima, in Italia il “decesso” è avvenuto da tempo, ma in Europa, soprattutto al nord, un certo modo di identificarsi nel club “di fiducia” resiste ancora e i frequentatori non sono certamente solo attempati nostalgici ma pure giovanissimi. Gli appassionati e i cultori restano ma sono meno. Personalmente mi piacciono alcuni piccoli festival a programmazione mista tra live e DJ set con un mix tra acustica ed elettronica, con act nuovi abbinati a show di figure storiche. Di questo tipo ce ne sono anche in Italia. Non mi piacciono invece i festival monocorde, quelli con trenta DJ di nome che fanno più o meno la stessa cosa, o coi tantissimi DJ che richiedono set lunghi per suonare la stessa minestra (e questo succede anche nei club). Li trovo noiosi ed inutili.

Bruno Bolla in compagnia di un’amica al Country Club di Siziano (Pavia), nel 1994
Perché si parla sempre entusiasticamente degli anni Novanta?
Perché rappresentano la golden age del clubbing e forse anche la mia stessa “età dorata” soprattutto per i trascorsi più underground. Credo però che anche negli anni Novanta ci siano stati dei momenti d’ombra. Nel mio caso, intorno al 1996, vissi un’impasse perché la house sembrava aver esaurito la sua spinta delle origini. Quella “stasi creativa” mi portò ad esplorare altri mondi musicali come trip hop, breakbeat e le prime cose del french touch, correnti che però non mi convinsero appieno. Nel frattempo la scena rare grooves, altro mio volto sonoro, stava entrando nella fase nel cosiddetto “nuovo jazz da club” poi chiamato nu jazz, ma i tempi non erano ancora maturi. Fu un periodo di piccola confusione perché erano generi non molto popolari e quindi non era affatto facile acquisire gig ed avere sfoghi radiofonici. Ritrovai la giusta energia alla fine del decennio quando l’house prese nuovamente una piega a me congeniale, tingendosi di afro e jazz con bellissime pubblicazioni di artisti come Masters At Work, Joe Claussell, François Kevorkian ed Osunlade, solo per citarne alcuni. Iniziai quindi gli anni Duemila col piede giusto e con le idee molto chiare, infatti credo che il periodo 2000-2006 sia quello in cui il mio nome abbia conosciuto maggiore popolarità, anche grazie a Cool Dance a cui facevamo prima cenno, un radio show dal concept assolutamente innovativo per i tempi e veramente eclettico, che andava oltre i mix show, pur pregevoli, orientati ad house e dance commerciale sentiti fino ad allora. Mettere insieme ben cinquemila persone nei primi cinque anni della mia residenza decennale al Cafè Solaire con quel suono poteva sembrare solo un sogno eppure era realtà.
Hai più vissuto momenti di stanca come quello del 1996?
Sì, circa una decina di anni più tardi. Nel 2007 entrai nuovamente in una fase un po’ strana, le cose stavano cambiando sia professionalmente che umanamente. Il matrimonio, la nascita di mia figlia, il trasferimento in Piemonte in una casa con bed & breakfast e studio annessi: tutti eventi non certamente indifferenti per chi, come me, non avrebbe scommesso un centesimo sul creare una famiglia. Invece è successo, con tutto il coinvolgimento emotivo del caso. La ristrutturazione della casa, la totale devozione al mio orto, la costruzione di una nuova, seppur piccola, attività sono diventate la mia quotidianità. A dirla tutta, iniziai ad avere un certo senso di nausea del mondo del clubbing perché a mio avviso la scena stava cambiando in peggio e nelle discoteche italiane si cominciò a respirare un’altra aria. Milano, in particolare, toccò forse il suo momento più basso (non ricordo periodi peggiori del lustro 2006-2011), almeno per musica, arte e spettacolo. Trovavo molto più interessanti città come Torino che costruivano una visione differente di club culture. Inoltre terminai l’esperienza radiofonica, visto che importanti cambiamenti travolsero pure quel settore, e i locali in cui avevo lavorato come resident iniziarono un declino fisiologico. Sino al 2009 circa ebbi l’opportunità di fare un po’ di serate all’estero, soprattutto in Oriente, grazie ad amici sparsi per il mondo e solo talvolta tramite qualche agenzia, anche perché non ho mai avuto una booking agency che si occupasse di me. Poi seguì un po’ di consapevole isolamento. C’è stato un periodo in cui ho pensato di mollare del tutto la musica, anche a causa di cose che mi hanno profondamente amareggiato e deluso. Riflettere sull’età che avanza però è un errore, basti guardare al momento strepitoso che vivono tanti DJ old school che mi hanno ispirato, tutti ovviamente più grandi di me. Così, grazie ad amici e persone vicine, ho deciso di continuare a mettere dischi sino a novant’anni. Non sono mica un mediano del calcio, posso resistere!
Qualche riga fa hai fatto cenno ad una crisi della scena milanese avvenuta tra la seconda metà degli anni Zero e i primi Dieci. Cosa avvenne di preciso?
Cambiò tutto profondamente. Tolte rarissime eccezioni, il clubbing divenne assolutamente mediocre e la musica non era più l’elemento trainante. Pure i generi si rivelarono solo rimpasti privi di quella forza necessaria per generare e fidelizzare nuovi adepti entusiasti, e la gestione dei locali fu stravolta. Un tempo a scegliere gli ospiti stranieri erano gli art director, al massimo con qualche suggerimento di chi lavorava in consolle, in quegli anni invece capitava molto spesso che le decisioni venissero prese dagli stessi DJ che ambivano a mettersi in mostra e magari ottenere una gig nel Paese di provenienza dell’ospite come contraccambio. Per non parlare poi della valanga di newcomer che si sono avvicinati a questo settore solo grazie alla tecnologia ma con background pari a zero. Risultato? Confusione totale, nei club e tra gli addetti ai lavori, col marketing che ha preso il sopravvento e l’apparire diventato più importante dell’essere. Non nego che questo approccio esistesse già negli anni Novanta, ma era diverso perché la musica riusciva ancora a primeggiare su tutto. Le cose fortunatamente, dopo il 2012 circa, sono migliorate ma faccio ancora fatica a raccapezzarmi e credo che tanti altri si trovino nella mia stessa condizione. L’unico modo per rimanere a galla è adeguarsi, io ci sono arrivato negli ultimi anni ma a modo mio, mantenendo sempre una certa distanza da cose che non riesco proprio a concepire e tollerare. Ora ho una nuova consapevolezza ma non voglio appartenere alla schiera dei nostalgici. Ho ritrovato l’entusiasmo e la voglia di “esplorare”, cerco quindi di fare bene le cose in cui credo così come le facevo un tempo, che ci siano cinquanta o cinquemila persone davanti per me non cambia nulla.
Se da un lato viviamo costantemente immersi nelle tecnologie di asimoviana memoria, dall’altro fronteggiamo col costante recupero di cose passate, facilitato anche da internet che in alcuni casi può trasformarsi in una sorta di “macchina del tempo”. Si veda, ad esempio, l’attenzione che riguarda l’italo house, genere che forse sta ottenendo più consensi ora rispetto alla sua collocazione storica originaria. Cosa ne pensi in merito? Si tratta di fogge passeggere istigate da qualcuno o qualcosa?
Assolutamente sì. Alla fine internet fa anche qualcosa di buono. L’italo house ha partorito grandi dischi ed un sacco di micro etichette interessantissime. Alcuni produttori e label poco popolari all’epoca stanno finalmente raccogliendo riconoscimenti inaspettati. Grazie alla voglia di retrospettiva che adesso sta contagiando un po’ tutti, in Europa si sta facendo giustizia. Meglio tardi che mai! A Brotherhood, ad esempio, abbiamo dedicato un’intera rassegna chiamata “The Italo House 90s Heroes”, dedicata ai produttori e label manager più oscuri ed underground di quegli anni. In tutto questo un merito indiretto lo ha il ritorno del vinile. Io ero tra i tantissimi che avevano cantato il De Profundis dopo il 2004-2005 e sono davvero contento di essermi sbagliato. Non credo che questo recupero del passato durerà poco perché indubbiamente, parlando di dance music, i pezzi che hanno smosso le acque ed hanno lasciato il segno sono quelli usciti dagli anni Settanta a fine anni Novanta. In seguito sono apparse ancora cose interessanti ma a mio avviso generi come disco, funk, boogie, house e techno prima maniera sono irripetibili. Tuttavia le gemme da riscoprire sono sempre meno, ormai stanno setacciando tutto di tutto.
Continui a comprare dischi e musica in generale?
Non mi sono mai fermato ma sicuramente acquisto meno di prima. Dopo quasi quarant’anni e pesanti rinunce, soprattutto da giovanissimo, le priorità cambiano. Per la cosiddetta “musica di consumo”, ovvero quella che suono durante le serate, uso principalmente i file ma il mio set up ideale in consolle è un ibrido tra analogico e digitale, quindi prevede anche la presenza dei giradischi. In vinile compro ristampe di rare grooves di generi come afro, funk e soul, oltre a qualcosa contemporanea, sia in 12″ che LP.
Quanti dischi possiedi?
Ne ho davvero tanti, circa quarantacinquemila, a cui vanno sommati i CD. Inizio ad avere seri problemi di spazio e da qualche tempo a questa parte ho iniziato a vendere le doppie copie ed alcune cose che non mi interessano più. Nel complesso sono tutti catalogati ma qualche volta divento matto a ricercare qualcosa che non è al suo posto.

Una parte della collezione di dischi di Bruno Bolla, 2018
Ci sono artisti ed etichette che ti hanno colpito recentemente?
Mi piacciono molto le cose della nuova scena afro e neo soul, etichette come Freestyle, Soundway, BBE ed pure quelle più house oriented tipo la MoBlack Records, la Philpot, la Lumberjacks In Hell o la Local Talk. Seguo inoltre label elettroniche che definisco “sempreverdi”, come Warp e Ninja Tune, oltre ad una moltitudine di etichette dedite ai re-edit disco e funk, tantissime da menzionare.
Quali invece i nomi più rivoluzionari degli anni Novanta?
Tra i DJ/produttori Carl Craig, Laurent Garnier, Larry Heard, Romanthony, Little Louie Vega, Kenny Dope Gonzalez e François Kevorkian, tra le etichette invece le già citate Warp e Ninja Tune, Nu Groove, F Communications, Soul Jazz Records ma l’elenco potrebbe andare avanti a lungo.
Solitamente i DJ hanno sempre nel flight case qualche “secret weapon” che usano in momenti particolari delle proprie serate. Quali sono i tuoi?
Ne ho tanti. In questo momento citerei “Renegade” di David Camacho, un caro amico DJ scomparso qualche anno fa, una delle anime più soulful che abbia mai conosciuto.
C’è almeno un disco che ti faceva impazzire ma che suonandolo in pubblico rischiava di svuotare la pista?
Solitamente non metto dischi che possano svuotare ma se succede dipende dal fatto di non aver indovinato la giusta sequenza, una qualità basilare per un disc jockey. Puoi passare anche un disco “difficile” ma se ci arrivi con la sequenza giusta lo fai diventare “facile”. In fin dei conti è proprio questa l’essenza dell’essere DJ.
(Giosuè Impellizzeri)
© Riproduzione riservata







 Project Democracy Feat. China – Is This Dream For Real?
Project Democracy Feat. China – Is This Dream For Real? Expansives – Life With You ….
Expansives – Life With You …. Phill & Friends Band – This Man
Phill & Friends Band – This Man Jiraffe – Out’A The Box
Jiraffe – Out’A The Box Peshay – Piano Tune
Peshay – Piano Tune Frak – Börft EP
Frak – Börft EP Clara Mondshine – Luna Africana
Clara Mondshine – Luna Africana Patrice Rushen – What’s The Story (Disco Version)
Patrice Rushen – What’s The Story (Disco Version) La Funk Mob – Casse Les Frontières, Fou Les Têtes En L’Air
La Funk Mob – Casse Les Frontières, Fou Les Têtes En L’Air Pressure Drop – Unify
Pressure Drop – Unify






 Rinôçérôse – Mes Vacances A Rio
Rinôçérôse – Mes Vacances A Rio Faze Action – Turn The Point
Faze Action – Turn The Point Daniele Baldelli & Dario Piana – Zero Gravity
Daniele Baldelli & Dario Piana – Zero Gravity Harry Thumann – Underwater
Harry Thumann – Underwater K.I.D. – Hupendi Muziki Wangu? ! (You Don’t Like My Music)
K.I.D. – Hupendi Muziki Wangu? ! (You Don’t Like My Music) Lil’ Louis & The World – Club Lonely
Lil’ Louis & The World – Club Lonely Flash And The Pan – Flash And The Pan
Flash And The Pan – Flash And The Pan Ian Pooley – What’s Your Number
Ian Pooley – What’s Your Number Kool & The Gang – Love & Understanding
Kool & The Gang – Love & Understanding Steve Miller Band – Circle Of Love
Steve Miller Band – Circle Of Love Bruno Bolla vanta un ampio bagaglio culturale che attinge da un nugolo di generi musicali agli antipodi del mainstream. La sua prima passione è quella per il cosiddetto “afro”, un intricato filone-contenitore di materiale trasversale determinante per gli orientamenti stilistici futuri. Negli anni Novanta infatti si lascia conquistare dall’acid jazz che, analogamente a quanto avvenuto con l’afro, è simile ad un groviglio multisfaccettato di generi che collega il mondo degli strumenti acustici con quello degli elettronici. Tra i suoi interessi c’è anche la house, che interseca ecletticamente con disco, funk e soul. Attivo pure in ambito discografico ma prediligendo più intenti compilativi che produttivi, Bolla è oggi uno dei veterani italiani della consolle, con una passione quarantennale alle spalle che continua ad animarlo senza sosta.
Bruno Bolla vanta un ampio bagaglio culturale che attinge da un nugolo di generi musicali agli antipodi del mainstream. La sua prima passione è quella per il cosiddetto “afro”, un intricato filone-contenitore di materiale trasversale determinante per gli orientamenti stilistici futuri. Negli anni Novanta infatti si lascia conquistare dall’acid jazz che, analogamente a quanto avvenuto con l’afro, è simile ad un groviglio multisfaccettato di generi che collega il mondo degli strumenti acustici con quello degli elettronici. Tra i suoi interessi c’è anche la house, che interseca ecletticamente con disco, funk e soul. Attivo pure in ambito discografico ma prediligendo più intenti compilativi che produttivi, Bolla è oggi uno dei veterani italiani della consolle, con una passione quarantennale alle spalle che continua ad animarlo senza sosta.





 “Un safari in tre D attraverso giungle inesplorate, terribili cerimonie voodoo e riti iniziatici Maya. Complici i prodigiosi occhiali che permettono di esaltare le tre dimensioni, uno stereo ad alta fedeltà ed una comoda poltrona di pelle, mondi che credevamo lontanissimi, leggende che raccontano di foreste impenetrabili e di bellissime amazzoni che sembrano vivere in simbiosi col proprio cavallo, entrano d’improvviso tra le pareti confortevoli del nostro salotto, rumori evocativi irrompono inaspettati nelle cuffie esaltati dal cocktail Martini che amabilmente sorseggiamo. Vivere “lounge” insomma, scoprire il fascino misterioso dell’esotismo, da consumare sprofondati nel più accogliente divano mentre scorrono le immagini che ci raccontano di altri emisferi, altri popoli, altre radici, commentate da un cocktail di suoni, una miscela perfettamente dosata dove temi struggenti composti da John Barry fanno da perfetto contrappunto alle sontuose orchestrazioni di Burt Bacharach”. Si apre così un articolo scritto da Pierfrancesco Pacoda e pubblicato ad aprile del 2000, che racconta l’invasione della musica exotica in Italia. Il successo di album tipo “Moon Safari” degli Air, “Play” di Moby, “I Find You Very Attractive” dei Touch And Go e “The Fifth Release From Matador” dei Pizzicato Five usciti negli ultimi anni del secolo/millennio e la progressiva diffusione di locali sul modello del parigino Buddha Bar di Claude Challe anticipano l’esplosione nostrana di una scena in cui emergono artisti come Sam Paglia, Montefiori Cocktail, Flabby, Nicola Conte, Alberto Dati, Pilot Jazou e Doing Time mentre etichette come La Douce, Easy Tempo, Dagored o Schema ripescano una valanga di musica cinematica, easy listening e più gergalmente lounge.
“Un safari in tre D attraverso giungle inesplorate, terribili cerimonie voodoo e riti iniziatici Maya. Complici i prodigiosi occhiali che permettono di esaltare le tre dimensioni, uno stereo ad alta fedeltà ed una comoda poltrona di pelle, mondi che credevamo lontanissimi, leggende che raccontano di foreste impenetrabili e di bellissime amazzoni che sembrano vivere in simbiosi col proprio cavallo, entrano d’improvviso tra le pareti confortevoli del nostro salotto, rumori evocativi irrompono inaspettati nelle cuffie esaltati dal cocktail Martini che amabilmente sorseggiamo. Vivere “lounge” insomma, scoprire il fascino misterioso dell’esotismo, da consumare sprofondati nel più accogliente divano mentre scorrono le immagini che ci raccontano di altri emisferi, altri popoli, altre radici, commentate da un cocktail di suoni, una miscela perfettamente dosata dove temi struggenti composti da John Barry fanno da perfetto contrappunto alle sontuose orchestrazioni di Burt Bacharach”. Si apre così un articolo scritto da Pierfrancesco Pacoda e pubblicato ad aprile del 2000, che racconta l’invasione della musica exotica in Italia. Il successo di album tipo “Moon Safari” degli Air, “Play” di Moby, “I Find You Very Attractive” dei Touch And Go e “The Fifth Release From Matador” dei Pizzicato Five usciti negli ultimi anni del secolo/millennio e la progressiva diffusione di locali sul modello del parigino Buddha Bar di Claude Challe anticipano l’esplosione nostrana di una scena in cui emergono artisti come Sam Paglia, Montefiori Cocktail, Flabby, Nicola Conte, Alberto Dati, Pilot Jazou e Doing Time mentre etichette come La Douce, Easy Tempo, Dagored o Schema ripescano una valanga di musica cinematica, easy listening e più gergalmente lounge.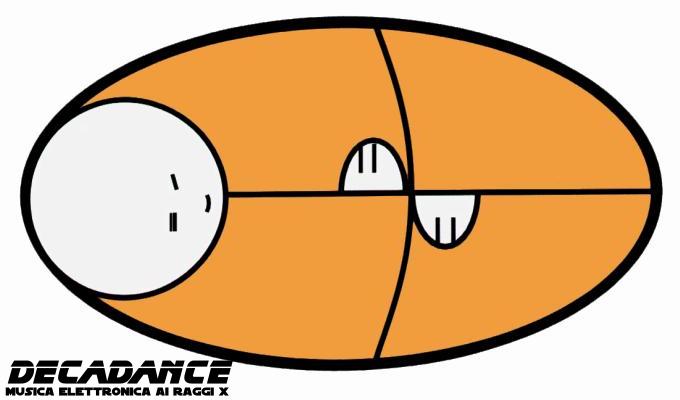





 Tra il 1989 e i primissimi anni Novanta, dopo il boom dell’italo house ribattezzata piano house per la sua caratteristica intrinseca probabilmente debitrice a
Tra il 1989 e i primissimi anni Novanta, dopo il boom dell’italo house ribattezzata piano house per la sua caratteristica intrinseca probabilmente debitrice a 




 “Il Paese della pizza, pasta e mandolino” recita uno dei più vecchi luoghi comuni sull’Italia. Per certi versi è vero ma non bisogna dimenticare che più di qualcuno si è dato attivamente da fare per azzerare o almeno ridurre i soliti pregiudizi. Tra questi Ivan Iusco che alla fine degli anni Ottanta, appena diciassettenne, diventa produttore discografico e crea un’etichetta per musica completamente diversa da quella che il nostro mercato interno prediligeva. Un ribollire di elettronica intellettualista, ambient, dark, industrial, quella che qualche tempo dopo sarebbe stata raccolta sotto la dicitura IDM (acronimo di Intelligent Dance Music) o braindance. Questa era la Minus Habens dei primi anni di intrepida sperimentazione, di registrazioni su cassetta vendute per corrispondenza ed effettuate da artisti che quasi certamente qui da noi non avrebbero trovato molti discografici disposti ad incoraggiare e supportare la propria creatività. Se oltralpe l’IDM viene consacrato da realtà come Warp Records, Apollo, Rephlex e Planet Mu, in Italia la Minus Habens pare non temere rivali. Dalla sua sede a Bari, tra le città probabilmente meno adatte ad alimentare il mito della musica sperimentale, irradia a ritmo serrato la musica di un foltissimo roster artistico che annovera anche band statuarie come Front 242 e Front Line Assembly. Iusco poi nel 1992 vara una sublabel destinata ad incidere a fondo nel sottobosco produttivo dei tempi, la Disturbance, approdo per italiani “molto poco italiani” sul fronte stilistico (Doris Norton, X4U, The Kosmik Twins, Baby B, Monomorph, Astral Body, The Frustrated, Xyrex, Dynamic Wave, T.E.W., Iusco stesso nascosto dietro la sigla It) e lido altrettanto felice per esteri destinati a lasciare il segno, su tutti Aphex Twin, Speedy J ed Uwe Schmidt. I Minus Habens e i Disturbance di quegli anni rappresentano il lato oscuro dell’Italia elettronica, quella adorata e rispettata dagli appassionati e che si presta più che bene per la locuzione latina “nemo propheta in patria”. Nel corso del tempo nascono altri marchi (QBic Records, Lingua, Casaluna Productions, Noseless Records, Betaform Records) che servono a rimarcare nuove traiettorie inclini a trip hop, nu jazz, funk, downtempo e lounge in senso più ampio destinato alla cinematografia anche con episodi cantautorali a cui Minus Habens Records, ormai vicina al trentennale d’attività, ha legato stabilmente la sua immagine. Al contrario di quanto suggerisce il nome (i latini indicavano sarcasticamente minus habens chi fosse dotato di scarsa intelligenza), la label di Ivan Iusco «è rimasta in piedi per un arco di tempo incredibilmente lungo, in cui numerose altre esperienze discografiche indipendenti, anche prestigiose, sono nate, cresciute e decedute», come si legge nel libro “Minus Habens eXperYenZ” del 2012 curato da Alessandro Ludovico, co-fondatore insieme allo stesso Iusco della rivista Neural, magazine pubblicato per la prima volta a novembre 1993 e dedicato a realtà virtuali, tecnologia, fantascienza e musica elettronica. Un’altra di quelle atipiche quanto meravigliose anomalie italiane.
“Il Paese della pizza, pasta e mandolino” recita uno dei più vecchi luoghi comuni sull’Italia. Per certi versi è vero ma non bisogna dimenticare che più di qualcuno si è dato attivamente da fare per azzerare o almeno ridurre i soliti pregiudizi. Tra questi Ivan Iusco che alla fine degli anni Ottanta, appena diciassettenne, diventa produttore discografico e crea un’etichetta per musica completamente diversa da quella che il nostro mercato interno prediligeva. Un ribollire di elettronica intellettualista, ambient, dark, industrial, quella che qualche tempo dopo sarebbe stata raccolta sotto la dicitura IDM (acronimo di Intelligent Dance Music) o braindance. Questa era la Minus Habens dei primi anni di intrepida sperimentazione, di registrazioni su cassetta vendute per corrispondenza ed effettuate da artisti che quasi certamente qui da noi non avrebbero trovato molti discografici disposti ad incoraggiare e supportare la propria creatività. Se oltralpe l’IDM viene consacrato da realtà come Warp Records, Apollo, Rephlex e Planet Mu, in Italia la Minus Habens pare non temere rivali. Dalla sua sede a Bari, tra le città probabilmente meno adatte ad alimentare il mito della musica sperimentale, irradia a ritmo serrato la musica di un foltissimo roster artistico che annovera anche band statuarie come Front 242 e Front Line Assembly. Iusco poi nel 1992 vara una sublabel destinata ad incidere a fondo nel sottobosco produttivo dei tempi, la Disturbance, approdo per italiani “molto poco italiani” sul fronte stilistico (Doris Norton, X4U, The Kosmik Twins, Baby B, Monomorph, Astral Body, The Frustrated, Xyrex, Dynamic Wave, T.E.W., Iusco stesso nascosto dietro la sigla It) e lido altrettanto felice per esteri destinati a lasciare il segno, su tutti Aphex Twin, Speedy J ed Uwe Schmidt. I Minus Habens e i Disturbance di quegli anni rappresentano il lato oscuro dell’Italia elettronica, quella adorata e rispettata dagli appassionati e che si presta più che bene per la locuzione latina “nemo propheta in patria”. Nel corso del tempo nascono altri marchi (QBic Records, Lingua, Casaluna Productions, Noseless Records, Betaform Records) che servono a rimarcare nuove traiettorie inclini a trip hop, nu jazz, funk, downtempo e lounge in senso più ampio destinato alla cinematografia anche con episodi cantautorali a cui Minus Habens Records, ormai vicina al trentennale d’attività, ha legato stabilmente la sua immagine. Al contrario di quanto suggerisce il nome (i latini indicavano sarcasticamente minus habens chi fosse dotato di scarsa intelligenza), la label di Ivan Iusco «è rimasta in piedi per un arco di tempo incredibilmente lungo, in cui numerose altre esperienze discografiche indipendenti, anche prestigiose, sono nate, cresciute e decedute», come si legge nel libro “Minus Habens eXperYenZ” del 2012 curato da Alessandro Ludovico, co-fondatore insieme allo stesso Iusco della rivista Neural, magazine pubblicato per la prima volta a novembre 1993 e dedicato a realtà virtuali, tecnologia, fantascienza e musica elettronica. Un’altra di quelle atipiche quanto meravigliose anomalie italiane.