1987: uno sguardo d’insieme
La musica che i DJ propongono nella maggior parte delle discoteche italiane nel 1987 è legata prevalentemente all’italodisco e al synth pop per i locali di stampo più commerciale, alla new wave, EBM ed industrial per quelli rivolti invece ad un pubblico più settoriale ed incline al rock alternativo. Sull’onda della cosiddetta “afro” lanciata molti anni prima in locali-culto come Baia Degli Angeli, Cosmic, Typhoon, Melody Mecca e Ciak, giusto per citare alcuni dei più noti, non mancano quelli che continuano a selezionare funk, soul e disco ma il panorama appare piuttosto stagnante perché improntato in sostanza sul recupero di materiale datato. Sul fronte rock/pop c’è chi, come Lorenzo Zacchetti in questo articolo, parla del 1987 come «un anno straordinariamente fertile sia sul piano della qualità che su quello della quantità, con le uscite di tutti i più grandi artisti del periodo, di figure emergenti e di diverse meteore». Il singolo più venduto dell’anno, secondo le statistiche di Hit Parade Italia è “La Bamba” dei Los Lobos. Undicesima si piazza Spagna con “Call Me”, prodotta da Larry Pignagnoli, ventiduesimi i tedeschi Off (i futuri Snap! ed un giovane Sven Väth che canta e presta l’immagine pubblica) con “Electrica Salsa (Baba Baba)” seguiti dalla prorompente Sabrina Salerno con “Boys”. Poco più giù “Respectable” di Mel & Kim, col tocco della premiata ditta Stock, Aitken & Waterman, e “Take Me Back” di un’altra bellezza della scuderia cecchettiana, Tracy Spencer. In ordine sparso poi Madonna, Nick Kamen, Rick Astley, Samantha Fox, Pet Shop Boys, Boy George, Level 42, Eighth Wonder, Depeche Mode, Duran Duran e Spandau Ballet. Solo settantaduesimo Den Harrow con “Don’t Break My Heart”, ennesimo singolo messo a segno dalla coppia Miki Chieregato – Roberto Turatti che quell’anno sforna anche “Meet My Friend” ed “Up & Down” di Eddy Huntington. L’italodisco nostrana pare essere giunta però al capolinea, il periodo più ricco di intuizioni, quello che va dal 1983 al 1985 circa, è ormai lontano e la formula di quel filone, ripetuta migliaia di volte e sdoganata in infinite salse, inizia a rivelarsi stantia. Sbirciare in altre classifiche di riferimento dei tempi non rivela grandi differenze: a giugno 1987 i posti più alti della “Superclassifica Show” condotta da Maurizio Seymandi (e dal virtuale DJ Super X) vede artisti come U2, Edoardo Bennato, Vasco Rossi, Zucchero e Whitney Houston. Tra le chart più consultate ai tempi c’è anche quella di TV Sorrisi E Canzoni diretto dal compianto Gigi Vesigna che, proprio nel 1987, tocca la tiratura record di oltre tre milioni di copie settimanali, ma anche lì non si rinviene nulla che riconduca alla “nuova dance music” che pulsa, da circa un biennio, in alcune discoteche statunitensi. Nella DeeJay Parade di Radio DeeJay invece, “Pump Up The Volume”, considerata alla stregua di una traccia spartiacque, entra il 24 ottobre e raggiunge la vetta il 7 novembre per rimanerci un mese.

La DeeJay Parade del 7 novembre 1987 vede in vetta “Pump Up The Volume” dei britannici M.A.R.R.S., considerato uno dei primi brani house prodotti in Europa. Foto su gentile concessione di Maurizio Santi
Per buona parte del 1987 quello della house music è un mondo ancora profondamente sotterraneo per gli stessi disc jockey, fatta eccezione per coloro che si tengono aggiornati leggendo riviste estere. Il fatto che ad inizio febbraio “Jack Your Body” di Steve “Silk” Hurley conquisti la vetta della chart britannica dei 45 giri (giunta da noi attraverso le pagine del Radiocorriere Tv) non significa molto, neanche nello stesso Regno Unito dove a Top Of The Pops giungono, già l’anno prima, Farley “Jackmaster” Funk e il compianto Darryl Pandy con “Love Can’t Turn Around”, ripubblicata oltremanica dalla London Records. In appena un paio di anni però in Europa cambia tutto, a partire proprio dalla Gran Bretagna dove i M.A.R.R.S., incrociano la sampledelia dell’hip hop coi beat in 4/4 della house e danno la spinta necessaria con “Pump Up The Volume” (a tal proposito si veda questo approfondimento). La house, che all’inizio viene scambiata per una moda passeggera, arriverà a conquistare milioni di giovani e non solo. Cederanno persino gli Style Council di Paul Weller che a febbraio del 1989 portano sul palco di Top Of The Pops “Promised Land”, cover dell’omonimo di Joe Smooth edito nel 1987 dalla D.J. International Records di Rocky Jones, tra i primi brani house prodotti a Chicago a fare fortuna nel Vecchio Continente.
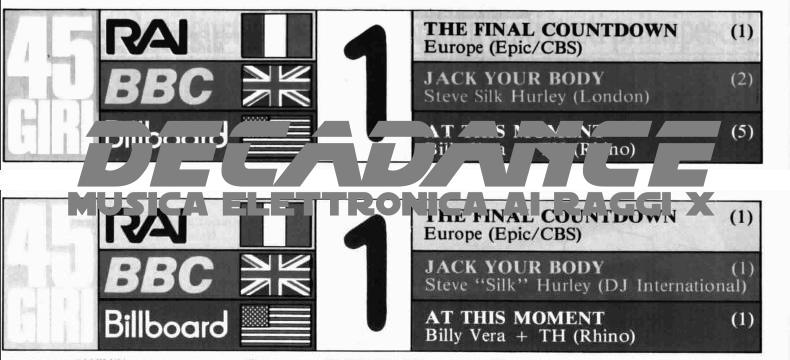
Le classifiche dei 45 giri giunte in Italia attraverso il Radiocorriere (1 ed 8 febbraio 1987): In prima posizione, nel Regno Unito, c’è “Jack Your Body” di Steve “Silk” Hurley
La “disco nera degli anni Ottanta” sbarca in Italia
È molto complesso stabilire chi abbia parlato per primo di house music nel nostro Paese. La scarsissima reperibilità di fonti impedisce di collocare nomi e date in un contesto preciso e le informazioni tramandate per via orale purtroppo non sempre rispettano e rispecchiano la reale cronologia degli eventi. Comunque, per sommi capi, si può asserire quasi con tranquillità che nella prima metà del 1987 i mass media generalisti (televisioni, radio e giornali) non si siano ancora accorti di quella grande rivoluzione in arrivo dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Sarà “Pump Up The Volume” dei britannici M.A.R.R.S., uscito ad agosto, a cambiare lo status quo e a spalancare nuove prospettive, introducendo anche in Italia per il grande pubblico il termine house music, genere che però, come si vedrà più avanti, necessiterà di circa due anni per assumere una personalità più definita. Inizialmente la house è considerata, come scrive Michele Monti in un articolo apparso sulla rivista DeeJay Show nell’autunno ’87 (presumibilmente a novembre) «l’ultima moda che soppianta il rap, l’electro funk e il go-go, cioè tutti i ritmi esotici approdati sulla pista da ballo negli ultimi tempi. A colpi di mezz’ora o di serate intere, la house music sta impazzando in ogni locale che si rispetti e non c’é DJ che non abbia in scaletta i suoi bei dieci minuti di house». Intesa come una sorta di diversivo, la house music è ancora ad uso e consumo di una ristrettissima fascia di DJ che peraltro fatica non poco a reperirla perché gli unici dischi disponibili sono quelli d’importazione, prevalentemente statunitense. Dislocati a macchia di leopardo lungo la penisola ci sono però gruppi di appassionati, DJ e ricercatori di nuove tendenze musicali, che intercettano il movimento house con abbondante anticipo rispetto all’affermazione commerciale e lo supportano in locali o eventi dedicati espressamente. È il caso del Devotion, che prende il nome dal brano omonimo dei Ten City, e de I Ragazzi Terribili a Roma, di cui si parla approfonditamente in questo articolo a cura di Luca Lo Pinto e Valerio Mannucci, dell’Ethos Mama a Gabicce, dove Flavio Vecchi, che allora si fa chiamare Double J. Flash, e Wayne Brown alternano la house all’hip hop e all’r&b come testimonia questo documento audio, o del Macrillo, locale ubicato sull’altopiano di Asiago e diretto dal compianto Vasco Rigoni, dove Leo Mas ed Alfredo Fiorito, reduci di una esaltante stagione estiva all’Amnesia di Ibiza – di cui si parla anche in Decadance Extra -, propongono house per un pubblico che accorre da tutta la penisola. Mas avrebbe poi continuato al Movida di Jesolo, diretto da Enzo Bellinato, fiancheggiato da Fabrice ed Andrea Gemolotto con cui dà avvio a “La Magica Triade”. Un certo interesse è mostrato pure dalle riviste di settore, come Fare Musica, dove appare un’intervista a Larry Levan, o Rockstar, dove invece trova spazio una rubrica di Luca De Gennaro, come scrive Andrea Benedetti nel suo libro “Mondo Techno”. Paolo Di Nola del citato Devotion ricorda altresì un articolo sul Messaggero e una breve intervista mandata in onda la domenica su Rai 3.

L’articolo di Michele Monti apparso sulla rivista DeeJay Show nell’autunno del 1987 (presumibilmente a novembre), tra i primi dedicati alla house music apparsi in Italia. Su gentile concessione di Maurizio Santi
Il successo spiazzante dei M.A.R.R.S. nell’autunno ’87 però, se da un lato aiuta la diffusione nazionale di questo nuovo genere, dall’altro finisce col falsare e compromettere la percezione che il pubblico italiano ha per l’house music che a quel punto viene spacciata come prodotto nato esclusivamente dal campionamento di pezzi altrui. Secondo i detrattori più accaniti, campionare equivale a rubare e la house diventa conseguentemente simile ad un riassemblaggio raffazzonato ad opera di non musicisti messi in condizione, dalla tecnologia, di poter fare musica anche a casa. Emerge così pure il parallelismo tra “house” e “casa” che secondo alcuni si presterebbe in modo inequivocabile a chiarire le origini di quel nuovo genere. A tal proposito, in quelle due pagine apparse su DeeJay Show, il citato Monti si riallaccia a quanto scritto dalla rivista anglosassone Mixmag spiegando che «dietro ogni pezzo house, più o meno famoso, si nascondono i ritmi e le melodie di brani di vecchia disco o di recente dance», elencando pure diversi esempi: «“Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders non è altro che un remix di “I Can’t Turn Around” di Isaac Hayes, “Dum-Dum” dei Fresh “rubacchia” frammenti di “One Nation Under A Groove” dei Funkadelic e di “The Glamorous Life” di Sheila E., “Move” dei Farm Boy ricorda molto “Slave To The Rhythm” di Grace Jones, “Like This” di Chip E. è la copia carbone di “Moody” degli ESG». Poi prosegue dicendo che «le canzoni più saccheggiate in assoluto dalla house music sono “Love Is The Message” degli MFSB, “Let No Man Put Asunder” dei First Choice, “Relax” dei Frankie Goes To Hollywood, “Moskow Diskow” dei Telex e, incredibilmente, “Happy Children” dell’italianissimo P. Lion». Il ruolo ricoperto specificamente dall’italodisco comunque è fondamentale tanto nella house di Chicago quanto nella techno di Detroit, per ammissione degli stessi artefici e probabilmente ad insaputa della maggior parte dei produttori (e giornalisti) italiani di allora, ma ridurre la house music a qualcosa di passivamente ed ingenerosamente derivativo, così come viene descritto ai tempi, è ingiusto, non solo sotto il profilo creativo ma pure sotto quello tecnico. “Rubacchiare” a destra e a manca e ricollocare con estrema semplicità su telai ritmici programmati da drum machine ree di aver svilito il ruolo dei batteristi in carne ed ossa è solamente una verità apparente, istigata inconsapevolmente dal collage dei M.A.R.R.S. a cui, comunque, va riconosciuto il merito di essere riusciti a creare un brano-patchwork talmente dirompente da diventare una pietra miliare in un particolare momento storico che offre nuove opportunità. Monti include una dichiarazione di Chip E. particolarmente significativa a tal riguardo: «prendere idee da altri dischi non è considerato furto, dopotutto il lavoro del DJ è sempre stato questo, usare pezzi vecchi per creare un sound nuovo e personale». È interessante constatare, ad esempio, che non sia emersa altrettanta indignazione da parte di critici e stampa quando nel 1980 i Queen pubblicano “Another One Bites The Dust” che gira su un basso davvero simile a quello di “Christmas Rappin'” di Kurtis Blow uscito l’anno prima, o quando negli anni Sessanta proliferano decine di cover in italiano di brani angloamericani. Si può forse parlare di rifacimenti di serie A e di serie B, in virtù della funzione da essi esercitata? Le musiche destinate in modo specifico ai locali da ballo sono implicitamente meno valide di altre per il loro uso ludico? L’impressione, quindi, è che si usino due pesi e due misure, così come avviene per gli eccessi del rock/pop, tollerati ed assai meno demonizzati rispetto a quelli di altre culture musicali. A pagina 289 dei libro “Last Night A DJ Saved My Life” di Bill Brewster e Frank Broughton, la house viene definita come «disco music realizzata da dilettanti. Era l’essenza della disco (ritmi, giri di basso, spirito) ricreata su macchine che erano una via di mezzo tra giocattoli e strumenti musicali da ragazzi, più clubber che musicisti. I DJ, che aspiravano a preservare una musica dichiarata morta, ne avevano creata un’altra dalle sue ceneri». Tale descrizione risulta senza dubbio più appropriata rispetto a tante altre emerse ai tempi, probabilmente indotte anche da un forte e radicato scetticismo nei confronti della novità.
La house nei club dello Stivale: le testimonianze
Lazio
Il grande pubblico scopre la house coi M.A.R.R.S. ma in Italia esistono luoghi in cui quel tipo di musica viene proposta già da qualche tempo, seppur senza particolar clamore. Il più delle volte l’unico modo con cui scoprire tali “raduni” è il semplice passaparola. Roma, ricordata più frequentemente per il suo ruolo primario nella fase rave giunta qualche anno dopo con l’esplosione della techno, ha ricoperto una posizione altrettanto importante per la house specialmente in riferimento al Devotion, nato come associazione culturale su iniziativa di un gruppo di amici tra cui Alessandro Gilardini, oggi giornalista per il TG5, e Paolo Di Nola, DJ, che racconta: «L’house entrò molto presto nel mio mondo, direi anche prima che ci fosse un termine per definirla in Italia, considerando l’ascolto di dischi come “Trapped” di Colonel Abrams, “Hypnotic Tango” di My Mine o “Problèmes D’Amour” di Alexander Robotnick, tutti incorporati nelle scalette dei DJ che sono passati alla storia dell’house music. Nell’inverno del 1981 trascorsi un periodo dell’ultimo anno di liceo a New York, nel quartiere di Canarsie a Brooklyn per l’esattezza, prevalentemente popolato dalla comunità italoamericana e dove risiedeva parte della mia famiglia paterna che ebbe la possibilità di ospitarmi. Furono i miei compagni di scuola, quelli più intraprendenti che passavano le notti dei weekend in città facendo breakdance, ad introdurmi ai dancefloor dei club di New York dove si potevano già ascoltare esempi di proto house e musica dance prodotta prevalentemente mediante strumenti elettronici, ma con una radice più soul e disco rispetto alla new wave europea. I primi dischi house li acquistai a New York negli anni successivi in negozi come Vinylmania e Rock And Soul, veri e propri templi del vinile dove lo staff era incredibilmente ferrato musicalmente ed addirittura in grado di riconoscere pezzi da me fischiati o a malapena canticchiati nel tentativo di riprodurli, non conoscendone i titoli. Le prime tracce house da me collezionate furono gli ormai diventati classici della Trax Records come “Washing Machine” di Mr. Fingers, “Acid Tracks” dei Phuture e “Baby Wants To Ride” di Frankie Knuckles a cui si aggiunsero le prime cose su Easy Street Records come “Ma Foom Bey” di Cultural Vibe nonché i dischi su State Street Records tra cui “Face It” di Master C & J e “Can’t Get Enough” di Liz Torres. Oltre a tantissima disco, tipo “Is It All Over My Face” dei Loose Joints ed altre stampe su West End Records, Salsoul Records e Prelude Records. L’impatto e la successiva infinita storia d’amore con quella che per definizione viene chiamata house music si consumò nei club gay di New York come Paradise Garage, The Choice, Tracks, Roxy, The Loft, Sound Factory ed anche in locali londinesi come l’Heaven. I primi DJ da me seguiti, propugnatori dell’house music, furono black, latino, gay e lesbian, ma gli stessi club erano spesso gestiti da personale LGBTQ e il dancefloor era quello che oggi viene definito “safe space” ovvero uno spazio in cui poter esistere liberi da ogni discriminazione. Tutti questi elementi, per me, sono inscindibilmente legati alla radice della house music. Questa è stata la scena che mi ha forgiato e a cui tuttora porto massimo rispetto e dedizione.

Il pubblico del Devotion (Roma, 1987) in una foto scattata da Federico Del Prete, gentilmente concessa da Paolo Di Nola. A sinistra c’è Vincenzo Viceversa
Per quanto riguarda l’Italia, nel 1987 c’era sicuramente l’intero pubblico del Devotion ad apprezzare quelle sonorità tra cui moltissimi DJ noti della scena romana che venivano a ballare. Noi, col nostro club, fummo i primi a proporre quel tipo di programmazione after hour nella capitale e nell’intera regione, con un’intera scaletta fatta esclusivamente di house music e disco, nonché ad introdurre un certo tipo di “attitude” nella vita notturna, slegata dal solito modello delle VIP room, tavoli riservati e bottiglie di alcolici in vendita per centinaia di migliaia di lire. La nostra fu una scelta talmente radicale per quegli anni che l’unico club che ci aprì le porte fu il Life 85, la cui capienza raggiungeva le appena duecento persone ed era fuori da ogni circuito. Nell’arco di un paio di settimane appena il successo della serata fu talmente eclatante che per la seconda stagione ci spostammo al Parco del Turismo in una mega tenda geodetica che, puntualmente ogni weekend, si riempiva di gente fino all’orlo. Io e i miei colleghi DJ, Marco Militello ed Alessandro Gilardini, viaggiavamo a turno per comprare i dischi direttamente a New York, assicurandoci così musica non ancora uscita in Europa, cosa che ci permetteva di mantenere uno standard alto nell’esclusività musicale. Poi molti DJ seguirono le nostre orme, alcuni con enorme successo, ma credo che Marco Moreggia con I Ragazzi Terribili sia quello che abbia preservato meglio la purezza e lo spirito di ciò che intendevamo fare noi.

La tessera del Devotion (1987). Su gentile concessione di Paolo Di Nola
Al di fuori del Lazio, l’unico altro posto in cui sentii suonare per intero un set di house music ad inizio ’87 fu Napoli, dove c’erano alcuni ragazzi di colore che svolgevano il servizio militare nelle basi NATO limitrofe e si dilettavano a fare i DJ. Sfortunatamente non ho mai avuto il piacere di incontrarli, li avrei ringraziati personalmente per gli splendidi set. Ricordo con affetto anche il contingente umbro, con Vincenzo Viceversa e Ralf che, sulle orme del Devotion, lanciarono serate house a Perugia e dintorni. Io stesso fui ospite in un’occasione allo storico locale Norman durante una serata chiamata “Big Party”. Come raccontavo prima, in quel periodo compravo la maggior parte dei dischi a New York e Londra. Mi recavo lì solo per comprare vinile, partivo con valigie vuote che tornavano strapiene. Il mio budget però era talmente scarso che passavo intere settimane mangiando solo barrette di cioccolata o al massimo un trancio di pizza una volta al giorno, pur di risparmiare soldi per comprare dischi. Credo fossi uno dei DJ più magri al mondo ma in realtà la cosa funzionava a mio vantaggio perché in quegli anni per fare clubbing ci si vestiva in spandex e lycra come i ciclisti. Quando poi arrivarono dischi house a Roma cominciai a comprare pure nei negozi specializzati per DJ nella capitale. Spesso però la disponibilità era legata a poche copie e puntualmente con un paio di settimane di ritardo rispetto al resto d’Europa, per cui bisognava darsi da fare velocemente per trovare i pezzi nuovi ed era fondamentale fare amicizia coi negozianti altrimenti si restava a mani vuote. Eravamo abbastanza competitivi e quando alcuni dei titoli che suonavamo al Devotion divennero reperibili, li compravamo in blocco. Credo di avere ancora copie sigillate di “Devotion” dei Ten City nella mia collezione, alcune le ho regalate durante qualche serata nel corso degli anni.
Il Devotion mi diede la possibilità di fare il salto da “bedroom DJ” a “professional DJ”, fu la piattaforma e il momento ideale per proporre quel tipo di suono. Il nostro pubblico era estremamente eterogeneo ma il nucleo di chi ci seguiva religiosamente era un gruppo di persone, prevalentemente LGBTQ, provenienti dal mondo dell’arte e della moda, e questo facilitò l’introduzione del nostro concetto essendo loro già esposti a quel tipo di sonorità e modo di fare clubbing più internazionale. Dal primo istante in cui poggiai la puntina sul disco capii che questo suono avrebbe conquistato la mia città, la reazione fu a dir poco euforica, come se tutti finalmente avessero trovato il groove ideale per esprimersi liberamente. I pochi increduli cambiarono velocemente opinione e finirono anche loro sul nostro dancefloor. Nel 1987 il termine “house” era comunque un’assoluta novità, i mass media a copertura nazionale solitamente aspettavano (ed aspettano) lunghi periodi prima di convalidare un nuovo fenomeno. Dare spazio a linguaggi diversi comporta dei cambiamenti e in Italia l’introduzione di nuove idee non è necessariamente premiata. Forse ora le cose sono cambiate, non saprei dirlo con certezza perché ho lasciato l’Italia oltre venti anni fa, ma in quel momento l’insieme dei mezzi di comunicazione di massa era un circolo chiuso. La stampa musicale italiana in quegli anni era ancora prevalentemente interessata al rock e la maggioranza delle radio passava dischi da classifica, in molti casi ancora italodisco ed eurodisco. Solo in seguito al grande successo commerciale l’house suscitò attenzione nel nostro Paese, altrimenti sarebbe restata un fenomeno marginale. Io ascoltavo Radio Città Futura che trasmetteva a Roma e nel Lazio, e fu proprio così che conobbi Marco Militello, mio collega DJ e cofondatore del Devotion insieme ad Alessandro Gilardini che conduceva una trasmissione insieme a Marco Boccitto in cui proponevano un repertorio disco, soul, afrobeat e, occasionalmente, proto house. La maggior parte del pubblico comunque è arrivata alla house music tramite “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S. o “Ride On Time” dei Black Box, pezzi che personalmente ho trovato banali ma che hanno formato l’orecchio dozzinale della grande maggioranza della gente.

Paolo Di Nola e Joe al Devotion (Roma, 1987) in uno scatto di Federico Del Prete
Comunque è risaputo che le masse non siano depositarie di gusti sofisticati, e questo avviene non solo in Italia. La prima house, per definizione, venne coniata a Chicago, ed è quella a rappresentare la matrice originale del genere musicale. Racchiude in sé lo zeitgeist della propria generazione e il linguaggio del tessuto sociale da cui proveniva. Nella composizione dei primi brani non erano presenti molti campionamenti perché in quegli anni avere un campionatore a disposizione in un home studio non era così comune. Le tracce erano scarne ma era proprio questa l’innovazione e la forza sonora dell’estetica house, l’impatto di quel suono minimale ad alto volume era molto più diretto ed efficace rispetto alla dance prodotta precedentemente. La musica concepita dai DJ, inoltre, deriva spesso dalla sovrapposizione di suoni, ritmi e melodie, che poi è quanto accade in fase di mixaggio. L’uso del campionamento non è altro che il “riadattamento” della stessa tecnica in studio di registrazione. L’importante è la creatività applicata al metodo e Steve Reich ha cambiato il concetto di musica proprio tramite questo procedimento. Ora come ora, con l’uso del computer, ci sono intere generazioni di musicisti che usano solo manipolazioni audio con risultati eccellenti, l’importante è mantenere sempre una mente aperta rispetto all’innovazione, credo sia proprio ciò ad aver alimentato e mantenuto vivo lo spirito della house nella miriade di mutazioni a cui è andata incontro. Da non dimenticare un altro fattore: la house fu un fenomeno importato nel nostro Paese e come spesso accade in queste situazioni, gran parte della radice culturale viene persa durante l’assimilazione o reinterpretata non sempre nella maniera più corretta. Fu difficile replicarne fedelmente l’essenza perché la house non era solo una tipologia di musica ma un universo e stile di vita per intere comunità di persone. Inoltre, come in tutti i casi in cui si manifesta un grande ed immediato successo economico, entrarono in gioco gli imitatori nel tentativo di replicarne la formula magica. Poi c’era anche il problema degli studi: fare musica non era accessibile come oggi, bisognava avere un equipaggiamento tecnico difficile da reperire, costoso, si doveva conoscere il linguaggio MIDI e bisognava fare i conti con ingegneri del suono che raramente lasciavano carta bianca agli artisti. L’onda creativa avvenne dopo l’impatto commerciale, quando i DJ house italiani si dedicarono a suoni più deep, parallelamente all’avvento della techno, e ciò spinse l’house verso territori più underground e più melodici. Fu proprio tramite il vocabolario più familiare della melodia che gli italiani riuscirono spesso a distinguersi, trovando il giusto terreno per reinterpretare e fare proprio questo stile di musica».
Tra i DJ del Devotion, insieme a Paolo Di Nola, c’è anche il citato Marco Moreggia, uno dei fondatori de I Ragazzi Terribili, un gruppo di giovani attivisti che crea eventi a base di musica dance alternativa: «Iniziai ad organizzare serate nel 1985 ma frequentavo i locali sin dal 1978 e credo di aver vissuto la parte migliore della dance» racconta oggi. «La nuova “ventata musicale” per me giunse alla fine del 1986 e brani come “Move Your Body” di Marshall Jefferson o “Work It To The Bone” dei LNR mi fecero scorgere un mondo del tutto inedito. L’unico posto dove ebbi occasione di ascoltare un intero set di quel nuovo sound fu al Life 85, durante una serata del Devotion. In quel posto riecheggiavano pezzi come “Bring Down The Walls” di Robert Owens, “Taste My Love” di House To House, “I’m A Lover” di Kym Mazelle, “House Nation” di The Housemaster Boyz And The Rude Boy Of House, “In The City” di Master C & J, “Someday” di Ce Ce Rogers, “Mystery Of Love” di Mr. Fingers, “If You Should Need A Friend” dei Blaze e “Devotion” dei Ten City, giusto per citarne alcuni. Parallelamente al Devotion, nell’estate del 1987, con I Ragazzi Terribili allestimmo il parcheggio del Castello di Maccarese trasformandolo in un club house all’aperto, tutti i sabato. Con orgoglio posso affermare che le prime serate a base di house music, unite all’esigenza di trovare nuovi spazi che non fossero le classiche discoteche, partirono da Roma. Nonostante sia durato per solo due stagioni, il Devotion ha lasciato un segno molto forte. Al citato Life 85 facevano una selezione assai ferrea, la gente che voleva entrare era tantissima e quindi l’organizzazione si spostò presto all’Euritmia, una location dalla capienza maggiore e il primo spazio a prendere le distanze dai soliti club del centro della città, con particolare cura dell’impianto, delle luci, del bar e di tutto il resto, al punto da spronare le persone a macinare un bel po’ di chilometri per raggiungere il posto (in un periodo in cui spostarsi era tutt’altro che usuale) e vivere la serata in modo diverso. Poi, purtroppo, la situazione sfuggì di mano.

Documento di una delle serate organizzate da I Ragazzi Terribili
Noi, come I Ragazzi Terribili, prendemmo un vecchio dancing creando un pre-serata, altra cosa del tutto nuova perché in quel periodo se non erano minimo le 2:00 non si andava da nessuna parte. Il periodo della Riviera nacque pochi anni dopo ed affini al nostro stile c’erano DJ come Ralf e Flavio Vecchi coi quali ho poi instaurato un lungo rapporto sia d’amicizia che professionale. Personalmente ho cominciato a fare il DJ nel 1988 al Dream nato dalle ceneri del Saint James, primo locale gay in Italia, gestito poi da I Ragazzi Terribili. Mi considero un privilegiato perché entrai in quel mondo da una porta prioritaria, essendo una serata che curavo insieme al mio team. Il pubblico mi conosceva come organizzatore ma non era scontato che mi accettasse, come poi fortunatamente è successo, nel ruolo di DJ che in quel periodo era una figura molto territoriale. Il Dream era un piccolo club ma nonostante ciò lanciò i “fuori orario”, detti anche after hour, perché apriva alle 23:00 e chiudeva alle 11:00 (e a volte persino alle 12:00!) del mattino seguente. Ogni sabato, quindi, mettevo musica per circa dodici ore consecutive. Allora compravo i dischi a New York, da Vinylmania, Dance Tracks ed altri negozi nel Village dove mi recavo regolarmente diverse volte l’anno. A Roma arrivava poco e niente, solo i titoli più commerciali, quindi se volevi un certo suono te lo dovevi letteralmente andare a prendere, investendo parecchi soldi. A New York andavo per comprare i dischi e per farmi avvolgere da quella energia che solo lì potevi cogliere andando nei club a sentire dal vivo quei DJ che poi erano i produttori dei dischi stessi che mettevo alle mie serate. Ebbi la fortuna di assistere all’ultima performance di Larry Levan al The Choice insieme ad altre cinquanta persone, fu una serata memorabile. Nel biennio ’87-’88 gran parte della stampa italiana cominciò ad interessarsi all’house music, ma per molti giornalisti fu solo un modo per parlare di ecstasy e non di musica e della rivoluzione che quella stava portando nel mercato discografico. Da un certo punto in poi, quindi, ho proibito l’ingresso con macchine fotografiche e videocamere alle mie feste, per evitare che gli ospiti si ritrovassero coinvolti in articoli compromettenti. È giusto ricordare però che non tutti i giornalisti volevano fare notizia sbandierando l’uso di droghe. A tal proposito feci una lunga intervista con Enrico Lucherini che rappresentava in modo eccelso l’ufficio stampa del cinema sulle pagine de Il Messaggero. A seguire una rubrica sulla stessa testata di Pietro D’Ottavi ed un’altra, neonata, sul Trovaroma curata da Stefano Cillis, i quali seguivano tutto con molto interesse e professionalità. Le radio invece arrivarono dopo.

Marco Moreggia in consolle al Coliseum (1990)
A cavallo degli stessi anni a Chicago nacque l’acid house che prese presto piede a Londra ma anche noi a Roma, con I Ragazzi Terribili, la proponemmo con molto successo. Nel 1988 Margaret Thatcher, primo ministro del Regno Unito, bandì dalle radio la programmazione di brani acid house ed era persino proibito indossare indumenti che avessero il simbolo dello smile perché rievocava l’uso di ecstasy e degli acidi. Proprio quell’anno tornai a Londra (dove avevo vissuto sino al 1985, quando la musica era focalizzata sul dark, new wave e new romantic) e all’uscita di un locale vidi un gruppetto di amici. Gli andai incontro per salutarli e da lontano mi fecero gesti per bloccare il mio entusiasmo perché nelle immediate vicinanze c’era una camionetta della polizia. I poliziotti erano lì per controllare se qualcuno rivelasse, col proprio atteggiamento, di aver assunto sostanze stupefacenti. In tal caso lo avrebbero portato in caserma. Da lì a breve, come reazione a questo clima di repressione, nacquero i rave. Inizialmente l’house non venne presa sul serio da molti e solo una ristretta nicchia di persone capì il grande potenziale di quel nuovo genere. I giudizi ricorrenti erano sempre gli stessi, come “ma che musica è questa?” o “sembra tutta uguale!”, e l’attenzione di molti si limitò giusto ai brani più commerciali. Mancava insomma il voler approfondire la vastità delle produzioni, la ricerca del suono e la presenza di grandi voci emerse in quel momento storico. Purtroppo lo snobismo musicale che prima toccò altri generi fu riservato anche alla house, c’era addirittura chi ne decretò la morte già nel 1990, facendoci subito dopo la propria fortuna. Ci volle qualche anno prima che i produttori nostrani iniziassero a produrla, io stesso necessitai di tempo per assimilarla. Mi sentii pronto per fare il primo passo in discografia solo nel 1991, quando uscì “I Know Love’s On Earth” del mio progetto Three-Bu. Tra i maggiori impedimenti senza dubbio quello dell’assenza cronica di cantanti, tuttavia sono convinto che quella italiana resti una grande scuola di DJing che ha mantenuto una forte dignità artistica e che non è seconda a nessuno».
Emilia-Romagna
La house music viene irradiata con tempismo anche in Emilia-Romagna, una delle regioni cardine del clubbing italiano. Autorevole testimonianza giunge da uno dei DJ capostipiti, Flavio Vecchi: «Non rammento esattamente il momento preciso in cui entrai in contatto con la house music, ricordo che correva il 1986 e suonavo al Kinki di Bologna. Conobbi quel nuovo genere attraverso delle musicassette che un amico mi spediva da New York. Erano registrazioni di un programma radiofonico, credo su Kiss FM, che si collegava in diretta col club Zanzibar a Newark, in New Jersey, dove suonava Tony Humphries. Insieme ad un ristretto gruppo di amici, iniziai quindi ad ascoltare house music e da lì a breve cominciò la caccia ai titoli. Il primo disco house che comprai fu “Ma Foom Bey” di Cultural Vibe, a seguire quelli della Trax Records come “Move Your Body” di Marshall Jefferson, “Let’s Let’s Let’s Dance” di Keynotes, “Tell Me (That You Want Me)” di West Phillips, “House Ain’t Givin Up” di BnC e “Go Bang” di Dinosaur L. Nel negozio che frequentavo, il Disco D’Oro di Bologna, arrivava un magazine quindicinale chiamato Echoes sul quale venivano pubblicate le prime underground house chart: consultavo con attenzione quelle classifiche insieme ad Achille ‘Aki Tune’ Franceschi (che lavora ancora lì!) il quale ordinava tre o quattro copie di quei titoli che ci parevano i più interessanti. Poi aspettavamo con ansia che arrivassero per poterli proporre durante le serate. I miei primi dischi house li comprai proprio al Disco D’Oro ma quando, nell’estate del 1986, iniziai a suonare in riviera cominciai ad andare pure al Disco Più di Rimini. Non mancavano viaggi a Londra, da dove tornavo con dischi non ancora reperibili in Italia. Non ero certamente l’unico DJ in Emilia-Romagna ad interessarsi di house music ai tempi, ma come dicevo prima il gruppo era veramente circoscritto a cinque o sei persone. Non conoscevo la realtà al di fuori della mia regione perché la mia attività da DJ non mi consentiva ancora di viaggiare per l’Italia, ma quando aprimmo le porte dell’Ethos Mama di Gabicce, nel 1987, mi resi conto di essere assolutamente un pioniere di quella nuova musica, come del resto lo era l’Emilia-Romagna. Lo capii perché nell’arco di breve tempo all’Ethos Mama veniva a ballare gente proveniente da tutto il Paese.

L’ingresso dell’Ethos Mama Club
Iniziai a suonare i primi dischi house nel 1986 al Kinki di Bologna e qualcosa alla Villa Delle Rose di Riccione, durante l’estate dello stesso anno, dove proponevo anche soul, r&b ed hip hop visto che in circolazione non c’era ancora molta house che mi piaceva. Ricordo reazioni positive da parte del pubblico e a tal proposito rammento un pensiero che feci: una volta che il pubblico “assaggiò” il nuovo tipo di cassa, dimostrando di gradirla, non sarebbe più stato possibile non offrirgliela più. Era una specie di punto di non ritorno e in effetti è stato proprio così visto che dopo pochi anni anche artisti pop iniziarono a pubblicare remix realizzati da DJ e produttori provenienti dal mondo house. Tra 1987 e 1988 comunque le uniche informazioni sulla house underground le reperivo sempre e solo al Disco D’Oro dove Achille riusciva a far arrivare con regolarità diverse riviste musicali inglesi ed americane dove venivano riportati nuovi titoli e nomi di produttori e DJ da tenere d’occhio. L’Italia ci mise un po’ per capire cosa fosse l’house music, semplicemente perché si trattava di un genere non nato entro i nostri confini. La mia prima collaborazione in una produzione house risale al 1990 (“House Of Calypso” di Key Tronics Ensemble Featuring Double J. Flash, nda) a cui seguirono parecchi dischi tra ’91 e ’92 alcuni dei quali sono ora considerati dei classici (cito fra tutti il Vol.1 e il Vol. 2 di Riviera Traxx, prodotti e composti insieme a Ricky Montanari e Kid Batchelor). Conservo ancora trafiletti di riviste britanniche e statunitensi in cui vennero citate le nostre produzioni, e recentemente alcuni nostri brani sono stati ristampati o inseriti in nuove compilation, a testimonianza che noi italiani imparammo presto e bene a comporre house music di buon livello».
Il citato Achille Franceschi (meglio noto come Aki Trax o Aki Tune) è un altro dei primi DJ, in Emilia-Romagna, a proporre house music. «La scoprii per caso. L’assoluta scarsità di informazioni in merito non permetteva infatti di capire esattamente cosa fosse» racconta oggi Franceschi. «Nella tarda primavera del 1986 iniziai a comprare dischi da Groove Records, a Londra, e la maggior parte riportava la scritta “house of Chicago” in copertina. La cosa mi incuriosì e da lì a poco mi resi conto che stessi suonando, inconsapevolmente, house music. Nell’arco di pochi mesi acquistai decine di quei mix, quasi tutti provenienti da Chicago. I miei preferiti? “Mystery Of Love” di Fingers Inc., “Your Love” di Frankie Knuckles, “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders e “Free Yourself” di Virgo. Iniziai a proporli al Lilì Marleen di Misano Adriatico (poi trasformato in Vae Victis ed Echoes) e al Graffio di Modena, supportato dall’entusiasmo del pubblico. In Emilia-Romagna c’erano anche altri DJ interessati come me a quel fenomeno musicale, Maurizio Tangerini, Flavio Vecchi, Pier Del Vega e Renzo Master Funk. In quel periodo la house era un fermento totalmente sotterraneo. Il successo di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S. poi aprì la strada a produzioni più commerciali che nel giro di un paio di anni, a mio parere, snaturarono del tutto l’essenza della stessa house music».

Il biglietto del concerto di Afrika Bambaataa organizzato da Il Graffio (dall’archivio personale di Marinella Mattioli)
Un paio di anni prima che la house music giungesse in Italia, a Modena apre un locale “di educazione all’intrattenimento”, così come lo descrive uno dei fondatori, Alessandro “Jumbo” Manfredini, in questo breve articolo di Laura Solieri del 3 settembre 2012. Appartenente al circolo Arci, il Graffio diventa in breve un ritrovo giovanile dove sperimentare allestimenti, proiettare film e proporre musiche alternative come hip hop ed house. «”Devotion” dei Ten City era uno dei pezzi che riempiva di più la pista del Graffio» ricorda oggi Manfredini, che in quel periodo milita nella band dei Ciao Fellini. «Fu la mia palestra coi maestri Maurizio Tangerini ed Achille Franceschi alias Aki Trax, un posto per anime libere e scevre da ogni preconcetto nei confronti di nuovi sound, che rappresentava una situazione abbastanza anomala almeno in Emilia, visto che in riviera alcuni DJ, come Renzo Master Funk, avevano già dato il loro contributo alla causa house. Ai tempi attivammo i contatti anche con altre realtà attraverso la sigla O.N.U. (acronimo di One Nation Underground) creando un circuito di locali “alternativi” dove poter trovare un’offerta musicale diversa dal mainstream. La house però era ancora per pochi, e dischi di quel genere ne arrivavano in quantità ridotta. I miei punti di riferimento erano l’American Records di Roberto Attarantato e il Disco Inn di Fabietto Carniel. Nel 1987 l’uscita di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S. aprì sicuramente gli orizzonti a molte persone seppur la culla della house fosse Chicago e non Londra, ma all’inizio in pochi capirono l’importanza di questo genere nato in America. Probabilmente vi era un’incapacità diffusa di interpretare la portata e la potenza culturale che poi quella musica avrebbe avuto. Non a caso per prendere dimestichezza con la house, i produttori italiani impiegarono del tempo perché non era in linea col percorso, sia creativo che di business, dell’italodisco che in quel momento imperava ancora».

L’allestimento dedicato al surrealismo allestito al Graffio nel 1986. Foto di Ernesto Tuliozi, gentilmente concessa da Alessandro Manfredini
Originario dell’Emilia-Romagna, seppur trapiantato da anni nel Lazio, è pure Maurizio Clemente, produttore del documentario “Italo House Story” (di cui si è fatto cenno qui) che mette ordine, in tempi non sospetti, nella storia della cosiddetta spaghetti house nostrana. «Conobbi la musica house nel 1987 circa, grazie agli amici DJ Ricky Montanari e Cirillo e alle registrazioni in cassetta di vari radio show newyorkesi, come quello di Tony Humphries allo Zanzibar. Un paio di anni più tardi approcciai anche alla discografia grazie all’amicizia con Kid Batchelor e Giorgio Canepa alias MBG. Lavorare nel campo della musica è sempre stato il mio sogno quindi fui coinvolto praticamente all’istante sia grazie a Batchelor, col quale andai negli studi londinesi della Warriors Dance (dove, tra l’altro, i Soul II Soul incisero la loro hit “Keep On Movin”), sia grazie ad MBG che aveva un piccolo studio di registrazione, pilotato dal Commodore 64, con cui alimentava una label distribuita da Severo Lombardoni, la MBG International Records. Su quella label nel ’90 uscì “The Chance” di Optik, un disco realizzato a quattro mani dallo stesso MBG e Montanari a cui collaborai pure io, in un secondo momento, come business manager. Conclusi una licenza esclusiva in Belgio con la Dancyclopaedia negoziandola con Rudy De Waele, oggi autorevole figura della cultura digitale.

Cirillo e Ricky Montanari nel 1984 a Berlino, durante un viaggio all’estero per comprare dischi (foto gentilmente concessa da Maurizio Clemente)
Col tempo la mia attività si irrobustì: nel ’92 fondai la Causa Effetto Italia e le etichette Zippy Records e Rena Records a cui fece seguito, nel 1994, la Nite Stuff, col supporto della Flying Records di Napoli. La società campana poi mi affidò pure il ruolo di A&R della UMM, affiancando Angelo Tardio e Giuseppe Manda. Facendo un passo indietro rispetto a tutto ciò però, ritengo che il citato Lombardoni della Discomagic sia stato un personaggio chiave per la house made in Italy di quegli anni. Senza di lui non ci sarebbe stata la diffusione della piano house in Europa e nel mondo intero. In Emilia-Romagna la prima House Convention venne organizzata al Tino di Massa Lombarda nel 1987, poi ripetuta all’Ethos Mama di Gabicce Mare. I primi underground house party, che non erano neanche organizzati in discoteca, però risalgono al periodo 1989-1990.

Il flyer della seconda House Convention svoltasi al Tino di Massa Lombarda (provincia di Ravenna) l’11 novembre 1987 (su gentile concessione di Maurizio Clemente)
A Rimini c’erano diversi giovani DJ che cercavano di emergere da quel sottobosco perché non trovavano spazio nei generi musicali in auge allora promossi dalle radio. Nel movimento underground era in voga anche la “afro” del Cosmic di Verona (oggi associato erroneamente all’italodisco) e de La Mecca. I DJ di riferimento erano Peri, T.B.C. (Claudio Tosi Brandi), Daniele Baldelli, Claudio ‘Moz-Art’ Rispoli, Rubens, L’Ebreo e Spranga. I primi party in assoluto che organizzammo con la house però erano vuoti, ma la gente cominciò presto a capire questa musica e ad apprezzarla fino a riempire anche i club della collina di Riccione che all’inizio erano piuttosto riluttanti. Dopo le difficoltà iniziali noi appassionati e promotori cavalcammo questo genere musicale come un cavallo di Troia per entrare nel mercato dei club mediante i DJ resident dei locali più famosi di Rimini, visto che la house iniziò ad essere richiesta dal pubblico in tutte le discoteche e non più solo in quelle specializzate. I primi DJ che ho fatto ingaggiare a Londra, ad esempio, suonavano all’Echoes di Gabicce. Ai tempi non era facile seguire i trend di tutto il mondo e per questo ero spesso in viaggio per conto dei proprietari ed art director delle discoteche con cui collaboravo (Gianluca Tantini dell’Ethos, Gianni Nistico del Peter Pan, Gianni Fabbri e Renato Ricci del Paradiso, Pascià e Pineta, Luca Carrieri del Cellophane) proprio per intercettare nuove tendenze musicali. Allora non c’era internet, le uniche fonti di informazione erano il telefono e la stampa di settore, principalmente straniera. Sapevamo che a Roma ci fosse un movimento house intorno al Devotion di cui si parlava tanto anche perché gli organizzatori invitavano artisti come guest dagli Stati Uniti. Noi li seguivamo sperando di poter replicare, un giorno, quelle proposte artistiche internazionali anche in provincia, magari organizzando un unico tour nazionale ed agganciandoci a Roma per dividere le spese, visti soprattutto gli alti costi dei biglietti aerei. A dare spazio alla house music prima dell’esplosione commerciale furono diverse emittenti radiofoniche locali che riuscivano ad avere ospiti in esclusiva come ad esempio i Ten City che io stesso portai in una piccola radio di Riccione di cui non ricordo più il nome.

Il flyer (gentilmente concesso da Maurizio Clemente) della terza House Convention svoltasi presso l’Ethos Mama Club il 24 dicembre 1987. In evidenza, al centro, un motivo grafico già apparso sul precedente che rimanda alla serie “The House Sound Of Chicago” varata dalla D.J. International Records nel 1986
Uno dei brani che fece uscire la house dal territorio prettamente underground fu “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S.: pur non essendo ancora musica da classifica radiofonica, quel genere iniziò a riempire le mega discoteche di allora e ritengo fu molto positivo. Non mancò ovviamente chi accusò la house di essere “falsa” perché fondata sull’uso di campionamenti, ma credo che ciò dipenda dall’annosa questione legata all’utilizzo del computer per produrre musica. A tal proposito ricordo di cantanti, più o meno famosi, che interpretarono dei pezzi house e che si arrabbiarono molto quando si resero conto di essere stati rimpiazzati negli eventi live dai DJ. Dal punto di vista della produzione invece i musicisti venivano ingaggiati perlopiù come turnisti, a volte senza neanche nessun riconoscimento tra i credit (a tal proposito si rimanda a questo approfondimento, nda). Il computer e la house music fecero in modo che un brano fosse interamente prodotto da una sola persona, il DJ, e questo ribaltò gli equilibri già allora in bilico e che oggi, con internet, sono sconvolti ancora di più. Noi italiani comunque fummo secondi solo rispetto all’Inghilterra nella produzione di musica house, in quanto avevamo alle spalle una storia di disco ed italodisco che aprì le porte all’import-export, e questo ne facilitò la divulgazione. Per tale ragione l’italo house fu importante per la scena internazionale, così come lo furono i club italiani che per primi iniziarono ad ingaggiare DJ guest internazionali dando maggiore visibilità alla nostra nazione e al settore dell’intrattenimento di allora».
Umbria
Anche il “cuore verde” dello Stivale, l’Umbria, ricopre un ruolo importante nella diffusione della house. La vicinanza con il Lazio ha generato una specie di ping pong tra alcune realtà da diventare determinante per futuri sviluppi. Nome statuario è quello di Antonio Ferrari noto come Ralf, nato a Bastìa Umbra, in provincia di Perugia, che racconta: «Sono curioso ed attento di natura ma nei primi anni Ottanta non frequentavo le discoteche, erano posti in cui passava musica a mio avviso indigesta. Preferivo di gran lunga i club del rock alternativo, dove peraltro iniziai a lavorare selezionando cose molto eterogenee, da Stevie Wonder a Barry White e i Clash passando per roba ska, punk, funk e il primo hip hop. Ci fu un periodo in cui feci incetta del repertorio funk/soul specialmente statunitense e britannico, con titoli per me completamente sconosciuti. Alla house invece arrivai attraverso “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders: era il 1986 e per me fu una vera e propria illuminazione. Ad aprirmi quel mondo nuovo furono le riviste estere che acquistavo regolarmente, New Musical Express, The Face, Melody Maker e i-D, sempre molto attente alle nuove tendenze. Parallelamente a mostrare interesse per la house fu l’amico Vincenzo Viceversa che veniva da un background di musica parecchio dura come industrial, EBM e punk. Non ricordo altri in Umbria. Al di fuori dei confini regionali invece c’erano i ragazzi del Devotion, a Roma, ed anche alcuni DJ in Emilia-Romagna come Aki Trax, Renzo Master Funk, Flavio Vecchi, Ricky Montanari e Wayne Brown. All’inizio però era dura. Iniziai in un piccolo locale a Lacugnano, lì dove facevo coppia con Viceversa, ma le reazioni del pubblico furono negative. Scommisi tutto sulla house facendo incetta di dischi e realizzando set interamente basati su quel genere ma nell’arco di poche settimane mi ritrovai senza stipendio, la gente non apprezzava affatto. Le cose cambiarono quando approdai all’Ultra Violet, un posto che mi garantì un bel successo. In seguito sarei approdato al Matmos di Milano, al Plegine di Firenze, all’Ethos Mama di Gabicce e al Matis di Bologna, praticamente i templi house italiani. I primi dischi house li comprai da Musica Musica, un negozio di Ponte San Giovanni. A seguire da Mipatrini e da DJ News. Erano tutti abbastanza forniti e con le mie continue richieste credo di aver stimolato, in qualche modo, anche i negozianti a richiedere quel tipo di musica. Nel momento in cui cominciai a lavorare al di fuori dei confini regionali, iniziai a frequentare il Disco Più di Rimini e il Disco Inn di Modena, i due negozi più forniti d’Italia. Non mancavano però viaggi a Londra, dove mi fiondavo da Catch A Groove e Black Market Records, e a New York, dove invece andavo da Hard To Get e Vinylmania, dove si potevano incrociare tantissimi DJ della Grande Mela. Ricordo però che una volta da Vinylmania (la cui storia si può leggere qui, nda) accadde una cosa singolare: chiesi dischi di musica house ma non comprendevano affatto cosa volessi. Per loro quella era semplicemente “dance music”, analogamente a quanto avveniva in Italia, sin dai tempi dell’italodisco. Non c’era ancora una grande consapevolezza di ciò che stesse avvenendo, e prima del successo di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S., ad esempio, da noi praticamente nessuno mostrò interesse per la house, sia a livello locale che nazionale, se non qualche sparuta realtà. Quando emerse il fenomeno del sampling il campionatore divenne lo strumento principe della house e molti la sposarono per moda ed interesse economico. Seppur nata negli States però, il fenomeno venne pilotato dalla Gran Bretagna, autentico volano del movimento house come fu la Germania per la techno. Noi italiani, comunque, non siamo stati da meno e ci facemmo ben notare, con neanche tanto ritardo rispetto ad altre nazioni. Non a caso oggi si parla di italo house come filone identificativo e rispettato anche oltre i confini».
Un altro nome preponderante della scena umbra è quello di Vincenzo Viceversa, già citato da Ralf poche righe fa ed intervistato qui qualche anno addietro. Ricontattato oggi, il DJ rammenta il suo primo contatto con la house music che avvenne «tra il 1986, anno di chiusura del Svbvrbia, e il 1987, attraverso riviste internazionali come The Face, i-D e New Musical Express, di cui ero assiduo lettore, che segnalavano questo nuovo “trend” con recensioni ed articoli di costume. I primi dischi house che mi folgorarono realmente e mi fecero sposare la causa furono “House Nation” di The Housemaster Boyz & The Rude Boy Of House, “Let’s Get Brutal” di Nitro Deluxe e “The Morning After” dei Fallout (ma anche il remix di “Behind The Wheel” dei Depeche Mode realizzato da Shep Pettibone, con un lungo intro simil-acid), in qualche modo mi ricordavano “Metal On Metal” dei Kraftwerk, “Planet Rock” di Afrika Bambaataa & Soulsonic Force, alcuni remix dei Front 242 ed altre cose electro dell’epoca come “Egypt, Egypt” di Egyptian Lover, “Breaker’s Revenge” di Arthur Baker o capolavori visionari come “Metal Dance” degli SPK e varie cose dei Cabaret Voltaire e di Chris & Cosey, tutti pezzi di matrice elettronica che già proponevo al menzionato Svbvrbia. Per me avvicinarmi a quel genere, nuovo e nero che si stava creando oltreoceano, fu una naturale evoluzione. Tracce elettroniche realizzate interamente con macchine e cantate esistevano già ed erano prodotte principalmente in Europa, ma quando le periferie americane dissero la loro cambiò tutto. Condivisi l’attrazione per la house inizialmente con Ralf, col quale ero in stretto contatto in quanto collaboratore degli stessi locali in cui lavorava come il Norman a Lacugnano, dove organizzammo i primi venerdì house underground della regione. In seguito si aggiunse Sauro Cosimetti. Ralf si avvicinò alla house perché appassionato di musica nera, io in virtù dell’amore per l’elettronica e la sperimentazione, Sauro invece per la via “afro”. Gettando uno sguardo al di fuori dei confini regionali, credo che tutto nacque a Roma col Devotion che adottò un concept praticamente contemporaneo con una location alternativa, un sound system potente, proiezioni visual (attraverso l’uso di diapositive) e musica house pura al 100% dato che i vari Militello, Di Nola e Gilardini in quel periodo vissero o frequentarono New York e locali come il Paradise Garage, oltre ad avere rapporti diretti con David Piccioni del Black Market di Londra. Le preziosissime copie dei primi dischi house americani arrivarono a Perugia proprio grazie a loro. Gilardini inoltre scriveva per il giornale Fare Musica e ricordo una sua intervista a Larry Levan. Attraverso la sua intercessione, realizzai pure io alcuni articoli per la stessa testata, tra cui uno sull’evoluzione EBM/new beat, ed uno su Fela Kuti per cui feci il DJ in after show nel 1988 al Quasar. Così come Ralf, anche io andavo da Musica Musica ma per fare vero shopping discografico era necessario volare a Londra. Ricordo, ad esempio, che di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S. ne arrivò solo una copia a Perugia. La comprai ma attratto dall brano inciso sull’altro lato, “Anitina (The First Time I See She Dance)”. Solo in seguito la band esplose per “Pump Up The Volume”, un pezzo fatto per gioco in una notte con l’intento di riempire la facciata del disco, testando il nuovo campionatore acquistato dallo studio di registrazione della 4AD usufruendo dei dischi a portata di mano. I M.A.R.R.S. furono fondamentali per la diffusione europea della house, ma senza dimenticare il successo mondiale di “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders e di “Respectable” di Mel & Kim. Il campionatore divenne uno strumento a tutti gli effetti e venne aggiunto all’equipment in uso negli studi di incisione. In Italia la house fu di fatto una evoluzione dell’italodisco che, a sua volta, si rivelò fonte d’ispirazione per la scena americana, basti pensare a “Dirty Talk” di Klein & MBO o a “Problèmes D’Amour” di Alexander Robotnick. Quando Di Nola mi disse che “Problèmes D’Amour” era un cult nel circuito di New York e Chicago, mi venne l’idea di fare un remix e mi recai alla sede della Materiali Sonori, a San Giovanni Valdarno, ma lì mi dissero che non avevano né DAT, né nastri e tantomeno una copia del 12″. Credo che i fratelli Bigazzi allora ignorassero quanto quel disco fosse speciale, per loro era solo un vecchio pezzo che non aveva venduto molto. Le mie prime serate house le feci al citato Norman, ma all’inizio il pubblico in Umbria era schifato da quella musica, solo pochi eletti si rivelarono estaticamente entusiasti. Roma invece era al top grazie al Devotion».
Lombardia / Veneto
Una parte del cuore del settentrione nostrano inizia a battere presto per la house music. Operativo tra Lombardia e Veneto, seppur le sue prime incursioni house, come si vedrà tra poco, avvengano prevalentemente ad Ibiza, è il citato Leo Mas che racconta: «Scoprii la house nel 1985 attraverso dischi come “Trapped” di Colonel Abrams, “Music Is The Key” di J.M. Silk, “Jam Tracks” di Kenny “Jammin” Jason e “Funkin With The Drums” di Farley “Jackmaster” Funk. Non ricordo in che modo giunsi ad essi, forse dopo aver letto qualche articolo relativo alla scena di Chicago sulla rivista The Face, la mia fonte d’informazione per tutti gli anni Ottanta. I primi dischi li trovai da Non Stop, il più grosso importatore d’Italia, in Via Quintiliano, a Milano, dove comunque erano disponibili poche copie ed ovviamente non di tutte le uscite. In quel momento il genere non era ancora definito, conosciuto ed etichettato, e quel tipo di produzioni, ai meno attenti, potevano sembrare frutto e parte del mondo electro o, nel caso di Colonel Abrams, persino del pop. Il fenomeno house iniziò a raccogliere una certa importanza solo nel 1986, tra Gran Bretagna ed Ibiza. Iniziarono a circolare più produzioni di quel nuovo sound e la compilation “The House Sound Of Chicago”, edita dalla D.J. International Records, a mio avviso fotografò perfettamente il genere con una tracklist di future mega hit (da “Jack Your Body” di Steve “Silk” Hurley a “Mystery Of Love” di Fingers Inc. passando per “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders e “Move Your Body (The House Music Anthem)” di Marshall Jefferson, nda), senza dimenticare le pubblicazioni della Trax Records e di altre svariate etichette nate proprio quell’anno. Fino all’estate del 1987 i centri di irradiamento, come dicevo prima, furono Ibiza e Regno Unito, poi la diffusione del genere iniziò ad allargarsi al mondo intero. Per lungo tempo le mie fonti restarono sempre e solo le riviste musicali britanniche, oltre al menzionato The Face anche i-D, New Musical Express e Record Mirror. Che io sappia, nessuna testata giornalistica nostrana affrontò l’argomento house music prima del successo internazionale di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S., che fu determinante per far conoscere il genere al grande pubblico seppur fosse una produzione inglese che non rispecchiava affatto quella che invece era la house di Chicago, pur possedendo alcuni elementi di quel filone, come i campionamenti. A “Pump Up The Volume” peraltro è legato un divertente aneddoto: poco prima dell’uscita del disco dei M.A.R.R.S., scelsi come nome d’arte Leo Mars, variazione del mio cognome anagrafico, Marras, a cui tolsi le lettere doppie. Da amante della conquista dello spazio e di tutto ciò che riguarda la space age, Leo Mars mi parve davvero perfetto, ma dopo l’uscita di “Pump Up The Volume” chiunque avrebbe potuto pensare che avessi copiato Mars dai M.A.R.R.S., e quindi a quel punto decisi di eliminare anche la R e diventai Leo Mas.
La prima volta che ho proposto house music fu nell’estate del 1985, all’Amnesia di Ibiza, con Alfredo. La alternavo a pezzi come “(I Like To Do It In) Fast Cars” di Z Factor, “Problèmes D’Amour” di Alexander Robotnick, “Al-Naafiysh (The Soul)” di Hashim, “Looking For The Perfect Beat” di Afrika Bambaataa & Soulsonic Force e “Clear” di Cybotron, tutti del 1983, che comprai quando non facevo ancora il DJ. Replicai nello stesso posto l’estate successiva, contando su più dischi a disposizione, anche se alla fine restavano insufficienti per reggere l’intera serata giacché mettevamo musica per ben nove ore quotidiane, da mezzanotte alle nove del mattino seguente, senza ospiti, che invece iniziarono a giungere solo nel 1990, per appena uno o due party stagionali (e a tal proposito ricordo il compianto Paul “Trouble” Anderson e Pete Heller). Quei brani quindi finivano irrimediabilmente nel mezzo del programma musicale. Poi di comune accordo con Alfredo, nell’estate ’87, quando la quantità delle produzioni aumentò sensibilmente, suonammo musica house da 116 a 127/130 bpm per ben tre ore consecutive, in cui la tensione sonora raggiungeva l’apice, e fummo i primi a farlo in Europa. Consumato quello sprint di energie, il ritmo tornava a calare per raggiungere i 110 (ed anche meno) bpm, e pure quel momento era assai speciale ed emotivamente coinvolgente, complice la struttura stessa del locale. L’Amnesia infatti era un club open air, fino al 1990 anno in cui venne chiuso (analogamente al Ku) perché non fu più permessa l’attività di discoteche all’aperto sull’isola. Nell’estate del 1987 arrivarono i DJ britannici come Paul Oakenfold, Danny Rampling, Nicky Holloway e Johnny Walker che portarono oltremanica praticamente tutto quello che noi suonammo in quei mesti estivi. Da ricordare anche Nancy Noise, nostra cliente già dall’estate ’86, poi al fianco di Oakenfold al Future, uno dei primi club house/balearic londinesi insieme allo Shoom di Rampling. Poiché Londra rappresentava un “faro” per tutto il mondo, specialmente nell’ambito delle tendenze musicali, da quel momento l’house music cambiò le dancefloor e il modo di vivere la notte a livello planetario, innescando di fatto un’autentica rivoluzione senza precedenti. Ci terrei anche a ricordare che nel genere house, fino all’uscita sulla 10 Records, sublabel della Virgin, della compilation “Techno! The New Dance Sound Of Detroit”, rientravano anche le produzioni made in Detroit, su Transmat, Metroplex, KMS ed altre etichette indipendenti della motor city. Si trattava insomma di un genere unico, non esisteva alcuna distinzione tra i dischi di Chicago e quelli di Detroit. Solo dopo l’uscita di quella compilation, a metà estate del 1988, la seconda “Summer Of Love”, la musica che proveniva da Detroit sarebbe stata etichettata come techno.

Leo Mas e Vasco Rigoni, art director del Macrillo
Provai una grande emozione quando all’Amnesia, nel 1987, suonavamo “House Nation” di The Housemaster Boyz And The Rude Boy Of House, vidi l’intera dancefloor con le mani in alto e in quell’istante percepii che stesse accadendo qualcosa di grande ed epocale. L’entusiasmo del pubblico fu sempre in crescendo, tra 1985 e 1986, ma nel 1987 divenne davvero devastante. Quell’anno iniziai a fare il DJ anche in Italia (dopo precedenti occasionali esperienze in qualche club in Emilia-Romagna) ed approdai al Macrillo di Asiago, diretto da Vasco Rigoni. A suggerirgli il mio nome e quello di Alfredo fu Mauro Bondi che organizzava le feste ibizenche al Pineta di Milano Marittima dopo la stagione estiva sull’Isla Blanca, e che poi aprì il Pascià a Riccione. Rigoni coinvolse anche gran parte dell’animazione del Pacha e del Ku. Molti clienti del Macrillo quindi conoscevano già il nostro sound perché frequentavano Ibiza, e mostrarono fortissimo entusiasmo quando si resero conto che non serviva più né attendere l’estate per ballare quella musica, né tantomeno volare nell’isola balearica. Era una situazione eccitante ma soprattutto unica perché, sino al 1987 circa, nelle discoteche italiane i DJ raramente superavano i 116/118 bpm. Come tutti i generi musicali che hanno innescato delle rivoluzioni, anche la house music era legata ad una sostanza stupefacente, l’MDMA, giunta ad Ibiza a fine ’86 da New York e poi prodotta in Olanda dal 1987, anno in cui il consumo aumentò esponenzialmente nell’isola proprio con l’avvento della rivoluzione house in atto (mentre in Italia non si sapeva ancora nulla, l’MDMA entrò nella tabella delle droghe solo nel 1989 dopo un mega arresto avvenuto al Movida di Jesolo). La combinazione house-droga amplificò ulteriormente l’esplosione del genere nei club. Per quanto riguarda le produzioni, noi italiani abbiamo dato presto la nostra interpretazione riuscendo a creare una “nostra house”, amata e riconosciuta ancora oggi da svariati DJ internazionali».
Piemonte
Dopo l’esperienza discografica nei Talk Of The Town di cui abbiamo già parlato qui, Roberto Pezzetti, da Novara, scopre la house music e si trasforma in Jackmaster Pez, cavalcando da protagonista buona parte degli anni Novanta. «Sino a poco tempo prima ascoltavo prevalentemente rock psichedelico e le cose appartenenti alla coda finale della new wave, inclusi brani di gruppi come A.R. Kane e Colourbox, dalla cui collaborazione poi nacquero i M.A.R.R.S.» racconta oggi. «Tolti Michael Jackson, Madonna e Prince, nel 1987 in Italia imperava ancora l’italodisco a cui mi ero avvicinato attraverso il progetto Talk Of The Town prodotto nel Logic Studio dei fratelli La Bionda. Alla house giunsi attraverso “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk (dal quale “presi in prestito” un pezzo del mio pseudonimo), uscito nel 1986. Da lì iniziò l’invasione della house di Chicago (D.J. International Records, Trax Records), poi Detroit rispose con la techno, senza dimenticare i paralleli fenomeni acid e garage, ma all’inizio tutti questi generi trovarono parecchia resistenza, almeno nella mia regione, il Piemonte. I primi confronti coi colleghi di studio, coi discografici e con gli altri membri dei Talk Of The Town furono decisamente deludenti. Nessuno di loro provava lo stesso feeling emozionale che percepivo io ascoltando quelle tracce, e mi gelarono con commenti tranchant tipo “ma questa non è musica, è solo una combinazione elementare tra drum machine e synth!”. La svolta, per me del tutto inaspettata, avvenne nel 1988, precisamente ad agosto quando mi trovavo all’Isola d’Elba, durante una pausa del tour dei Talk Of The Town. Andai in una discoteca dove si ballava house music, programmata e mixata dall’amico Miki The Dolphin, e quella serata accese in me la miccia. Tornato a Milano, conobbi Leo Mas che suonava al Macrillo di Asiago, in una “dodici ore non stop” organizzata dall’indimenticabile Vasco Rigoni. Lì, insieme a lui, anche i primi DJ guest ibizenchi. Da quel momento per me sarebbe stato un costante crescendo. A settembre ’88 iniziai a comprare dischi house con regolarità, prima dai distributori e da negozi occasionali, poi dal Disco Più di Rimini che mi spediva settimanalmente delle cassette coi demo delle nuove uscite per facilitare gli ordini a distanza. In seguito il mio fornitore divenne, per almeno un decennio, Fabietto Carniel del Disco Inn di Modena. Ai primi dischi house è legato un ricordo indelebile: dopo una serata trascorsa al Macrillo con l’amico Johnson Righeira, acquistai in un piccolo negozio di dischi “Strings Of Life” di Rhythim Is Rhythim (Derrick May), e rimanemmo entrambi folgorati. Ancora oggi, dopo oltre trent’anni, quel disco lo ho ancora nel flight case. Giusto pochi giorni fa proprio Johnson mi ha fatto scoprire l’opening del Weather Festival a Parigi, con la versione orchestrale di “Strings Of Life” di Francesco Tristano (ex Aufgang) eseguita dalla Philharmonic Orchestra Lamoureux diretta da Dzijan Emin. Mi sono venute le lacrime agli occhi per l’emozione, consiglio davvero di guardare la clip.

Flyer de La Clinica (1988) su gentile concessione di Jackmaster Pez
Nell’autunno del 1988, sull’onda dell’entusiasmo, iniziai ad organizzare piccoli house party a casa mia. Così nacque la Clinica che, in teoria, era riservata a pochi intimi amici conosciuti all’Elba invece ci ritrovammo in cinquecento provenienti da Roma, Firenze, Genova, Milano, Torino … Tutto crebbe in modo spontaneo e col passaparola (in un periodo in cui internet non era neanche ipotizzabile) generando una tribù di seguaci molto ricettivi per quel nuovo fenomeno musicale all’interno di una cornice radicalmente inedita e meravigliosamente magica. Ricky Pannuto, mio partner ai tempi dei Talk Of The Town all’inizio fortemente scettico nei confronti della house, cambiò idea ed insieme producemmo, nel 1990, “Life Is An Illusion” di Sound Of Clinica, in puro genere “paradise”. In Italia però giornali, televisioni ed emittenti radiofoniche giunsero alla house solo dopo “Pump Up The Volume”, peraltro prestando più attenzione ai primi acid house party londinesi che altro. La house era musica di nicchia e vista di traverso perché legata all’uso dell’ecstasy. Inoltre sia discografia che distribuzione nostrana non erano ancora pronte a voltare pagina, perché inizialmente le soglie di vendita della house erano talmente esigue da non creare alcun interesse per i manager discografici che continuavano a vendere milioni di copie con altri generi. Non a caso la house music si è diffusa attraverso piccole etichette indipendenti, quelle che avevano meno paura di osare. Non dimenticherò mai l’espressione di un discografico dopo aver ascoltato un mio demo house. Aspettava che succedesse qualcosa e alla fine mi guardò stranito dicendomi “mah, mi sembra un jingle per uno spot pubblicitario”».
I primi dischi house made in Italy
Se è arduo indicare chi abbia parlato per primo di house music nel nostro Paese è altrettanto problematico stabilire con esattezza chi abbia prodotto il primo pezzo house in Italia. Quel che pare certo è che a dedicarsi discograficamente a questo nuovo sound è, in principio, solo chi ha già carriere pregresse alle spalle in ambito italodisco e con una certa dimestichezza sia in processi tecnici che trafile burocratiche e, non meno importante, con uno studio di registrazione a disposizione, allora requisito essenziale per incidere dischi. Si ha inoltre l’impressione che la maggior parte dei primi italiani a buttarsi nella produzione di musica house sia allettata in primis da possibili introiti economici più che dallo stile in sé, ed infatti sul mercato giungono diverse riproposizioni, piuttosto pedestri, della formula portata al successo dai M.A.R.R.S. con “Pump Up The Volume”, a dimostrazione che inizialmente la house venga considerata più come mezzo per lucrare velocemente che esprimere la propria vocazione artistica e creativa. Il campionatore viene adoperato per generare frullati citazionistici ma attingendo da fonti prevalentemente riconoscibili anche dal pubblico generalista. Non c’è ancora traccia del minuzioso lavoro dei cosiddetti “crate digger” che passano al setaccio materiale oscuro facendo leva sulla propria sensibilità per individuare i giusti frammenti da trasformare in cose nuove. A differenza di quanto avviene oltremanica inoltre, da noi inizialmente mancano produttori che prendono le mosse da Chicago, e i pochi DJ a volerlo fare non hanno la forza economica sufficiente per approntare prodotti adatti alla stampa, se non qualche demo registrato alla meno peggio. Negli studi che si usa prendere a nolo invece non c’è ancora personale specializzato in house music e a dirla tutta i turnisti mostrano più di qualche riserva nel prendere parte a progetti in cui la musica viene composta in modo del tutto diverso rispetto a quanto fosse avvenuto sino a quel momento. Non mancano neppure produttori infastiditi dal fatto che i DJ inizino a conquistare indipendenza emancipandosi dai musicisti qualificati per realizzare i propri brani. Inoltre non esistono case discografiche, tranne piccole e piccolissime indipendenti, disposte a pubblicare senza riserve pezzi di quel tipo, preferendo puntare ancora sull’italodisco che, nel frattempo, raggiunge la fase creativa più deludente. Si delinea pertanto un quadro in cui i DJ italiani che amano sperimentare nuove fogge stilistiche sono costretti a ripiegare esclusivamente su materiale discografico proveniente dall’estero perché non esiste ancora un equivalente prodotto in patria. Qui di seguito una carrellata (in ordine alfabetico) di produzioni italiane edite nel 1987, candidate ad essere considerate tra le prime prove “friendly house” nostrane. La gallery non ha però la pretesa di essere completa ed esaustiva, pertanto in futuro potrebbe essere oggetto di aggiornamenti.
 Alexander Robotnick – C’est La Vie (Fuzz Dance)
Alexander Robotnick – C’est La Vie (Fuzz Dance)
“C’est La Vie” è il brano con cui Maurizio Dami torna a vestire i panni di Alexander Robotnick, personaggio franco-sovietico scaturito dalla sua fantasia e materializzatosi per la prima volta nel 1983 con la seminale “Problèmes D’Amour” a cui abbiamo dedicato un ampio articolo qui. Il pezzo, per cui viene realizzato anche un videoclip, non è esattamente house almeno nella versione principale. Cantata ancora in lingua francese e con gli inserimenti di sax ad opera di Stefano Cantini che giusto l’anno prima partecipa a “Love Supreme” dei Giovanotti Mondani Meccanici, team in cui figura lo stesso Dami, “C’est La Vie” è destinata al pubblico mainstream e alle radio. Più filo house risulta essere però la versione incisa sul lato b intitolata, piuttosto banalmente, Another Version, privata di quasi tutte le parti vocali e contraddistinta da un telaio percussivo più rigido. Nonostante venga licenziato in Francia dalla Sire, il pezzo non raccoglie il successo sperato e spinge l’autore toscano ad “ibernare” il suo alter ego sino al 1991, anno in cui ci riprova ancora con la house attraverso “Les Vacances” edito da Los Cuarenta/Expanded Music ed arrangiato da Claudio Collino ed Elvio Moratto. La nuova delusione sembra tale da infliggere a Robotnick il colpo di grazia. Le cose cambiano però nei primi anni Duemila, quando scoppia l’electroclash e il revivalismo connesso alla “80s dance”: influenti personaggi esteri riconoscono a Maurizio Dami il merito di aver gettato con “Problèmes D’Amour” (ma pure con altri brani meno noti del suo repertorio come “Dance Boy Dance”), i semi della proto house specialmente a Chicago, lì dove il suo primo singolo è considerato un’autentica pietra miliare.
 Cappella – Bauhaus (Media Record)
Cappella – Bauhaus (Media Record)
Con le mani in pasta nella discografia sin dal 1983, Gianfranco Bortolotti conia il progetto Cappella nell’autunno del 1987 per questo brano-emulo di “Pump Up The Volume” realizzato da Francesco Bontempi, affermatosi in epoca italodisco come Lee Marrow e futuro produttore delle hit di Corona di cui abbiamo parlato qui. «Ero in vacanza negli States ed ascoltai il pezzo dei M.A.R.R.S. che mi colpì al punto da voler creare qualcosa di simile» spiega l’imprenditore bresciano in questa intervista. La vicenda ricorda quanto avvenuto esattamente un anno prima a Ian Levine che tornato a Londra da New York replica “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders attraverso “On The House” di Midnight Sunrise (per tutti i dettagli si rimanda a questo approfondimento). Autentico spirito di emulazione transcontinentale insomma. «“Bauhaus” fu realizzato con tecnologia primitiva» prosegue Bortolotti, «avevamo cinque o sei campionatori Akai tra cui l’S612, ma non disponendo del MIDI tre persone erano costrette a spingere un pulsantino nello stesso istante. Registravamo su nastro a 24 piste per poi editare con la taglierina ed attaccare con lo scotch. Le tastiere erano al 99% analogiche come del resto l’effettistica della Lexicon che costò un occhio della testa. Tra le poche macchine digitali di cui disponevamo c’era la Yamaha DX7. Il pezzo venne realizzato in una cantina dove era allestito lo studio (il 24th Street Studio in Via Sant’Emiliano, a Brescia, nda) di cui sarei diventato socio e che poi avrei spostato in Via Martiri Della Libertà». “Bauhaus” macina licenze sparse in tutto il mondo, Svezia, Paesi Bassi, Germania, Francia, Spagna, Grecia e persino Australia. In Canada e Regno Unito viene pubblicato con un titolo diverso, “Push The Beat” perché, come rivela Bortolotti contattato per l’occasione, «chi rilevò la licenza tentò di fregarci il 50% dei diritti di master e d’autore, cercando di far passare il pezzo per un medley con “Push The Beat”, un campione che figura solo sulle prime copie britanniche. Ovviamente sistemammo la questione». La scarsità sul mercato di materiale di quel tipo, dovuta alla difficoltà tecnica nel replicare il risultato considerati gli esorbitanti costi per allestire uno studio, determina la fortuna di “Bauhaus”, sostanzialmente la risposta italiana a “Pump Up The Volume”, e a tal proposito Bortolotti dice, sempre in quell’intervista del 2015, che «fu la chiave di volta nella mia carriera da produttore, il successo continentale da cui germogliò l’elemento determinante per la nascita della Media Records e che iniziò a lanciare lo stile italiano in Europa». Oggi aggiunge: «Credo che “Bauhaus” abbia venduto circa un milione di copie e pensarci mi riporta alla memoria qualche aneddoto: quando lo pubblicai in Italia ormai l’italodisco era agli sgoccioli e i titoli vendevano mediamente duecento/trecento copie, lasciando emergere un malessere generale nella discografia. Le richieste del pezzo però furono straordinarie, così alte da non poter sostenere da solo i costi della stamperia. Quando ordinai la prima tiratura di oltre trentamila copie il buon Antonio Cagnola della Microwatt, che ormai ci ha lasciati, si spaventò e mi disse che era necessario versare almeno il 50% in anticipo. Fui costretto a farmi prestare il denaro da Diego Leoni, in cambio di quote della Media Records. Alla fine ne stampai quasi centomila, e così fu per tutte le nostre hit sino al 2004, quando lasciai. Sia la Microwatt che la Ariston di Alfredo Rossi, per quindici anni, mi inviavano puntualmente ogni Natale mazzi giganteschi di fiori (rose o gardenie) e champagne per ringraziarmi del lavoro che gli passavamo. Rossi inoltre mi mandò suo figlio a “scuola”, a Roncadelle, per due o tre anni, chiedendomi di crescerlo adeguatamente». “Bauhaus” esce su Media Record (senza s finale), brand che il produttore bresciano crea nel 1986 in seno all’italodisco e quando è ancora affiliato alla Discomagic di Severo Lombardoni. Ci vorrà ancora del tempo prima di giungere alla Media Records (il primo ad uscire col nuovo marchio è “Shadows” di 49ers, 1989). Nel frattempo Cappella continua ad essere il nome con cui Bortolotti scommette sulla house filobritannica, a partire dal fortunato “Helyom Halib” del 1988 (con un campionamento di “Work It To The Bone” degli LNR), “Get Out Of My Case” ed “House Energy Revenge”, entrambi del 1989, sino a “Be Master In One’s Own House” del 1990. Nel 1991, sull’onda della compenetrazione tra suoni techno e ritmiche house in stile Bizarre Inc (“Such A Feeling”, “Playing With Knives”), escono “Everybody” e “Take Me Away”, prima della svolta eurodance con hit milionarie (“U Got 2 Know”, “U Got 2 Let The Music”, “Move On Baby”, “U & Me”, “Move It Up”, “Tell Me The Way”, “I Need Your Love”) che legheranno Cappella sia ad un nuovo volto sonoro che fisico visto che il ballerino/body builder Ettore Foresti, già coinvolto in Superbowl tra ’85 e ’87, lascia spazio a Rodney Bishop, Kelly Overett ed Alison Jordan che contribuiscono a mantenere alte le quotazioni del progetto per diversi anni.
 DJ Lelewel – House Machine (Renata Edizioni Musicali)
DJ Lelewel – House Machine (Renata Edizioni Musicali)
Trainato da sezioni di pianoforte sincronizzate su una base in 4/4, “House Machine” è il brano di Daniele Davoli alias DJ Lelewel, disc jockey di Reggio Emilia e tra i primi ad incidere musica house nel nostro Paese. «Ai tempi c’erano già dei sentori di house music, spesso mischiata a rimasugli dell’electro usata per la breakdance come ad esempio “19” di Paul Hardcastle, del 1985, che conteneva qualche elemento che si sarebbe poi ritrovato nella house» spiega oggi Davoli. «Allora lavoravo al Marabù di Reggio Emilia e in particolare ricordo la serata del giovedì dedicata agli studenti, in cui proponevo la cosiddetta “afro”, quella che per intenderci passavano DJ come Daniele Baldelli, Moz-Art, L’Ebreo, Spranga, emittenti come la bresciana Radio Azzurra e locali come il Chicago di Baricella di Bologna. Era un filone intorno al quale c’era un forte interesse specialmente nella zona del lago di Garda, a Lazise e a Verona. Le prime influenze che emersero quando divenni un produttore infatti richiamavano più l’afro che altro. Comunque il pezzo che mi fece capire quanto fosse forte la house fu “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders, del 1986. L’anno dopo giunse “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S. con cui tutti capirono che la house era arrivata e sarebbe rimasta. Ricordo però che ad avere la meglio da noi era ancora la dance hi NRG in stile Stock, Aitken & Waterman, specialmente nei locali di provincia come il citato Marabù. Seppur fosse gestito molto bene e meta di un corposo pubblico, non era il luogo più adatto per sperimentare nuovi stili tranne il giovedì, quando non scendevo a nessun compromesso con le hit da classifica e facevo un programma afro che, verso la fine, includeva qualche pezzo house. Partivo molto lento, intorno agli 85 bpm, tirando dentro un mucchio di cose eterogenee, da James Brown alla new age». A produrre “House Machine” è il compianto Stefano Cundari, co-fondatore della Memory Records che ai tempi inizia a prendere le misure di un nuovo segmento di mercato, quello della house per l’appunto. «Il grande Cundari, espertissimo in tecnologia, mi insegnò tanto, fu lui a spiegarmi come realizzare i remix col Revox ad 1/4 di pollice, a tagliare, duplicare ed incollare il nastro» prosegue Davoli. «Prima di diventare un produttore di fama internazionale inoltre, Cundari era un DJ e per questo capiva benissimo la mentalità di noi disc jockey, anche se quando ci conoscemmo aveva smesso già da tempo di mettere i dischi nei locali preferendo dedicarsi esclusivamente alla produzione discografica. Aveva una struttura avviatissima, un’etichetta di successo e due studi di registrazione che erano ad appena cinquecento metri da casa mia. Grazie a questa vicinanza potevo andare a trovarlo spesso perché condividevamo la passione per le auto d’epoca. Paradossalmente parlavamo poco di musica perché a me non piaceva molto il genere con cui lui fece fortuna, l’italodisco, che cercavo di evitare nelle mie serate fatta eccezione per le hit da classifica che non potevo proprio esimermi dal passare. Un giorno, durante uno dei nostri incontri, gli dissi che la house music stava prendendo piede in Europa e lui annuì sostenendo che anche altri gli avessero riferito la stessa cosa. A quel punto mi propose di provare a fare un brano, non con l’intento di incidere una hit ma giusto per tenere un piede nel futuro. La musica che gli dava da mangiare era ancora l’italodisco ma Cundari mostrò la curiosità e la volontà di sondare le potenzialità di quel nuovo genere e per farlo avremmo potuto usare gli strumenti in suo possesso come il campionatore Akai S900 e vari sintetizzatori (Prophet-5, Minimoog, PPG). Per “House Machine”, nello specifico, adoperammo un sequencer Roland programmato da Stefano perché ai tempi non ci capivo davvero niente, l’Akai S900 (o forse due), un Korg M1 con cui eseguimmo la parte di pianoforte, e un PPG Wave 2.3 per il basso. La batteria invece era un misto tra campioni e percussioni prese dalla mitica Linn LM-1. Per finalizzare il tutto impiegammo un paio di settimane circa ma lavorando quattro/cinque ore per volta in qualche serata. Durante il giorno infatti Stefano si occupava degli artisti del suo catalogo, si dedicava a me solo dopo le 18, rimanendo in studio sino alle 21/22. Il brano non fu un successo, vendette 1500 copie che poi, probabilmente, furono destinate quasi tutte all’export, ma fece anche una manciata di licenze, in Olanda e in Germania, seppur non vidi mai i rendiconti (il socio di Stefano, Alessandro Zanni, non era tra i più solerti nel mandarli). Le perplessità di Cundari sorsero nel 1988 quando avremmo dovuto preparare il follow-up. Nonostante non fosse un fiasco, “House Machine” non raggiunse i risultati che si aspettava o sperava. Siccome vendeva ancora molte copie di italodisco, fu titubante a dedicarmi del tempo per un disco house. Mi chiese innanzitutto di pensare ad un pezzo con più musica, a suo avviso per ottenere buoni risultati non bastava incidere una traccia adatta solo ai disc jockey, il rischio era di vendere di nuovo troppo poco. Né io, né Stefano però eravamo musicisti, capivamo la musica ma mettersi davanti ad un pianoforte e suonarlo è un altro paio di maniche. Avevamo bisogno di coinvolgere un musicista e Stefano interpellò Mirko Limoni che, di tanto in tanto, collaborava con lui a cottimo. In mente avevo una vaga idea di ciò che avrei voluto realizzare ma dopo appena un paio di pomeriggi Cundari si demoralizzò e ci disse che era costretto a mettere il progetto “in freezer” per dedicarsi ad altro. Aggiunse che lo avremmo potuto riprendere più avanti, qualora la voglia non fosse scemata del tutto. Delusi per quella decisione, uscimmo affranti dallo studio ma Mirko si mostrò subito dubbioso. Secondo lui le idee buttate giù erano buone e mi propose di raggiungerlo nello studiolo che aveva allestito con alcuni amici tra cui Valerio Semplici. Lì potevamo dedicarci senza limiti di tempo perché lui usciva dal lavoro a mezzogiorno ed avremmo avuto tutto il pomeriggio e parte della sera per strimpellare e fare quello che ci pareva, senza alcuna costrizione. Nove/dieci mesi dopo il pezzo era pronto, si trattava di “Numero Uno” che pubblicammo come Starlight, omonimo del locale estivo in cui lavoravo. I direttori della discoteca si offrirono di pagare le spese della copertina stanziando un milione di lire per il grafico. In cambio noi avremmo dovuto inserire il nome del locale da qualche parte. Nessuno avrebbe potuto immaginare che “Numero Uno” (con un sample preso da “Beyond The Clouds” dei Quartz, pubblicato dalla Out di Severo Lombardoni ed oggetto di una ricchissima serie di licenze in tutto il mondo, nda) fosse il follow-up di “House Machine”. A sua volta Starlight fu il predecessore di “Ride On Time” dei Black Box. Alla luce di tutto ciò quindi posso affermare che “House Machine” mi incoraggiò ad intraprendere l’attività di produttore discografico oltre a fornirmi aiuto per farmi conoscere nell’ambiente. Da lì a breve infatti cominciarono a giungere le prime richieste di remix come quello di “Happy Children” di P. Lion che mi commissionò Lombardoni. Cose italiote, senza dubbio, ma che mi garantirono comunque una certa esposizione. Allora non riuscivo neanche ad immaginare di poter conquistare le classifiche straniere, soprattutto quelle inglesi, esisteva solo una flebile speranza contrapposta alla consapevolezza di non poter riuscire in quella impresa. “House Machine” mi fece capire come e cosa fare per creare l’arrangiamento di un disco, mi fece conoscere prima Mirko e poi Valerio, insomma proprio con quel pezzo si aprì la porta della mia carriera da produttore». Nel 1989 Davoli darà vita ad uno dei capisaldi della italo house, “Ride On Time” di Black Box, che sommato al menzionato “Numero Uno” di Starlight, “Do-Do-Don’t Stop” di Rosso Barocco, “Airport 89” di Wood Allen e “Grand Piano” di The Mixmaster costituisce l’ossatura dell’affiatato team della Groove Groove Melody creato insieme a Mirko Limoni e Valerio Semplici.
 DJ System – Animal House (Discomagic Records)
DJ System – Animal House (Discomagic Records)
DJ System è il team project messo su da Stefano Secchi, Maurizio Pavesi e Marcello Catalano con l’intento di cavalcare l’esplosione della house music dopo il successo di “Pump Up The Volume”. La loro “Animal House” è annodata in modo inequivocabile al disegno creativo dalla hit dei britannici, con sample piazzati qua e là, alcuni dei quali ben noti come quello di “Thriller” di Michael Jackson, e qualche immancabile scratch. Il titolo è ispirato dal latrato di un cane incastrato nelle pieghe ritmiche insieme al nome del progetto fatto balbettare così come si usa fare a Chicago. Nel 1989 Secchi e Pavesi ci riprovano con la poco nota “Party Time” su Rolls Record, ma si rifaranno entrambi con gli interessi negli anni a seguire. La Discomagic Records di Severo Lombardoni riprende invece il brand DJ System nel 1992 per “Yeah!” prodotto da Maurizio Braccagni quando la tendenza commerciale in Italia si è spostata sui suoni derivati dalla techno dei rave britannici, tedeschi ed olandesi.
 Fun Fun – Gimme Some Loving (House Mix) (X-Energy Records)
Fun Fun – Gimme Some Loving (House Mix) (X-Energy Records)
Le Fun Fun spopolano tra 1983 e 1984 coi singoli “Happy Station” e “Color My Love”, ispirati entrambi dalla disco hi NRG di Bobby Orlando. Nel corso degli anni vengono ingaggiate diverse vocalist, tra cui Ivana Spagna, ed altrettante frontwomen a rappresentare l’immagine pubblica del duo secondo una modalità lavorativa ampiamente rodata nell’ambiente dell’italodisco nostrana (a tal proposito si rimanda a questo reportage). “Gimme Some Loving” è la cover, arrangiata da Paolo Gianolio, dell’omonimo di Spencer Davis Group, ma l’uso del termine House Mix è decisamente fuorviante. È vero che c’è un beat costruito con la TR-909 e qualche inserto pianistico ma, contrariamente a quanto forse pensano i produttori allora, ciò non è sufficiente a farne un brano house, e basta un veloce ascolto per sfatare ogni dubbio. Una “House Mix” realizzata dall’olandese Ben Liebrand figura pure nel successivo “Could This Be Love”, ma di house se ne sente davvero poca pure in questo caso, a testimonianza di quanta confusione ed approssimazione ci fosse intorno al termine “house” nel 1987.
 Glance – Turas / Open Legs (Les Folies Records)
Glance – Turas / Open Legs (Les Folies Records)
Ad orchestrare il lavoro dietro lo sconosciuto progetto Glance è Tony Carrasco, DJ americano di origini italiane che alle spalle ha un successo di proporzioni epocali, “Dirty Talk” di Klein & M.B.O., uscito nel 1982 e considerato una specie di proto house. Ad affiancare Carrasco sono Sergio Pisano, i fratelli Nicolosi (Giuseppe, Lino e Rossana) e la vocalist Dora Carofiglio, altri nomi ben noti nella discografia nostrana (Novecento, Valerie Dore). Delle varie versioni incise sul 12″ spicca meglio la Sexy Piano che, come promette il titolo, sfoggia un assolo di pianoforte incastrato a dovere in un basso slappato di matrice funk derivato dall’omonimo brano originale, edito dalla Proto Records nel 1983 e firmato Amnésie. Il tutto su un beat “dritto” a garantire una sorta di “effetto Paradise Garage”. Il disco viene pubblicato sulla Les Folies Records che all’attivo ha solamente un’altra uscita, “Limit” di True Colors, prodotta da Pisano nel 1984 ed oggi ben quotata sul mercato dell’usato.
 L.A.N.D.R.O. & Co. – Get Up, Get On Up (New Music International)
L.A.N.D.R.O. & Co. – Get Up, Get On Up (New Music International)
Prodotto da Pippo Landro, ex membro dei Gens e titolare di uno dei negozi di dischi più noti di Milano, il Bazaar Di Pippo, Maurizio Macchioni e il sopraccitato Sergio Pisano presso il Les Folies Studio, “Get Up, Get On Up” è uno dei primi 12″ del catalogo New Music International, etichetta che lo stesso Landro fonda nel 1987. Il brano è costruito in maniera semplice, con assoli di tastiera jazzati, un breve messaggio vocale, una parte pseudo rap, un sample preso da “Kiss” di Prince e la chiusura con un virtuosismo di tromba. Dal 1988 L.A.N.D.R.O. & Co. ospita nuovi autori: a “Belo E Sambar” mettono mano Massimino Lippoli ed Angelino Albanese mentre “Hey Mr. D.J.” viene prodotto da Fabrizio Rizzolo, Franco Diaferia e Marco Martina. Con “I’ve Got Your Love”, “Un Otro” e “Zodiac Lady” l’attenzione si sposta progressivamente verso il downtempo.
 MBO – M.B.O. Liverpool Theme (Limited Edition Records)
MBO – M.B.O. Liverpool Theme (Limited Edition Records)
Il successo internazionale raccolto con “Dirty Talk” di Klein & M.B.O. (nato da un’idea di Davide Piatto dei N.O.I.A. seppur il suo nome non figuri tra i credit – si legga questo reportage per tutti i dettagli) galvanizza il compianto Mario Boncaldo che nel 1987 avvia il progetto MBO lasciandosi affiancare da Elio Crociani. “M.B.O. Liverpool Theme” ricalca lo schema di “Dirty Talk” sfruttando più incisivamente la rhythm section di una Roland TR-808, elemento che stuzzica l’attenzione oltreoceano negli anni immediatamente precedenti alla nascita della house. In “M.B.O. Liverpool Theme”, ad onor del vero, di house non c’è granché, fatta eccezione proprio per il telaio della batteria analogamente a “Don’t Stop The Music” di Lee Marrow, ma Boncaldo era convinto che la house fosse una sua invenzione. A tal proposito qualche anno fa scrive sul suo sito: «Nel 1985 Rocky Jones, patron della celebre etichetta D.J. International Records, prese spunto da “Dirty Talk” e continuò il trend chiamandolo impropriamente The House Of Chicago. “La Casa di Forlì” sarebbe andata certamente poco lontano! Rifiutai, diverse volte, proposte accorate e suppliche di Rocky che mi voleva con lui a Chicago. Non sempre nella vita si fanno le cose giuste e purtroppo lo si capisce col senno di poi». Intervistato dallo scrivente nel 2011, Rocky Jones dichiara però di non aver mai sentito parlare di Boncaldo a Chicago, e che in realtà fu l’amico Benji Espinoza, commesso presso il negozio di dischi DJ Records, a segnalargli quel pezzo. «Incontrai Boncaldo tempo dopo in Francia, dove era insieme a Tony Carrasco» spiega, «mi sarebbe piaciuto lavorare con loro per traghettarli in una dimensione più vicina alla house che alla disco. “Dirty Talk” resta un gran pezzo, avanguardista nell’uso della batteria ed ispiratore per chi in seguito si è dedicato alla house, ma il mondo intero sa che la genesi della house spetta ai creativi di Chicago. La disco e la house non vanno assolutamente confuse perché non sono la stessa cosa, e il pezzo di Boncaldo appartiene più alla disco visto che fu prodotto nel 1982 quando la house, di fatto, non esisteva ancora». Da abile uomo d’affari, Boncaldo cerca comunque di tirare acqua al suo mulino facendo scrivere sul centrino del disco “the original house sound of M.B.O.” parodiando, anche graficamente, il “the house sound of Chicago” che si ritrova sull’omonima compilation della D.J. International Records uscita nel 1986. Un secondo 12″ marchiato con la sigla MBO viene commercializzato, pure in formato picture disc, attraverso la lombardoniana Technology su cui, sempre nel 1987, esce “War… No More” assemblato insieme a David Sabiu. Analogamente a “M.B.O. Liverpool Theme”, la title track incrocia stilemi house a impostazioni eurobeat, “Theme For Peace” è un restyling piuttosto raffazzonato di “Dirty Talk” mentre “House Nation” suona come la versione tarocca dell’omonimo di The House Master Boyz And The Rude Boy Of House, un classico di Farley Jackmaster Funk pubblicato l’anno prima dalla Dance Mania di Chicago.
 Midas – One O One (DFC)
Midas – One O One (DFC)
Dietro il nomignolo Midas si celano Riccardo Persi, Davide Sabadin, Claudio Collino ed Andrea Gemolotto che ritroveremo più avanti in altri progetti. “One O One” sintetizza certe sfumature della house sampledelica britannica con suoni e costruzioni che risentono ancora dell’influsso italodisco specialmente nella Extended Dance Mix. Più filo-house risulta la Reaction Drums Mix, in cui presenzia ancora il sample dell’arcinota “Long Train Running” dei Doobie Brothers ma combinato insieme al suono di quello che pare un organo hammond. Persi & co. incideranno ancora come Midas pubblicando “Nummer Een” nel 1988 e il meglio riuscito “You Make Me Feel So Good” nel 1989, quando la house italiana acquista più personalità e carattere.
 P/P/G – Jack The Beat (DFC)
P/P/G – Jack The Beat (DFC)
P/P/G sta per Persi Previsti Gemolotto, i tre che uniscono le forze per creare il disco in questione. Intervistato anni fa in Decadance Extra, Riccardo Persi racconta il modo in cui giunge alla house, lasciandosi alle spalle l’esperienza coi Krisma e con l’italodisco. «Le major erano ancora legate al concetto di album, io puntavo invece ad incidere dischi mix con etichette indipendenti che velocizzavano molto l’iter, bypassando burocrazia ed attese interminabili dovute al passaggio del pezzo di scrivania in scrivania. Dopo aver creato i Premio Nobel con Claudio Collino e Davide Sabadin, decidemmo di prendere le distanze da quello che era l’andazzo generale della dance italiana. Volevamo uscire dagli schemi, fare più tendenza e magari abbracciare da vicino il mondo dei DJ, così nel 1987 fondammo un’etichetta nuova di zecca, la DFC, acronimo di Dance Floor Corporation, ammiccando pure alla sigla simile DMC. Non a caso proprio in quel periodo conoscemmo Andrea Gemolotto che ai campionati DMC si faceva chiamare Cutmaster-G». Il catalogo della DFC è inaugurato da “Jack The Beat”, prodotto nello studio di Gemolotto ad Udine e a cui partecipa Fulvio Zafret come tecnico del suono. Il pezzo segna la fusione tra house ed italodisco: da una parte la classica costruzione ritmica con kick/hihat in levare, snare e qualche vocione a declamare il titolo ammiccando al jack di estrazione chicagoana e ai successi dei J.M Silk, dall’altra un bassline che pare citare quello di “Moskow Diskow” dei Telex, pianate jeffersoniane e qualche scorcio melodico classicamente disco/funk a richiamare “Dancer” di Gino Soccio. Tra ’88 e ’89 il brano viene pubblicato anche all’estero ma il follow-up, “Funky Domanuva”, rimane nell’anonimato. Persi e Gemolotto si rifaranno a partire dal 1989, quando realizzano “Sueño Latino” del progetto omonimo a cui seguiranno svariate altre hit (Atahualpa, Glam, Ramirez) che renderanno la DFC uno dei capisaldi della dance made in Italy negli anni Novanta.
 The Jam Machine – Funky (Let’s Go) (X-Energy Records)
The Jam Machine – Funky (Let’s Go) (X-Energy Records)
Prodotto da Dario Raimondi ed Alvaro Ugolini per la loro X-Energy Records, “Funky (Let’s Go)” mette insieme alcune delle caratteristiche primarie della house diffusasi ai tempi in Europa, un beat in 4/4, un basso avvolgente, qualche breve sample vocale giocato col campionatore ed un paio di elementi melodici. Ad arrangiarlo è Paolo Gianolio, che ha già maturato esperienze in ambito dance collaborando con musicisti di prim’ordine come Celso Valli, Claudio Simonetti (nell’album dei Crazy Gang) e Mauro Malavasi. «Conobbi Dario Raimondi qualche anno prima in uno studio di Cremona dove ci incrociammo in occasione di un lavoro che poi portammo avanti insieme, credo fossero alcuni brani per le Fun Fun» ricorda oggi Gianolio. «Da lì nacque la collaborazione che andò avanti per un bel periodo in cui producemmo diversi progetti, proprio come The Jam Machine, uno di quelli nati davvero per caso. La costruzione di “Funky (Let’s Go)” era basata sul puro divertimento e su idee da cui ne sbocciavano altre. Andavamo avanti a ruota libera, senza alcuna tensione o ansia per il risultato. In quegli anni la tecnologia aiutava fino ad un certo punto, a seconda delle necessità ed esigenze ricorrevamo a trucchi ed artifici. Erano tempi in cui ci si poteva esprimere attraverso varie tipologie di dance ma l’influenza della house mi attrasse per i suoi contenuti. Nonostante le drum machine e i sequencer fossero già molto usati, la house manteneva di fondo una cosa fondamentale, lo swing e il “nervo” musicale che faceva ballare anche le sedie». Non è mistero che in quel periodo più di qualche musicista riserva alla house giudizi tutt’altro che lusinghieri in virtù del fatto che fosse una musica realizzabile anche da chi non in grado di leggere lo spartito. A tal proposito Gianolio sostiene che «leggere lo spartito non significa saper costruire un brano musicale. La dance si è creata il proprio pubblico indirizzando il ritmo sulla semplicità scelta anche da chi, pur non avendo preparazione musicale, ha saputo inventare melodie ripetitive ma accattivanti su ritmi al servizio del ballo. Le buone idee non tengono conto da dove vengono». Nel passato di Gianolio c’è anche la collaborazione con la Goody Music di Jacques Fred Petrus (assassinato proprio nel 1987) in progetti come Change, Silence e The Brooklyn, Bronx & Queens Band – meglio noti come B. B. & Q. Band. Probabilmente una prova più che utile per ciò che avviene in seguito con la X-Energy Records. «L’esperienza che un musicista acquisisce nel suo cammino gli servirà sempre da base per sviluppare il proprio gusto secondo il proprio carattere. Silence ad esempio, che mi portò a collaborare con Celso Valli, mi aprì il mondo della melodia e dell’armonia applicate alle canzoni. Change invece mi ha fatto capire, grazie a grandi musicisti come Davide Romani e Mauro Malavasi, come avvicinarsi alla musica in modo che la musica stessa ti si avvicinasse. La mia vita è trainata dalla musica, l’importante è viverla come mezzo per esprimerla. L’anima è, con o senza sapere, il tramite, il ponte che permette di esprimere al mondo la sensibilità di ognuno di noi» conclude Gianolio. “Funky (Let’s Go)” viene registrato presso il Pick-Up Studio di Reggio Emilia e licenziato all’estero (Canada, Stati Uniti, Spagna, Paesi Bassi) conquistando la presenza in diverse compilation. Dal 1988 il progetto The Jam Machine ospiterà autori a rotazione: a “Graffiti House” lavorano Julio Ferrarin e Gino Woody Bianchi, in “Everyday”, del 1989, figurano invece Corrado Rizza e i cugini Frank e Max Minoia. L’ultimo è “Move On Up” del ’93, cover dell’omonimo di Curtis Mayfield, prodotto dal team della Lemon Records (di cui abbiamo parlato qui) col supporto vocale di Orlando Johnson e Karen Jones.
 Yagmur – Ali Baba (DFC)
Yagmur – Ali Baba (DFC)
A poca distanza da “Jack The Beat” di P/P/G di cui si è parlato più sopra, Persi, Collino e Sabadin incidono un pezzo contraddistinto da linee melodiche orientaleggianti. All’interno un sample vocale tratto da “Electrica Salsa (Baba Baba)” dei tedeschi Off ed assoli di scratch, “tag” sonora di Gemolotto che allora bazzica il mondo del mixing acrobatico del DMC. L’Extended Dance Mix è più connessa alla new beat che alla house, la Percussion Mix invece lavora meglio il ritmo, anticipando la formula che gli Yagmur presentano in “Woo-Alli-Alli” del 1988, battendo ancora itinerari esotici ed adoperando un sample vocale che si ritroverà più avanti in “We Are Going On Down” dei Deadly Sins.
1988, un anno spartiacque
Dal 1988 in poi la produzione va intensificandosi ma l’impressione è che la house, in Italia, continui ad essere ancora discograficamente battuta con scarsa o inesistente cognizione di causa a supporto di parodie, cloni di successi esteri e brani ironico-demenziali come “C’è Da Spostare Una Macchina” di Francesco Salvi che ricicla la base di “The Party” di Kraze, “Checca Dance” di Gay Forse Featuring D.J. Roby, che canzona Claudio Cecchetto in un quadro di continui riferimenti all’omosessualità, ed “Inno Del Corpo Sciolto” di Toilet Paper, che campiona l’omonimo di Roberto Benigni e semina citazioni per “È Qui La Festa?” di Jovanotti. Per diversi discografici nostrani la house pare una parentesi stilistica più che un ceppo culturale, qualcosa a cui approdare adoperando certi suoni ma ignorandone le origini. Ed ecco sfilare le presunte house version di “Just An Illusion” degli Imagination a firma Marco Martina (arrangiata da Franco Diaferia) e quella di “Jesahel” dei Delirium. Persino la blasonata Irma Records ha, come racconta Vittorio “Vikk” Papa su Orrore A 33 Giri uno scheletro nell’armadio: “Tombao Meravigliao”, brano che ironizza sullo sciatore Alberto Tomba in una delle sue stagioni più fortunate, facendo il verso al “Cacao Meravigliao” di Renzo Arbore (dal programma tv “Indietro tutta!”). Nulla di house al suo interno ma vale la pena soffermarsi su uno degli autori, Cesare Collina, un paio di anni dopo all’opera con Kekko Montefiori e Flavio Vecchi su Key Tronics Ensemble, diventato uno dei vessilli della italo house. Il 1988 è anche l’anno in cui Lorenzo Cherubini conduce, su Italia 1, il programma “1, 2, 3 Jovanotti”, imponendosi al pubblico dei giovanissimi grazie al primo album, “Jovanotti For President”, un mix tra hip hop all’italiana, pop e qualche riferimento house. Il mercato però necessita ancora di tempo, e a testimonianza di ciò è utile ricordare che uno dei top seller italiani del 1988 è “Faccia Da Pirla” di Carlo Marchino alias Charlie. Segue l’analisi di produzioni nostrane targate 1988, a cui se ne potrebbero aggiungere altre in futuro.
 49ers – Die Walküre (Media Record)
49ers – Die Walküre (Media Record)
Sulle ali dell’entusiasmo per il successo internazionale raccolto con “Bauhaus” di Cappella, Gianfranco Bortolotti lancia un altro progetto che farà la fortuna della sua casa discografica. Col nome ispirato dalla squadra di football americano, i San Francisco 49ers, crea i 49ers che traghettano nuovamente la Media Record, prossima a trasformarsi nella definitiva Media Records, all’attenzione generale. A livello di concept, 49ers potrebbe essere considerata l’evoluzione di un altro progetto bortolottiano di qualche anno prima, Superbowl, anch’esso intrecciato al mondo del football. Indizi evidenti si palesano sulla copertina del singolo “Oé – Ooh” del 1985, dove il nome 49ers appare su uno dei due elmetti, insieme alla ristilizzazione del logo della squadra stessa con le iniziali del produttore bresciano. «Effettivamente tra Superbowl e 49ers c’era una certa continuità dettata dalla mia passione per il football americano» rivela oggi Bortolotti. «Dopo un lungo viaggio negli Stati Uniti dell’Ovest, tornai talmente entusiasta per le prodezze di Joe Montana, quarterback dei San Francisco 49ers originario di Brescia e coi parenti che vivevano poco distanti dalla casa dei miei genitori, da dedicare un disco al Super Bowl. La mia passione per il football americano non si spense in tempi brevi, continuai a seguire per anni le avventure dei San Francisco 49ers e quando possibile, durante i miei viaggi negli States, cercavo di non mancare mai alle loro partite. Quando scoprii l’origine del nome della squadra, che rimandava ai cercatori d’oro del ’49 del secolo precedente, pensai di adottarlo per un nuovo progetto. Immaginando che una grande hit discografica fosse la mia miniera d’oro, ne auspicai lo stesso vantaggio». “Die Walküre”, assemblato insieme a Pierre Feroldi, mescola parecchi sample presi da brani più o meno noti, come “I.O.U.” dei Freeez e “Papa’s Got A Brand New Pigbag” dei Pigbag, e viene pubblicato in numerosi Paesi, anche extraeuropei. Tra i risultati più esaltanti l’ingresso nella top 20 dei singoli in Francia. «Effettivamente lì funzionò particolarmente bene ma lo licenziammo, più o meno, in tutto il mondo. L’house music stava esplodendo. Da sempre feroce ascoltatore di musica classica ed opera, presi in prestito il titolo in lingua tedesca da uno dei quattro drammi di Richard Wagner di cui ammiravo lo stile innovativo, sempre orientato al nuovo e all’eccezione. Sentendomi in qualche modo (ovviamente con le super dovute distanze e rispetto!) come Wagner, per l’innovazione che sostenevo con la house music, “Die Walküre” mi sembrò il titolo più adatto allo scopo». A supporto del brano viene girato un videoclip in cui l’immagine del gruppo è rappresentata da Josy Gil Persia, che però non copre alcun ruolo all’interno del progetto. «All’inizio dell’avventura eravamo ancora impreparati nella ricerca del talento e, come avveniva solitamente negli anni Ottanta, “usammo” anche noi una artista col solo scopo di sostenere la canzone in un video. Qualche anno dopo iniziai a scommettere sui DJ con la Heartbeat, strategia per supplire alla mancanza di rockstar nel territorio della musica da discoteca» conclude Bortolotti. La storia dei 49ers prosegue l’anno seguente con “Shadows” e soprattutto “Touch Me”, dove elementi dell’omonimo di Alisha Warren ne incrociano altri presi da “Rock-A-Lott” di Aretha Franklin e contribuiscono a rendere l’italo house un fenomeno d’esportazione, insieme a gruppi come Black Box, FPI Project, Double Dee e Sueño Latino. Sarà la britannica Ann-Marie Smith, che sostituisce la temporanea presenza di Dawn Mitchell, a dare voce al resto della discografia e a rappresentare l’immagine del gruppo negli anni a venire, quando il successo sarà altalenante ma arricchito da un ricco parterre di blasonati remixer house tra cui Masters At Work, E-Smoove e Maurice Joshua.
 Abel Kare – Allalla (Out)
Abel Kare – Allalla (Out)
Roberto Zanetti, che brilla nel ruolo di interprete nel firmamento italodisco come Savage, è il Robyx che produce il pezzo in questione per la Out di Severo Lombardoni. La versione principale è la Afro-Acid Version che è una summa di influenze new beat ed house. All’interno l’artista sovrappone ritagli vocali e ritmici assemblandoli con la metodologia sdoganata dai britannici. In mezzo a varie citazioni (l’urlo di “Jesus Loves The Acid” di Ecstasy Club, un bassline che ricorda il riff di “It’s More Fun To Compute” dei Kraftwerk) piazza anche una pianata che strizza l’occhio a quella di “The Party” dei newyorkesi Kraze, brano che Zanetti coverizza proprio nello stesso anno per un’altra etichetta della Discomagic di Lombardoni, la Technology, firmandola Rubix. In parallelo incide “Me Gusta” nelle vesti di Raimunda Navarro, lasciandosi affiancare dalla cantante Paola Bonini (la Paula Evans di “Ciao”, 1989). Il tutto prodotto nel Casablanca Recording Studio a Massa Carrara, lì dove nasceranno le molteplici hit milionarie della sua DWA.
 Amadhouse – Shock Me Amadhouse (Memory Records)
Amadhouse – Shock Me Amadhouse (Memory Records)
Affiancato da Alessandro Cardini, Damiano Prosperi realizza questo brano per la Memory Records di Parma che riesce a licenziarlo in Svezia, Germania e Grecia. “Shock Me Amadhouse” è fondato su ingenui strimpellamenti sampledelici sequenziati su una linea di basso ispirata da “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders. Il titolo e l’alias sono un gioco fonetico che rimanda ad una delle più note sonate di Wolfgang Amadeus Mozart, il rondò “alla turca”, risuonato all’interno della traccia in uno smaccato “Bontempi style”.
 B.C. – Housebad (Soundtrack Record)
B.C. – Housebad (Soundtrack Record)
“Housebad” è una traccia che nella sua essenzialità rammenta molto la schematizzazione della house prima maniera di Chicago, con quell’asciutto minimalismo tra ritmi programmati con drum machine ed il virtuoso basso funzionale nei club. Un altro rimando alla house d’oltreoceano pare rimarcato pure dal titolo di una delle due versioni, Bam Bam, omonima del Bam Bam (Chris Westbrook) della Westbrook Records. Non mancano ovviamente dei sample tra cui quelli di “Bad Girls” di Donna Summer e “Le Freak” degli Chic. Ad assemblare il tutto sono Andrea Baratella ed Orlando Bragante che per la loro prima esperienza discografica decidono, come si è soliti fare allora, di inglesizzare i loro nomi in Andrew Bratley e Roland Brant. «Tradurre in inglese i nostri riferimenti anagrafici servì sia a dare una parvenza estera al prodotto, sia ad evitare di “bollinare” tutti i dischi col marchio SIAE, giacché ai tempi i vinili provenienti dall’estero erano esenti da tale procedura» rivela oggi Bragante. «La Soundtrack Record, di mia esclusiva proprietà, fu la prima etichetta che creai, nata esclusivamente per la produzione di musica dance appartenente al cosiddetto circuito di “tendenza”. La utilizzai per una decina di produzioni e rimase attiva per soli tre anni. Registrammo “Housebad” con un otto piste della Fostex e lo masterizzammo sul classico Revox a due piste. I suoni provenivano da un Roland JX-8P, un Ensoniq Mirage (il primo campionatore disponibile sul mercato ad un prezzo abbordabile) ed una Yamaha DX7. A questi si aggiunsero due drum machine, una Roland TR-909 ed una Yamaha RX7. Il tutto pilotato da un sequencer Roland MSQ-700 fatta eccezione per la parte della RX7, non quantizzata ma suonata live tramite i pad e registrata su due tracce separate del Fostex per dare una maggiore sensazione di batteria reale. Il brano piacque molto ai DJ e venne suonato parecchio nei club ma ai tempi la house era un genere ancora di nicchia quindi non vendette molto, dalle duemila alle tremila copie circa. Poiché non riscosse il successo desiderato, decisi di abbandonare il progetto B.C. e dedicarmi ad altro: avevo già intrapreso il viaggio verso nuove “frontiere” nell’ambito dell’allora nascente techno». Bragante infatti si ritaglierà spazio nel corso degli anni Novanta con la musica dream/progressive, filone di cui diventa uno dei principali portabandiera.
 Beat Kick – Claro Que Si (Sunset)
Beat Kick – Claro Que Si (Sunset)
Con un piglio aggressivo quasi new beat, Luca Marci realizza “Claro Que Si” per la Sunset, etichetta affiliata alla Renata Edizioni Musicali di Parma di cui si è già parlato più sopra. Gli elementi che si rincorrono sono gli stessi che compaiono in praticamente tutte le produzioni house del periodo, beat in 4/4 usati come traino per un carico di sample carpiti, senza un filo conduttore ben preciso, da vari dischi noti (come “Situation” di Yazoo) e non, con l’aggiunta di melodie pianistiche appena abbozzate. La formula, chiaramente, non può garantire successo a tutti ma in tanti si buttano nella mischia tentando il grande salto.
 Co-Mix Featuring Y-10 – Relax (X-Energy Records)
Co-Mix Featuring Y-10 – Relax (X-Energy Records)
A metà strada tra eurodisco e il tipico “fare house” dei tempi, “Relax”, prodotta dai fratelli Paolo e Pietro Micioni, è la cover dell’omonimo dei Frankie Goes To Hollywood del 1983. Con la velocità aumentata rispetto all’originale e con l’aggiunta di una parte rappata realizzata dall’enigmatica Y-10 (un possibile rimando all’omonima automobile della Autobianchi, assai popolare in quel periodo?), il brano gira sulla linea del basso moroderiano carpito ad “I Feel Love” di Donna Summer a cui i fratelli romani intersecano una pianata e qualche velato rimando ad “High Energy” di Evelyn Thomas. A curare l’editing è Gino “Woody” Bianchi che oggi racconta: «In quel periodo lavoravo molto con la X-Energy Records, il mio ruolo principale era fare gli edit in post produzione nel piccolo studio che avevo allestito a casa, con un registratore Revox B77 ad alta velocità ed un paio di multieffetto. In pratica mi portavano i nastri con le registrazioni del pezzo ed io sceglievo le parti “ristesurando” e tagliando il nastro, creando in editing sezioni inesistenti sia su ritmiche che su bassi (un esempio di ciò che facevo lo si può sentire nella compilation “Garage Classics Volume 1”, uscita nel 1989 sempre su X-Energy Records e di cui è disponibile un estratto qui). Anche su Co-Mix il mio intervento avvenne in post production. L’inciso fu campionato paro paro mentre il rap venne registrato lento per poi essere ricampionato, velocizzato ed armonizzato con un effetto. A produrre il tutto furono i fratelli Micioni e il DJ Angelino. Il disco andò abbastanza bene, dai rendiconti appresi che vendette tremila copie, non male per una cover. Nel 1988 uscì pure “Graffiti House” di The Jam Machine (progetto nato l’anno prima e di cui abbiamo parlato più sopra, nda), un pezzo partorito da una mia idea mentre collaboravo con Giulio Ferrarin. Era uscito da poco “The Opera House” di Jack E Makossa e, da amante del sound di Arthur Baker, pensai di rifarmi a quello “schema” con altri sample stile anni Sessanta. Grazie alla bravura di Ferrarin realizzammo il brano in una notte appena. Poi dedicai un’altra giornata al mix e all’editing. Nel mondo discografico stava cambiando tutto radicalmente e velocemente. A tal proposito, un anno particolarmente importante fu il 1987: le ritmiche della LinnDrum e della Alesis HR-16 iniziarono a dare spazio a quelle della Roland e dei campionatori Akai ed E-mu Emulator, mentre i bassi divennero ripetitivi e molto gommosi. Si sviluppò forte interesse intorno ad etichette americane come D.J. International e Trax Records ma un ruolo decisivo lo svolse pure la prima house britannica tipo Yazz, Bomb The Bass e soprattutto la serie di campionamenti su S’Express. Da lì partirono le idee e si sperimentò inserendo il piano ispirato a “Going Back To My Roots” di Lamont Dozier che diede origine alla prima italo house. “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S., poi, fu un’assoluta genialata, credo sia stato il brano ad aver aperto la strada ad un sound europeo oltre a sdoganare un modo diverso di utilizzare le macchine (sample e drum machine). Ai tempi la house americana risultava troppo underground per le radio ma i britannici sfruttarono abilmente il concetto di “canzone” inserendolo nel sound house. Forse senza il movimento europeo (Gran Bretagna, Olanda, Italia) l’house music non avrebbe mai preso corpo in maniera consistente ed importante come è effettivamente avvenuto».
 Cutmaster-G & The Plastic Beats – Rock On! (DFC)
Cutmaster-G & The Plastic Beats – Rock On! (DFC)
“Rock On!” è l’unico brano (remix a parte) che Andrea Gemolotto firma come Cutmaster-G, nickname con cui ai tempi si fa largo ai campionati DMC. Autentico mosaico di scratch e campionamenti (tra cui l’assolo di chitarra rallentato di “Ain’t Talkin’ ‘Bout Love” dei Van Halen, ripreso tempo dopo dagli Apollo 440 in “Ain’t Talkin’ ‘Bout Dub”), il pezzo pare girare sulla base di “Beat Dis” di Bomb The Bass ed attinge il main vocal da “Rock Party/Smoke On The Water” dei Da Rock, un brano che circola parecchio negli ambienti del turntablism e che a sua volta seziona “Smoke On The Water” dei Deep Purple e dal quale qualche anno dopo il britannico Tinman estrarrà uno dei sample per la sua hit “Eighteen Strings”.
 Dalu – Do You Like House? (Memory Records)
Dalu – Do You Like House? (Memory Records)
La parmense Memory Records di Alessandro Zanni e del compianto Stefano Cundari continua a sondare il terreno della house con questo “Do You Like House?” prodotto dal citato Damiano Prosperi sul modello marrsiano, assemblando un alto numero di sample di estrazione eterogenea (incluso un frammento di “Don’t Let Me Be Misunderstood” dei Santa Esmeralda) sonori e vocali, farcendo il tutto con immancabili tastierate di pianoforte.
 DJ Atkins & Sharada House Gang – Let’s Down The House (Media Record)
DJ Atkins & Sharada House Gang – Let’s Down The House (Media Record)
Con “Let’s Down The House” Gianfranco Bortolotti rinnova la direzione stilistica di un progetto partito nel 1984 in seno all’italodisco, Paul Sharada. Al personaggio che presta voce ed immagine ai tempi di “Florida (Move Your Feet)”, “Dancing All The Night” o “Boxers”, Lamott Eugene Atkins (nel 1985 finito nel cast del film “Lui È Peggio Di Me” con Adriano Celentano e Renato Pozzetto) viene ora attribuito il ruolo di DJ. Il lavoro in studio è di Pieradis Rossini e Pierre Feroldi che realizzano due versioni, House Side ed Acid Side, nelle quali montano vari sample (tra cui quello di “Reach Up” di Toney Lee e quello di “Last Night A D.J. Saved My Life” degli Indeep) ed un basso di moroderiana memoria. Nonostante sia l’ennesimo dei pezzi col sampling in stile M.A.R.R.S., Bortolotti lo piazza comunque in tutta Europa, tra Paesi Bassi, Francia, Spagna, Germania, Portogallo e persino nel lontano Giappone. La storia di Sharada House Gang continuerà per i dieci anni successivi con successo alterno. Tra i vari singoli si ricordano “House Legend”, in stile Technotronic, “Life Is Life”, una sorta di cover di “Mary Had A Little Boy” degli Snap!, “It’s Gonna Be Alright”, cantata da Valerie Etienne dei Galliano, “Dancing Through The Night”, col featuring di Ann-Marie Smith dei 49ers, “Keep It Up”, con la voce di Zeitia Massiah, e “Gipsy Boy” a cui abbiamo dedicato un articolo qui.
 Don Pablo’s Animals – Ibiza (Meal Power)
Don Pablo’s Animals – Ibiza (Meal Power)
Ideato e sviluppato da Christian Hornbostel, “Ibiza” è il primo singolo del progetto Don Pablo’s Animals in cui l’autore mescola e sovrappone tutti gli elementi che in quel periodo portano ad incanalare automaticamente un brano nel calderone della house. Scratch, sample raccattati a mani basse da fonti di varia estrazione (tra cui Chic, James Brown, LNR e Run-DMC) senza ovviamente dimenticare inevitabili pianate. «Appena tornato da Ibiza, totalmente devastato per tutto quello che vidi e vissi – qualcosa di assolutamente rivoluzionario ed avanguardistico per l’epoca, sia dal punto di vista musicale che da quello della moda e del modo stesso di vivere -, pensai di dedicare all’Isla Blanca il disco» racconta oggi Hornbostel. «Lo realizzai al 90% con un campionatore Akai S1000 rubando, saccheggiando ed editando materiale musicale ben oltre il limite della legalità. Se ben ricordo, vendette diecimila copie, un risultato più che ottimo ai tempi per quel tipo di produzioni». “Ibiza” è il preludio di un successo ancora più grande, quello raccolto con “Venus” del 1989 con cui il terzetto della BHF Production (Paul Bisiach, Christian Hornbostel e Mauro Ferrucci) riprende l’omonimo degli Shocking Blue, rinverdito tre anni prima dalle Bananarama, e raggiunge l’ambito palco di Top Of The Pops, lì dove peraltro viene accolto a braccia aperte anche per “Moments In Soul” di J.T. And The Big Family a cui segue, qualche tempo dopo, “I Need You” di Nikita Warren che abbiamo analizzato qui nel dettaglio. «Credo sia necessario puntualizzare un aspetto cronologico importante riguardante i brand Don Pablo’s Animals e J.T. And The Big Family» dice Hornbostel. «Entrambi furono creati da me prima della nascita del team BHF ed inglobati in esso solo successivamente. L’ispirazione per i nomi venne da un famoso negozio padovano di dischi, al tempo di proprietà di Paolo ‘Don Pablo’ Turiaco e del figlio Giovanni. Da qui l’iniziale inglesizzata nella prima lettera, J.T., che stava appunto per il suo nome e cognome. Quasi tutti i DJ dell’epoca fissarono come punto di riferimento il Dischi Arcella, formando quella che loro stessi definirono una “grande famiglia” (Big Family appunto). Qualche anno più tardi, quando fondai la Shadow Productions con Mr. Marvin (di cui abbiamo parlato qui, nda), Giovanni Turiaco tornerà a collaborare con me nei progetti Hortuma (“The Fantastic Bongo Dream”, 1994) e Sacro Cosmico (“Yattosan”, 1995)». A supportare discograficamente “Ibiza” è la Meal Power del gruppo veronese S.A.I.F.A.M. che continua a sfruttare commercialmente il nome quando si trasforma in New Meal Power affidando svariati nuovi singoli di Don Pablo’s Animals (“Birmania”, “Dreadlock Holiday”, “Ganja Party”, “Walking In The Rain”, giusto per citarne alcuni) a produttori differenti. «Se da un lato c’era un’ingenuità positiva che rese possibili azioni folli e coraggiose nell’editing e nel campionamento, cosa comunque di moda ovunque in quel periodo, dall’altro quella stessa ingenuità generò una pessima gestione dei diritti dei cosiddetti “marchi di servizio”, e ciò avvenne da parte della maggioranza dei produttori di allora. È altresì vero che la Meal Power fece semplicemente e legittimamente il proprio interesse, anche perché non mostrammo più intenzione di produrre ancora musica con quel marchio o in quella direzione. Qualche mese più tardi infatti sarebbe partita l’avventura Interdance, sempre con Ferrucci e Bisiach e il contributo di altri produttori come Marco “Lys” Lisei e i fratelli Visnadi» conclude Hornbostel.
 El Chico – D.I.N.D.O.N.D.E.R.O. (Out)
El Chico – D.I.N.D.O.N.D.E.R.O. (Out)
“D.I.N.D.O.N.D.E.R.O.” è il primo disco che Marco Bresciani firma come El Chico. Supportato dalla Out di Severo Lombardoni, il noto DJ toscano realizza un autentico potpourri di sample in stile “Pump Up The Volume”, talmente serrato da sembrare più un megamix che un brano vero e proprio. Con la stesso piglio pochi mesi più tardi incide “House Party” a cui segue, nel 1989, “House Music Lovers”, in cui emerge chiaramente l’influenza di altri act italiani che raccolgono successo internazionale (49ers, Black Box, FPI Project). Bresciani, già coinvolto nel progetto italodisco Radiorama, torna a vestire i panni di El Chico per “Brisa Latina” del ’90, sui binari di una house ormai virata euro.
 Gino Latino – Welcome (Yo Productions) / Gino Latino – È L’ Amore (Time Records)
Gino Latino – Welcome (Yo Productions) / Gino Latino – È L’ Amore (Time Records)
A cimentarsi in una manciata di pezzi ammiccanti alla house post M.A.R.R.S. è pure un giovane Lorenzo Cherubini, prodotto da Claudio Cecchetto sulla sua Yo Productions: “Welcome” prima e “Yo” poi bazzicano suoni e ritmi che allora segnano una cesura dalla più classica italodisco, portando avanti un collage tra hip hop, funk, new beat ed hip house. Entrambi vengono licenziati all’estero (Gran Bretagna e Stati Uniti compresi, rispettivamente dalla blasonata FFRR e dalla Harbor Light Records) e sono firmati come Gino Latino, pseudonimo usato contemporaneamente da un artista “house friendly” di una casa discografica diversa, la Time Records di Giacomo Maiolini (per tutti i dettagli in merito si veda qui).
 Horn & Art – Action! (The Cock) (Meal Power)
Horn & Art – Action! (The Cock) (Meal Power)
Lasciata alle spalle l’esperienza nell’italodisco/rock dei Fard (“Chiamami Da Tokyo”, 1984, “Flash, Running Into The Night”, 1986, entrambi editi dalla EMI) , Christian Hornbostel approda alla house che, tra 1987 e 1988, inizia a scardinare le certezze che le compagnie discografiche ripongono ancora nella canonica “disco dance all’italiana”. «Per me il passaggio dall’italodisco alla house avvenne in modo molto naturale, conseguentemente allo sviluppo della musica da discoteca e alla mia attività da DJ» ricorda oggi Hornbostel. «Le prime “club edit” presenti sui dischi furono uno stimolo ed un’ispirazione molto forte per iniziare ad interpretare la produzione musicale in un modo inedito, con suoni ed arrangiamenti orientati verso il genere house, allora del tutto nuovo». “Action! (The Cock)”, prodotto insieme a Max Artusi (artefice, qualche anno più tardi, di “What’s Up” di DJ Miko), è una traccia-collage con cui i due si cimentano nel sampling assemblando funk e disco a matrici house, usando come collante sia un campione vocale di “Get Up Action!” degli olandesi Digital Emotion, sia il canto di un gallo, cinque anni prima rispetto ad “El Gallinero” di Ramirez. Ecco spiegata quindi la ragione del titolo. «A quel tempo ero spesso in studio da Artusi col quale lavoravo in una radio regionale. Lui era un esperto di campionatori (parliamo dell’era dell’Akai S1000) e un giorno mi fece sentire delle cose divertenti ed interessanti che stimolarono la mia curiosità goliardica in modo così determinante da mettermi subito a cercare qualcosa di sorprendente, un suono che potesse colpire con violenza l’attenzione dell’ascoltatore. Optai per il chicchirichì del gallo, ovviamente circondato con suoni house». Il 12″ esce sulla veronese Meal Power, la stessa che pubblica altri dischi di Hornbostel e dei suoi soci della BHF Production come “Ibiza” di Don Pablo’s Animals di cui si è parlato poche righe fa.
 House Force – Pig House (S.P.Q.R.)
House Force – Pig House (S.P.Q.R.)
Sebbene Discogs riporti il 1986 come data di pubblicazione, il disco in questione esce due anni più tardi su una delle tante etichette affiliate alla Best Record di Claudio Casalini. Lo stile anticipa gli stilemi che diventeranno classici dell’italo house, con assoli di piano in evidenza corredati da sample vocali. Autore è Giovanni Cinaglia, meglio noto come Cinols, che oggi racconta: «Cominciai a mettere i dischi nelle radio locali nel 1977. Il periodo storico era meraviglioso per funk e disco ma con l’avvento dell’elettronica, ad inizio degli anni Ottanta, la qualità e soprattutto la carica emozionale della dance cominciò a perdere colpi. Evidentemente questa sensazione si diffuse anche e soprattutto negli States tant’è che, già nel 1985, in alcune discoteche i DJ iniziarono a suonare musica “fatta in casa” con le drum machine della Roland. Il fenomeno prese piede velocemente e l’anno successivo uscirono tantissimi dischi house che fortunatamente arrivarono anche in Italia. Per me fu la svolta ma era ancora presto per proporre al pubblico un’intera serata di house music che vedrà la sua totale affermazione nel nostro Paese durante il 1987. Ad attrarre la mia attenzione furono specialmente DJ/produttori americani come Todd Terry, Ralphi Rosario, Marshall Jefferson, Farley Jackmaster Funk, Steve ‘Silk’ Hurley ma pure alcuni britannici come Coldcut e Simon Harris. In quel periodo diversi DJ nostrani si misero in gioco per produrre un disco. Nel 1988 volli provare pure io e così realizzai “Pig House”. Ai tempi non possedevo campionatori, sequencer e tastiere, avevo solamente una batteria elettronica Roland TR-909, quindi fui costretto ad affidarmi ad uno studio di registrazione esponendo le mie idee al tecnico di turno che fino al nostro incontro non aveva mai sentito parlare di house music. Non fu facile entrare in sintonia con lui. Insieme alla mia TR-909, ruolo di protagonista lo giocò l’Akai MPC60: oltre ad essere utilizzato come sequencer, ebbe la funzione di campionatore con cui elaborammo sample di batterie elettroniche, bassi e voci. Quelle femminili le registrammo in studio ma non rammento da dove fu estrapolato l’eins zwei drei vier. Per i suoni usammo un Roland D-50 e un paio di expander tra cui il Roland D-550. Era presente anche un bel Lexicon 480L, appena giunto sul mercato, destinato alla riverberazione. Il mixer invece era un Soundcraft di cui non ricordo più il modello. Per completare il pezzo impiegammo circa quindici giorni. Non so esattamente quante copie abbia venduto ma ricordo che riuscii ad andare quasi in pari con le spese sostenute per la sua realizzazione. Adottai come nome House Force per dare subito l’idea di cosa si trattasse ma da lì a breve, visto l’uso esasperato che si fece della parola “house”, decisi di abbandonarlo. Tutte le produzioni che seguirono a “Pig House” furono interamente prodotte presso lo studio che ho allestito alla fine del 1988 e che nel corso degli anni ha subito regolarmente cambiamenti ed aggiornamenti». Dal 1991 Cinols inizia a collaborare con la Media Records per cui produce diversi dischi tra cui “Divin’ In The Beat” degli East Side Beat, “Congo Bongo” di The African Juice, “The Only One” di Base Of Dreams e “Rock House Party” di Theorema.
 J.M.B.I. – Snoopy’s Count House (American Records)
J.M.B.I. – Snoopy’s Count House (American Records)
Dedicato alla nota discoteca modenese Snoopy Countdown a cui allude chiaramente il titolo e dove, pare, nei primi anni Settanta fece il suo debutto come DJ Vasco Rossi, il brano è l’ennesimo dei “figli” di “Pump Up The Volume”. Ad occuparsi degli arrangiamenti e degli scratch sono i disc jockey Max Gavioli ed Ivan Delisi mentre la produzione è affidata a Roberto Attarantato che pubblica il 12″ sulla sua American Records a cui abbiamo dedicato una monografia qui. Il tutto registrato presso il B.M.S. Recording Studio di Modena. Sembra che l’idea di partenza sia venuta a Filiberto Degani, ai tempi titolare del locale ed anni dopo coinvolto in guai giudiziari per il fallimento dello stesso come si può leggere qui. In circolazione ci sono almeno tre tirature con altrettante copertine, tutte dedicate all’indimenticata discoteca di Piazza Cittadella di cui si possono scorgere interessanti dettagli tra cui la consolle e parte degli esterni. Nonostante non sia diventato una hit, il brano viene licenziato in diversi Paesi esteri (Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Francia, Canada) e ciò alimenta l’entusiasmo degli autori che, facendo leva sui medesimi elementi, approntano altri due singoli, “Rat In The Movie’s House” e “Snoopy’s Makes 3° (Bloody Hell?)”.
 Kekkotronix – It’s Time To Relive (Top Line Productions)
Kekkotronix – It’s Time To Relive (Top Line Productions)
Edito dalla milanese Top Line Productions, “It’s Time To Relive” è un brano non propriamente ascrivibile alla house in senso stretto, seppur contenga alcuni elementi che ai tempi lo rendono appetibile per coloro che prediligono programmazioni inclini alla house con dilatazioni afro/baleariche. Le tre versioni sul 12″ derivano pressoché dallo stesso materiale ma è la Dangerous Version a rendere meglio l’idea del disegno stilistico effettuato da Kekkotronix ossia Francesco Montefiori, pare coadiuvato in studio da Claudio “Moz-Art” Rispoli. Entrambi vivranno da protagonisti la fase successiva della italo house, quando navigheranno a bordo di una moltitudine di progetti (Omniverse, Outphase, Soft House Company, Key Tronics Ensemble, Soft & Loud Music Enterprise, TFM, Jestofunk, Double Dee) supportati dalla bolognese Irma Records. La stessa etichetta pubblica un’altra manciata di dischi che Montefiori firma come Kekkotronics (e non più Kekkotronix) in coppia con Luca ‘LTJ’ Trevisi, “First Job” e “Gimme The Funk”.
 Koxo’ Club Band – Paradhouse (Di-Gei Music)
Koxo’ Club Band – Paradhouse (Di-Gei Music)
Registrato presso il B.M.S. Recording Studio e dedicato ad un altro storico locale del capoluogo emiliano, il Koxo’, “Paradhouse” è frutto del lavoro di un team di produzione in cui spiccano due nomi che si faranno ben notare negli anni Novanta, quelli di Lino Lodi e Stefano Mango (Face The Bass, Masoko, Pan Position, Express Of Sound etc). Gli elementi sono i soliti: pianate, bassline meccanico, campionamenti ed ovviamente un trascinante beat che però si ferma ai 110 BPM. Il brano è oggetto di diverse licenze in Germania, Spagna e Regno Unito, aiutato dal remix di Roberto ‘Bob One’ Attarantato che nel 1989 lo ristampa sulla sua American Records. Il singolo successivo, “Makes You Blind”, uscirà proprio sulla American Records. Il sample è tratto dall’omonimo della Glitter Band alternato a frammenti di celebri artisti e compositori (Michael Jackson, Mike Leander, Mory Kanté). Sul lato b trova spazio la pianistica “Drive House” coi sample vocali del paninaro di Drive In, Enzo Braschi.
 Ocean In Red – Relax In House (Many Records)
Ocean In Red – Relax In House (Many Records)
Arrangiato da Pasquale Scarfì che matura diverse esperienze discografiche sin dai primi anni Ottanta, “Relax In House” è il brano con cui due DJ dall’identità sconosciuta svuotano un calderone di campionamenti eterogenei su una base di house semplificata e ridotta a pochissimi elementi. Con squarci aperti verso classici pop/rock come “Relax” dei Frankie Goes To Hollywood, “Another One Bites The Dust” dei Queen ed “(I Can’t Get No) Satisfaction” dei Rolling Stones, la Many Records di Stefano Scalera inizia quindi ad esplorare la house music, prendendo parallelamente in licenza brani come “The Party” di Kraze e “Night Moves” di Rickster.
 Piero Fidelfatti – Baila Chico (Acid Version) (Out)
Piero Fidelfatti – Baila Chico (Acid Version) (Out)
DJ di lungo corso, Fidelfatti incide un megamix bootleg intitolato “Baila Chico Mix” sulla fittizia Easy Dance ideata per parodiare la newyorkese Easy Street. All’interno, tra gli altri, anche Mantronix, M.A.R.R.S. e J.M. Silk. L’ottimo riscontro lo spinge a realizzare anche un singolo, questa volta a suo nome, in scia a “Pump Up The Volume”. Il brano viene assemblato nel Palace Recording Studio di Andrea Gemolotto, ad Udine, e pubblicato dalla Out di Severo Lombardoni. Due le versioni, arrangiate col musicista/illustratore Franco Storchi e l’ingegnere del suono Fulvio Zafret: la Acid Version, che a dispetto del nome di acid non ha davvero nulla, allineata ai suoni di “The Party” di Kraze e “Jack To The Sound Of The Underground” del compianto Hithouse, e la Piano Version che prevedibilmente mette in evidenza assoli pianistici. Fidelfatti raccoglierà successo internazionale l’anno seguente con “Just Wanna Touch Me” di cui abbiamo parlato nel dettaglio qui.
 Raff Todesco – I Got My Mind (RA – RE Productions)
Raff Todesco – I Got My Mind (RA – RE Productions)
Produttore sin dalla fine degli anni Settanta, Raff Todesco vive in pieno sia l’exploit dell’italodisco, sia quello della house e dell’eurodance. “I Got My Mind”, edito sulla sua RA – RE Productions, è un omaggio/tributo al quasi omonimo degli Instant Funk, “I Got My Mind Made Up” del 1978, di cui vi è un sample all’interno insieme ad un frammento preso da “Hit It Run” dei Run-DMC, del 1986. Il resto è un susseguirsi ritmico affine a quel nuovo genere musicale che arriva dagli States e dalla Gran Bretagna, ben rimarcato dal nome di una delle tre versioni presenti sul 12″, Hause-Hause Version, oltre ad immancabili assoli di piano. «Verso la fine del 1987 le vendite delle produzioni italodisco cominciarono a non essere più soddisfacenti per chi, come me, frequentava il Sandy’s Recording Studio di Sandy Dian, a Gambellara, in provincia di Vicenza» racconta oggi Todesco. «Anche per coloro che avevano la fortuna di produrre in continuazione, lo storico studio della dance col mixer MCI 600 a 32 piste e con strumentazioni d’avanguardia iniziò a pesare non poco per gli elevati costi. Tuttavia a settembre del 1987 decisi di avviare lì un progetto musicalmente innovativo, sull’onda di ascolti maturati attraverso produzioni alternative rispetto alle cose che ero abituato a fare, come “Your Love” di Frankie Knuckles e le pubblicazioni sulla Trax Records. Non avevo ancora le idee chiare sulla strada da seguire musicalmente ma sentivo la necessità di abbandonare sia l’italodisco che l’eurodisco, fino ad allora i capisaldi del mio autorato, e cominciare una nuova avventura musicale e produttiva. Il primo risultato di quella svolta fu proprio “I Got My Mind”, realizzata col vecchio sistema analogico e senza ausilio del computer. Il progetto si fondava sul disegno strumentale creato con la tastiera su cui vennero inseriti vari campionamenti, “suonati” come se fossero uno strumento, attraverso la Korg DSS-1 grazie all’aiuto di Michele Paciulli, ai tempi dimostratore della stessa azienda. Il tema principale del piano invece, che doveva rappresentare un ideale volo nello spazio, fu eseguito con una Korg DW-8000 polifonica. Fu l’unico disco a portare il mio nome come artista sulla copertina e il mio ultimo lavoro ad essere registrato nello studio di Sandy Dian, tra la fine di settembre e i primi di ottobre del 1987. Lo avrei terminato e mixato in autunno inoltrato presso il Summit Studio. Per continuare l’attività da produttore infatti mi trasferii a Milano e in un nuovo studio, il citato Summit Studio di Antonio Summa, a Villa d’Almè, in provincia di Bergamo, i cui costi erano notevolmente inferiori rispetto a quello di Dian. Oltre a Summa, tecnico e bassista, lì conobbi anche il tastierista Sergio Bonzanni col quale avrei collaborato negli anni a seguire. Il Summit Studio era uno studio tradizionale che si poggiava ancora su tecnologia analogica ma in Italia praticamente nessuno, ai tempi, registrava in digitale. All’inizio del 1988 feci veramente una pazzia: tentai di sostituirmi al lavoro del DJ e costruii una song basata su soli campionamenti legati tra loro da una brevissima melodia strumentale. Si trattava di “Magnetic Dance” di T.V.M. (acronimo di Todesco Vaccari Maini), pubblicato dalla On The Road, etichetta che avevo creato qualche tempo prima proprio con Francesco Vaccari e Gigi Maini. Il brano si fondava su una ventina di campionamenti, i più rilevanti erano tratti dal film “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick e da un brano dei Jackson 5, che emergevano più volte durante la stesura. Nonostante le buone vendite, per fortuna non avemmo conseguenze legali. A posteriori la considero una vera follia aver inciso un disco con sample di quel tipo senza regolari autorizzazioni! Nel 1988 uscirono anche “Foot Stompin’ Music / Funnyhouse”, ancora insieme a Vaccari e Maini, ed “I Am” dei Time, un nome risorto dai periodi più rosei della italodisco (quelli di “Can’t You Feel It”, di cui abbiamo parlato qui, nda). In quel caso presi a modello “No UFO’s” di Model 500: usai la Roland TR-808 per la drum e Summa incise il basso col suo Fender Precision. La voce invece era di Eleonor, una cantante di un gruppo rock, e non mancavano vari campionamenti, scratch e clap così come voleva la tipologia house di allora. La melodia però era tipica del modello disco, imprinting della nostra italica memoria musicale. Soltanto alla fine del 1989 incominciai, nel nuovo studio allestito da Sergio Bonzanni, le produzioni digitali con la tecnologia computeristica».
 Rhythm Station – Let’s Clean Up The Ghetto (Technology)
Rhythm Station – Let’s Clean Up The Ghetto (Technology)
Cover dell’omonimo dei Philadelphia International All Stars, il brano in questione viene approntato nel Lumiere Studio di Milano dai componenti della Big Business Orchestra (tra cui si cela il poliedrico Fred Ventura) che nello stesso anno incidono “Big Business”. Nel 1990 nei negozi arriva il secondo singolo, “Don’t Stop”, registrato presso il Gian Burrasca Studio di Marcello Catalano. Il tutto supportato da Severo Lombardoni.
 Risen From The Rank – Sampler ’83 (Media Record)
Risen From The Rank – Sampler ’83 (Media Record)
Nato nel 1985 con “AIDS” (la cui base viene riadattata per “America” due anni dopo), Risen From The Rank è uno dei tanti progetti scaturiti dalla fervida immaginazione di Gianfranco Bortolotti. Sull’onda di “Bauhaus” di Cappella e “Die Walküre” dei 49ers, di cui si è già detto più sopra, l’imprenditore bresciano pubblica “Sampler ’83”, altro collage di sample in stile “Pump Up The Volume”, in cui spiccano frammenti di “Last Night A DJ Saved My Life” degli Indeep, ma con meno potenzialità commerciali. «Era uno dei brani che facevano parte, insieme ai menzionati Cappella e 49ers, alle prime esperienze della house music, del campionamento, dell’organizzazione di una nuova metodologia di lavoro nei nuovi home studio che mi inventai e che poi furono perfezionati e copiati in tutto il mondo. Un gradino che ci avrebbe portato in cielo, proiettati verso il successo mondiale» dice oggi Bortolotti. «Seppur molto simile a “Bauhaus”, le vendite furono inferiori ma lo scopo non era eguagliare i risultati economici bensì testare nelle discoteche prodotti di quel tipo e cercare la formula giusta per il nuovo Cappella». Sempre nel 1988 esce “Ecstasy”, prodotto da Pieradis Rossini e Pierre Feroldi, poi diventato “Fantasy” per il mercato estero. «Non volevamo correre il rischio di farlo passare per un’incitazione all’uso della nota droga sintetica. Per noi era un semplice sample e chi mi conosce sa che non ho mai fatto uso di droghe e questo posso giurarlo» conclude Bortolotti. Dal 1990 Risen From The Rank riapparirà solo con l’acronimo R.F.T.R. attraverso vari singoli in bilico tra suoni techno ed house, tra cui “I Need A Fix” (col featuring di Simone Baldo, pochi anni dopo coinvolto nel progetto televisivo TSD) e “Rock Oops”, entrambi prodotti a Padova negli studi della Prisma Records da Valter Cremonini e dal team che da lì a breve crea gli U.S.U.R.A. di “Open Your Mind”. Meritevole di citazione anche il più fortunato “Extrasyn”, arrangiato da Max Persona con la consulenza artistica di Francesco Zappalà.
 Rusty – Rusty Acid (Dance And Waves)
Rusty – Rusty Acid (Dance And Waves)
Mentre esplodono in Giappone come Green Olives con “Jive Into The Night” agganciato agli stereotipi stilistici eurodisco/hi NRG, David Sion, Fulvio Zafret e Sergio Portaluri iniziano a tastare il terreno della house sia come Big House e il poco noto “Don’t Stop The Party”, sia come Rusty, pseudonimo con cui firmano “Rusty Acid”. Il brano raccoglie gli input dei tipici collage sampledelici, con brevi passaggi vocali alternati a qualche melodia bleepy e ai graffi degli scratch, vero leimotiv del DJismo di quel periodo. A pubblicarlo è la Dance And Waves del gruppo bolognese Expanded Music. Più fortunato risulta il singolo seguente, “Everything’s Gonna Change”, edito dalla DFC nel 1989 e licenziato oltremanica dalla Stress Records di Dave Seaman che affida il remix ad una figura chiave della progressive house britannica degli anni Novanta, Sasha. Da lì a poco Sion, Zafret e Portaluri creano il team di produzione De Point con cui mettono a segno diversi successi come “Your Love Is Crazy” di Albertino (a cui abbiamo dedicato un articolo qui) ma soprattutto i brani con cui Afrika Bambaataa aderisce, inaspettatamente e per molti inspiegabilmente, all’italodance, “Just Get Up And Dance”, “Feeling Irie”, “Pupunanny” e “Feel The Vibe”.
 Surprise – 7.6.5.4.3.2.1 (Blow Your Whistle) (X-Energy Records)
Surprise – 7.6.5.4.3.2.1 (Blow Your Whistle) (X-Energy Records)
A metà strada tra l’italodisco virata pop/hi NRG e scorci house, il disco riporta in vita l’omonimo dei Gary Toms Empire del 1975. Artefice è Giulio Ferrarin, che qualche anno più tardi fonda la MKS Records, affiancato da Gino “Woody” Bianchi. Maggiormente aderente all’universo house è la traccia incisa sul lato b, “Don’t Stop The Music”. A chiarirlo è il nome stesso della versione, Acid House Mix. «A proporci di coverizzare il brano dei Gary Toms Empire (già rifatto con successo dai Rimshots) fu Alvaro Ugolini, uno dei proprietari della X-Energy Records, e devo ammettere che ci divertimmo molto a realizzarlo. Utilizzammo un piano della Roland ma per poter guadagnare sui diritti d’autore dovevamo produrre una traccia inedita e quindi pensammo di aggiungere qualcosa in stile Trax Records. Prendendo spunto da “Are You Ready” di Rich Martinez e “Don’t Stop The Music” dei Bay City Rollers, un classico per il pubblico della Baia Degli Angeli, il gioco era fatto. Dopo un paio di whisky il chitarrista Marco Scainetti si lanciò a cantare il brano e in appena due giorni completammo il tutto. La X-Energy Records investì molto nei progetti italo house e dopo poco tempo mi avrebbe affidato il remix/rework di “Notice Me” di Sandee. Da lì a breve, inoltre, fui invitato in studio dai cugini Minoia e da Corrado Rizza (mio futuro socio nella Lemon Records/Wax Production) per remixare “Satisfy Your Dream” di Paradise Orchestra ed “Everyday” di The Jam Machine, usciti entrambi nel 1989 e che, a mio avviso, hanno scritto la storia della italo house».
 The Hardsonic Bottoms 3 – Do It Anyway You Wanna (BBAT)
The Hardsonic Bottoms 3 – Do It Anyway You Wanna (BBAT)
Nati da una costola dei Pankow, gruppo fiorentino che aderisce al movimento industrial, gli Hardsonic Bottoms 3 debuttano col singolo “Do It Anyway You Wanna” che, è bene chiarirlo, non è propriamente house bensì un mix tra EBM e new beat, generi che in quel periodo iniziano però ad essere riadattati dai produttori house europei vista la loro spiccata ballabilità. Tra ’89 e ’90 escono altri due 12″, “Disco Inferno” e la doppia a-side “Jailhouse Shock / Stompxnxtorr” che chiude la breve parentesi danzereccia di Maurizio Fasolo, Enzo Regi e Sergio Pani, supportata discograficamente dalla BBAT, sublabel della Contempo Records.
Considerazioni finali
Sono ormai trascorsi più di trent’anni da quando la house music ha messo piede in Italia. Quello che era un foglio bianco, tutto da scrivere, adesso è diventato un libro, con molteplici capitoli ricchissimi di avvenimenti, nomi, passioni, vite e, purtroppo, anche morti. La house è diventata la colonna sonora di intere generazioni dando vita ad una visione “house-centrica” della musica da ballo. L’housecentrismo come nucleo da cui irradiare idee, soluzioni, intuizioni, emozioni. Per alcuni i primi dischi house prodotti in Italia svilirono pesantemente la sacralità della stessa house music, profanandola e minandone la credibilità con un approccio tipicamente consumistico tanto da restare ai margini della conoscenza collettiva e scarsamente considerati. Per altri invece quelle produzioni, molto spesso dai caratteri oggettivamente naïf, servirono eccome perché gettarono le basi per lo sviluppo della personalizzazione del genere, giunta nel 1989 quando si delineano i caratteri somatici intrinsechi dell’italo house che emerge con forza facendosi notare pure in quei mercati sino a poco prima apparentemente inavvicinabili, come il britannico e lo statunitense. L’Italia avrebbe mostrato i muscoli dimostrando al mondo intero di avere voce in capitolo. Ma questa è un’altra storia.
Giosuè Impellizzeri
* le testimonianze esclusive di questo reportage sono state raccolte tra novembre 2018 ed aprile 2019.
© Riproduzione riservata


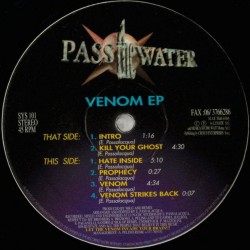


























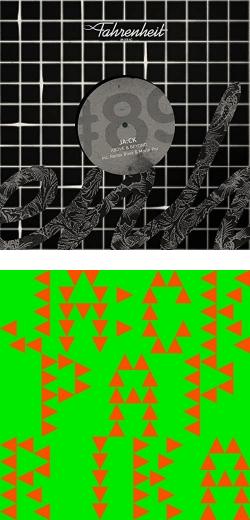
 Si dice che nessuno, nella musica, abbia inventato qualcosa dal nulla, perché in qualche modo tutto deriva da elementi preesistenti. Vale anche per la trance che nei suoi primi anni di vita è una sorta di ambient “groovizzato”, provvisto di ritmo ballabile importato dalle neonate techno ed house. Tra i giovani che aderiscono presto a quel fermento musicale, localizzato in primis nell’Europa centrale, c’è il berlinese Rolf Maier-Bode, classe ’74, che oggi racconta: «Ho scoperto la musica elettronica attraverso i primi dischi di Vangelis e Jean-Michel Jarre, a colpirmi in modo particolare furono le melodie e le armonie che li contraddistinguevano. Ad attirarmi però erano pure i suoni di sintetizzatore nei primi due album di Jarre, che riascolto con piacere ancora adesso. A ciò si sommava ovviamente tutto il campionario pop e rock anni Ottanta consumato durante il periodo dell’adolescenza. Tra i miei preferiti, quando ero appena tredicenne, c’era persino Bruce Springsteen. In quegli anni cominciai a suonare il pianoforte ma odiavo andare a lezione di musica classica. Preferivo di gran lunga i pezzi di Vangelis, Jarre e Tangerine Dream e scoprii che si potesse comporre attraverso il Commodore 64. Avevo quindici anni e desideravo fare musica nuova a tutti gli effetti evitando ciò che veniva solitamente trasmesso dalle radio. Una notte ho sentito il DJ set di WestBam presso la festa itinerante Macht Der Nacht (per approfondire si rimanda a
Si dice che nessuno, nella musica, abbia inventato qualcosa dal nulla, perché in qualche modo tutto deriva da elementi preesistenti. Vale anche per la trance che nei suoi primi anni di vita è una sorta di ambient “groovizzato”, provvisto di ritmo ballabile importato dalle neonate techno ed house. Tra i giovani che aderiscono presto a quel fermento musicale, localizzato in primis nell’Europa centrale, c’è il berlinese Rolf Maier-Bode, classe ’74, che oggi racconta: «Ho scoperto la musica elettronica attraverso i primi dischi di Vangelis e Jean-Michel Jarre, a colpirmi in modo particolare furono le melodie e le armonie che li contraddistinguevano. Ad attirarmi però erano pure i suoni di sintetizzatore nei primi due album di Jarre, che riascolto con piacere ancora adesso. A ciò si sommava ovviamente tutto il campionario pop e rock anni Ottanta consumato durante il periodo dell’adolescenza. Tra i miei preferiti, quando ero appena tredicenne, c’era persino Bruce Springsteen. In quegli anni cominciai a suonare il pianoforte ma odiavo andare a lezione di musica classica. Preferivo di gran lunga i pezzi di Vangelis, Jarre e Tangerine Dream e scoprii che si potesse comporre attraverso il Commodore 64. Avevo quindici anni e desideravo fare musica nuova a tutti gli effetti evitando ciò che veniva solitamente trasmesso dalle radio. Una notte ho sentito il DJ set di WestBam presso la festa itinerante Macht Der Nacht (per approfondire si rimanda a 

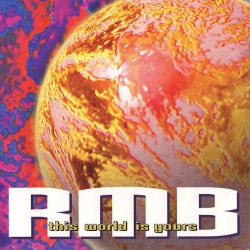
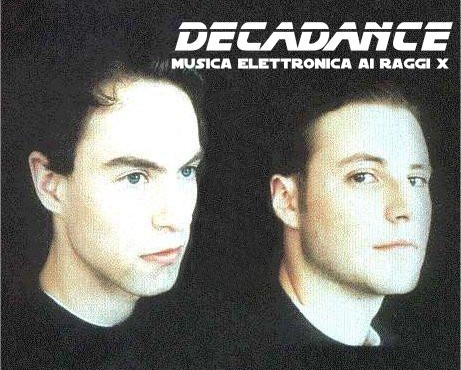
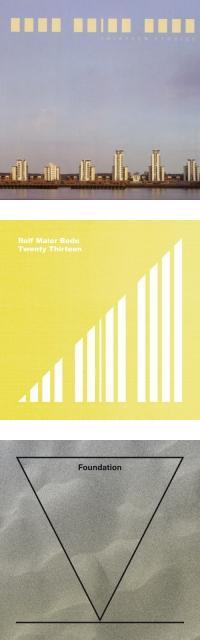
 Negli anni Ottanta e in buona parte dei Novanta comporre musica dance non è, come oggi, un “affare” quasi esclusivamente relegato ai DJ o perlomeno non si tratta di un’attività praticabile in forma autonoma dai disc jockey. Se da un lato gioca a svantaggio il costo ancora piuttosto proibitivo delle strumentazioni necessarie per allestire uno studio di registrazione, dall’altro vi è un limite di tipo compositivo perché non esiste ancora una totale indipendenza creativa, sviluppatasi contestualmente alla nascita di equipment più intuitivi per chi non sa leggere lo spartito e non possiede alcuna formazione teorica. I DJ lanciano idee e suggerimenti, talvolta anche determinanti, ma necessitano ancora spesso della presenza di arrangiatori, ingegneri del suono e musicisti per tradurre compiutamente le proprie suggestioni in brani pubblicabili.
Negli anni Ottanta e in buona parte dei Novanta comporre musica dance non è, come oggi, un “affare” quasi esclusivamente relegato ai DJ o perlomeno non si tratta di un’attività praticabile in forma autonoma dai disc jockey. Se da un lato gioca a svantaggio il costo ancora piuttosto proibitivo delle strumentazioni necessarie per allestire uno studio di registrazione, dall’altro vi è un limite di tipo compositivo perché non esiste ancora una totale indipendenza creativa, sviluppatasi contestualmente alla nascita di equipment più intuitivi per chi non sa leggere lo spartito e non possiede alcuna formazione teorica. I DJ lanciano idee e suggerimenti, talvolta anche determinanti, ma necessitano ancora spesso della presenza di arrangiatori, ingegneri del suono e musicisti per tradurre compiutamente le proprie suggestioni in brani pubblicabili.




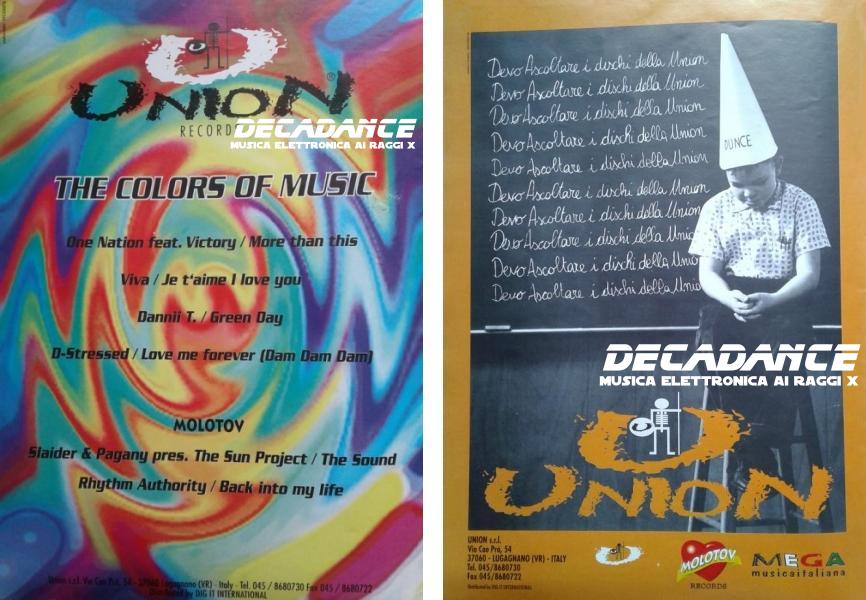


 Cervia, 1978. Bruno Magnani e Davide Piatto fondano i N.O.I.A., uno dei primi gruppi italiani a rivelarsi come punto di incontro e vicendevole scambio tra meccanicismo sintetico e vocalità new wave, capace di generare un suono-meticciato tra Kraftwerk e Devo. Insieme a loro, sino al 1983, quando la band è tendenzialmente attiva solo sul fronte live, ci sono Giorgio Giannini, Jacopo Bianchetti e Giorgio Facciani, ma nel momento in cui Oderso Rubini li mette sotto contratto con l’Italian Records cambia tutto. La propensione ad esibirsi dal vivo viene meno, sostituita dal lavoro in studio. La musica dei Talking Heads, Ultravox, Can e Neu! forgia il gusto dei romagnoli che si spingono avanti sino a lambire sponde no wave e proto house.
Cervia, 1978. Bruno Magnani e Davide Piatto fondano i N.O.I.A., uno dei primi gruppi italiani a rivelarsi come punto di incontro e vicendevole scambio tra meccanicismo sintetico e vocalità new wave, capace di generare un suono-meticciato tra Kraftwerk e Devo. Insieme a loro, sino al 1983, quando la band è tendenzialmente attiva solo sul fronte live, ci sono Giorgio Giannini, Jacopo Bianchetti e Giorgio Facciani, ma nel momento in cui Oderso Rubini li mette sotto contratto con l’Italian Records cambia tutto. La propensione ad esibirsi dal vivo viene meno, sostituita dal lavoro in studio. La musica dei Talking Heads, Ultravox, Can e Neu! forgia il gusto dei romagnoli che si spingono avanti sino a lambire sponde no wave e proto house.






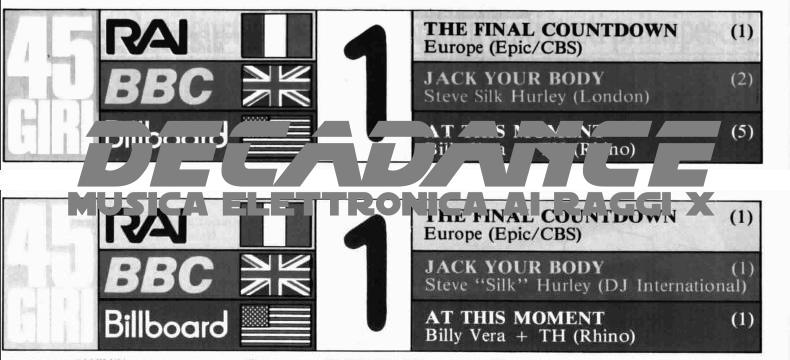














 Alexander Robotnick – C’est La Vie (Fuzz Dance)
Alexander Robotnick – C’est La Vie (Fuzz Dance) Cappella – Bauhaus (Media Record)
Cappella – Bauhaus (Media Record) DJ Lelewel – House Machine (Renata Edizioni Musicali)
DJ Lelewel – House Machine (Renata Edizioni Musicali) DJ System – Animal House (Discomagic Records)
DJ System – Animal House (Discomagic Records) Fun Fun – Gimme Some Loving (House Mix) (X-Energy Records)
Fun Fun – Gimme Some Loving (House Mix) (X-Energy Records) Glance – Turas / Open Legs (Les Folies Records)
Glance – Turas / Open Legs (Les Folies Records) L.A.N.D.R.O. & Co. – Get Up, Get On Up (New Music International)
L.A.N.D.R.O. & Co. – Get Up, Get On Up (New Music International) MBO – M.B.O. Liverpool Theme (Limited Edition Records)
MBO – M.B.O. Liverpool Theme (Limited Edition Records) Midas – One O One (DFC)
Midas – One O One (DFC) P/P/G – Jack The Beat (DFC)
P/P/G – Jack The Beat (DFC) The Jam Machine – Funky (Let’s Go) (X-Energy Records)
The Jam Machine – Funky (Let’s Go) (X-Energy Records) Yagmur – Ali Baba (DFC)
Yagmur – Ali Baba (DFC) 49ers – Die Walküre (Media Record)
49ers – Die Walküre (Media Record) Abel Kare – Allalla (Out)
Abel Kare – Allalla (Out) Amadhouse – Shock Me Amadhouse (Memory Records)
Amadhouse – Shock Me Amadhouse (Memory Records) B.C. – Housebad (Soundtrack Record)
B.C. – Housebad (Soundtrack Record) Beat Kick – Claro Que Si (Sunset)
Beat Kick – Claro Que Si (Sunset) Co-Mix Featuring Y-10 – Relax (X-Energy Records)
Co-Mix Featuring Y-10 – Relax (X-Energy Records) Cutmaster-G & The Plastic Beats – Rock On! (DFC)
Cutmaster-G & The Plastic Beats – Rock On! (DFC) Dalu – Do You Like House? (Memory Records)
Dalu – Do You Like House? (Memory Records) DJ Atkins & Sharada House Gang – Let’s Down The House (Media Record)
DJ Atkins & Sharada House Gang – Let’s Down The House (Media Record) Don Pablo’s Animals – Ibiza (Meal Power)
Don Pablo’s Animals – Ibiza (Meal Power) El Chico – D.I.N.D.O.N.D.E.R.O. (Out)
El Chico – D.I.N.D.O.N.D.E.R.O. (Out) Gino Latino – Welcome (Yo Productions) / Gino Latino – È L’ Amore (Time Records)
Gino Latino – Welcome (Yo Productions) / Gino Latino – È L’ Amore (Time Records) Horn & Art – Action! (The Cock) (Meal Power)
Horn & Art – Action! (The Cock) (Meal Power) House Force – Pig House (S.P.Q.R.)
House Force – Pig House (S.P.Q.R.) J.M.B.I. – Snoopy’s Count House (American Records)
J.M.B.I. – Snoopy’s Count House (American Records) Kekkotronix – It’s Time To Relive (Top Line Productions)
Kekkotronix – It’s Time To Relive (Top Line Productions) Koxo’ Club Band – Paradhouse (Di-Gei Music)
Koxo’ Club Band – Paradhouse (Di-Gei Music) Ocean In Red – Relax In House (Many Records)
Ocean In Red – Relax In House (Many Records) Piero Fidelfatti – Baila Chico (Acid Version) (Out)
Piero Fidelfatti – Baila Chico (Acid Version) (Out) Raff Todesco – I Got My Mind (RA – RE Productions)
Raff Todesco – I Got My Mind (RA – RE Productions) Rhythm Station – Let’s Clean Up The Ghetto (Technology)
Rhythm Station – Let’s Clean Up The Ghetto (Technology) Risen From The Rank – Sampler ’83 (Media Record)
Risen From The Rank – Sampler ’83 (Media Record) Rusty – Rusty Acid (Dance And Waves)
Rusty – Rusty Acid (Dance And Waves) Surprise – 7.6.5.4.3.2.1 (Blow Your Whistle) (X-Energy Records)
Surprise – 7.6.5.4.3.2.1 (Blow Your Whistle) (X-Energy Records) The Hardsonic Bottoms 3 – Do It Anyway You Wanna (BBAT)
The Hardsonic Bottoms 3 – Do It Anyway You Wanna (BBAT) Nell’autunno del 1995 il successo della
Nell’autunno del 1995 il successo della 




 1982: nei cinema arrivano “E.T. l’extraterrestre” e “Blade Runner”, muoiono il pilota di Formula 1 Gilles Villeneuve e la principessa Grace Kelly, viene lanciato il Commodore 64, la nazionale di calcio italiana vince i Mondiali in Spagna, in una fabbrica della Philips viene prodotto il primo Compact Disc. In ambito musicale l’AIDS uccide Patrick Cowley, gli ABBA si sciolgono ed esce “Thriller” di Michael Jackson. Restringendo il campo alla sola Italia e alla “musica da ballo”, sul mercato giunge un disco destinato a lasciare il segno,
1982: nei cinema arrivano “E.T. l’extraterrestre” e “Blade Runner”, muoiono il pilota di Formula 1 Gilles Villeneuve e la principessa Grace Kelly, viene lanciato il Commodore 64, la nazionale di calcio italiana vince i Mondiali in Spagna, in una fabbrica della Philips viene prodotto il primo Compact Disc. In ambito musicale l’AIDS uccide Patrick Cowley, gli ABBA si sciolgono ed esce “Thriller” di Michael Jackson. Restringendo il campo alla sola Italia e alla “musica da ballo”, sul mercato giunge un disco destinato a lasciare il segno, 





